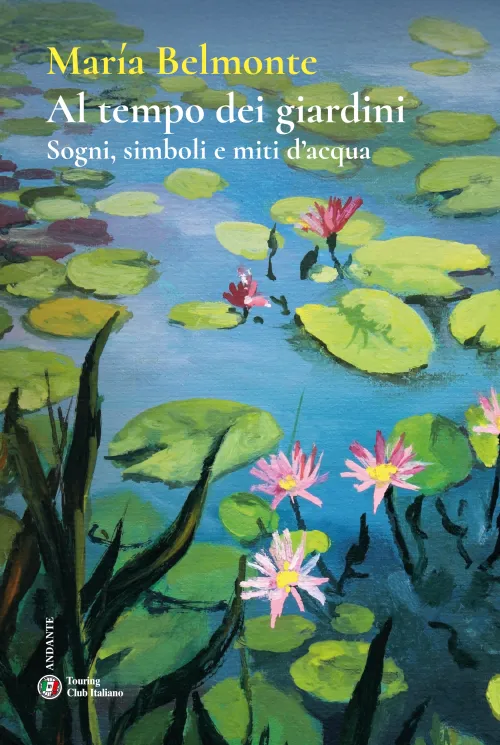La vita dell'acqua
“Chiare, fresche et dolci acque”. Con il suono piano, dolce e cadenzato di questo verso inizia a zampillare, come da una sorgente candida e semplice, la musica di uno dei testi più celebri del Canzoniere di Petrarca. Dove le lettere, i silenzi e i sospiri tra le parole sembrano quasi solo un pretesto per evocare e imitare quella misteriosa musica dell’acqua; quel ritmo e quella luce diafana e piena che solo le sorgenti, le fontane e i giochi d’acqua nei giardini estivi sanno custodire. È questa eterea presenza, sfuggente e allo stesso tempo così chiara e viva, il contenuto autentico del libro di Marìa Belmonte (Al tempo dei giardini. Sogni, simboli e miti d’acqua, Touring Club Italiano, p. 183). Malgrado a un primo sguardo possa sembrare che l’oggetto del libro consista semplicemente nel racconto dei topoi classici legati all’arte dei giardini e gli incanti suscitati dalle molteplici forme simboliche che l’elemento acqueo ha assunto nei secoli, l’autrice sembra aver di mira qualcosa di più profondo, da un lato, e di più preciso, dall’altro.
Già nel titolo, infatti, soprattutto nella sua formulazione in lingua originale, El murmullo del agua. Fuentes, jardines y divinidades acuáticas, si dichiara apertamente la volontà di tentare di afferrare l’incanto di un fenomeno così semplice e naturale, ma al tempo stesso così profondo ed enigmatico: il mormorio pullulante della sorgente, il gorgoglio fecondo della fonte, emblema e mito di una vita sempre verde, sempre viva. E sebbene il libro tracci un percorso storico, ricco anche di riferimenti eruditi, attorno alle trasformazioni che il significato e l’esperienza dell’acqua hanno subito nel corso dei secoli, dai miti metamorfici dell’antichità classica fino alle evoluzioni acquatiche delle fontane nei giardini delle ville barocche, è evidente fin dalle prime pagine che tutto ciò sia interamente al servizio di un altro scopo, più personale, da un lato, più universale, dall’altro. Documentare nel dettaglio le innumerevoli forme che l’acqua ha assunto nella cultura umana sembra quasi il pretesto per raccontare una vita intera spesa sulle tracce di quei luoghi verdeggianti che custodiscono la vita dell’acqua. Il fil rouge che accomuna attraverso i secoli giardini, fontane, sorgenti lontanissime e diversissime tra loro, o addirittura ignote ai più, è non solo la vita dell’acqua che le anima, ma soprattutto la vita e il racconto autobiografico dell’autrice. Perché da quelle acque, da quella ricerca si ritrova essa stessa animata.
Dalla mistica fonte di Villa Pliniana, così cara all’autrice, ai giardini onirici di Polifilo, ogni ritrovamento di un locus amoenus si intreccia al vissuto personale, è un incontro vis à vis: “ho spesso l’impressione di scrivere libri per visitare certi luoghi e conoscere certi personaggi, imparare tutto su di loro e poi divertirmi a raccontarli con dovizia di dettagli”. Il libro così, piuttosto che semplicemente presentare con acribia miti, divinità e leggende dell’acqua, si presenta davvero come un viaggio di scoperta, come un’esperienza (Erfahrung) autentica dei luoghi. Come ammette l’autrice stessa: “la scrittura di questo libro mi ha fornito la scusa perfetta per fare una delle cose che amo di più: visitare i giardini” (p.102). E non a caso il giardino è quel luogo prediletto – come insegnava Rosario Assunto – affinché il reale concreto incontri l’ideale astratto, e il destino personale si trovi faccia a faccia con l’universale. Visitando un giardino è possibile fare un’esperienza unica: immergere il proprio corpo temporale, singolare, all’interno di un luogo pervaso da un anelito di perfezione, che là pare finalmente raggiungibile, cristallizzata al di là del tempo, in una pace universale. “Ficino sosteneva che era la bellezza dei giardini a evocare nella mente dell’uomo l’esistenza di una bellezza ancora più perfetta, spingendolo ad anelarne la scoperta” (p.86).

Il giardino è il santuario della natura: paradiso carico di frutti, misterioso hortus conclusus, santificato alsos greco, bosco abitato dal dio, separato dalla città. Il giardino è quel luogo finito, recintato, in cui appare l’infinita perfezione della natura. E la perfezione morale che esso ispira non è che il riflesso di quella perfezione estetica che lo domina. Dal pensiero antico fino a Kant, prima che Hegel sparigliasse le carte, tra i rari punti di convergenza – sempre parziale! – dei filosofi vi è la constatazione che la bellezza della natura rispecchia non solo la vera forma della natura, ma soprattutto – e serve la sagacia di un poeta come Luzi per dire la sintesi – il giusto della vita. E forse anche il suo gusto, o almeno uno dei suoi piaceri più alti. Qui la bellezza della natura, finalmente assoluta, perché sciolta da ogni condizione mondana, viene immortalata nella cornice muraria del chiostro, nelle volte del porticato, e realizza l’impossibile: l’eterna idea invisibile si rende visibile, abita il tempo. Vero tempio della natura, il giardino è davvero una foresta di simboli, il luogo delle corrispondenze, dove i modelli universali delle cose si rendono finalmente a portata di mano. “Il giardino è un itinerario progettato nei minimi dettagli, concepito come le tappe di un viaggio iniziatico dal visibile all’invisibile, di fonte in fonte, spesso collegate da cammini d’acqua che conducevano a una sorgente primitiva nascosta in una grotta o in un dirupo” (p. 87).
Si cammina tra le rocce seguendo il gorgoglio dell’acqua, ma ogni passo rappresenta soprattutto una progressione dentro e fuori la caverna platonica, verso la fonte, verso il principio, verso le verità ultime. Seguire le traiettorie imprevedibili dell’acqua, allora, significa anche imparare a imitarne il passo sinuoso, i risvolti improvvisi: lasciarsi affascinare dalle sensuali movenze delle ninfe che deviano il cammino in antri oscuri, senza perdere tuttavia il desiderio di trovare la scaturigine. Dove si trova l’origine di quella bellezza? Ecco allora che anche l’andamento del racconto diventa acqueo: sebbene segua una traiettoria storico-cronologica, il libro non rinuncia a divagazioni, svincoli, rivoli di approfondimenti laterali, aneddoti personali. Al punto che alla fine sembra quasi il libro stesso ad essersi fatto simile ad un giardino: concilia microcosmo e macrocosmo, senza dimenticare la fonte, restando sempre sulle tracce di quella magia dell’acqua che lo nutre. D’altronde, come mostra esemplarmente l’autrice, acqua e giardini sono inseparabili, le medesime divinità dei luoghi vegliano su di loro. Così il genus loci che sorveglia l’architettura di Villa d’Este di Pirro Ligorio (pp. 108-110) non si sente a casa se lo zampillio delle fontane non erompe davanti alla facciata.

La meraviglia che l’acqua suscita, infatti, si accompagna sempre allo stupore che ispira tanto l’esperienza dei suoi frutti lussureggianti, lo spettacolo verdeggiante della natura, quanto degli edifici, della vita delle città, che solo l’acqua – come abbiamo imparato a nostre spese in tempi di siccità – rende possibile. Roma, città eterna, come mostra l’autrice (pp. 144-154), non è che un immenso elogio all’acqua: dai nasoni alle fontane del Bernini, ogni sampietrino rovente celebra la vita liquida che lava via l’arsura estiva. Infatti, non c’è vita che eternamente si rinnovi, che fluisca sempre, che sia sempre verde, senza un baluginante riflesso, che faccia quasi da eco a quell’immortalità trasparente – eppure così inafferrabile e sfuggente – dell’acqua. Dove la vita scaturisce c’è l’acqua, l’elemento che anima e principia tutte le cose.
E non è forse un caso che abbia meditato il mistero dell’acqua anche quel sapiente che per primo tematizzò in modo inaudito la questione della sorgente originante tutte le cose, da cui tutte fuoriescono, dipendono e ritornano. L’acqua è la metonimia dello scaturire: da sempre all’origine, origina ogni cosa. E origina perfino la filosofia! Che proprio con il sapiente Talete, com’è noto, incomincia a seminare il principio di un modo di pensare radicalmente originale. Ma, come ci ricorda l’autrice (23-24), il contributo dell’antico sapiente di Mileto alla filosofia dell’origine – e all’origine della filosofia – non finisce qui. La rigogliosa fertilità del giardino, specchio della vitalità della natura e del mondo intero, non fa che testimoniare la grandezza di quel dono gratuito della vita che lo alimenta e lo permea in ogni sua parte. Ovunque la forza sorgente dell’acqua sembra presente, perché ovunque si ripropone quel miracolo della vita. Ovunque, infatti, come insegna il sapiente, è presente un Dio, una vita immortale.