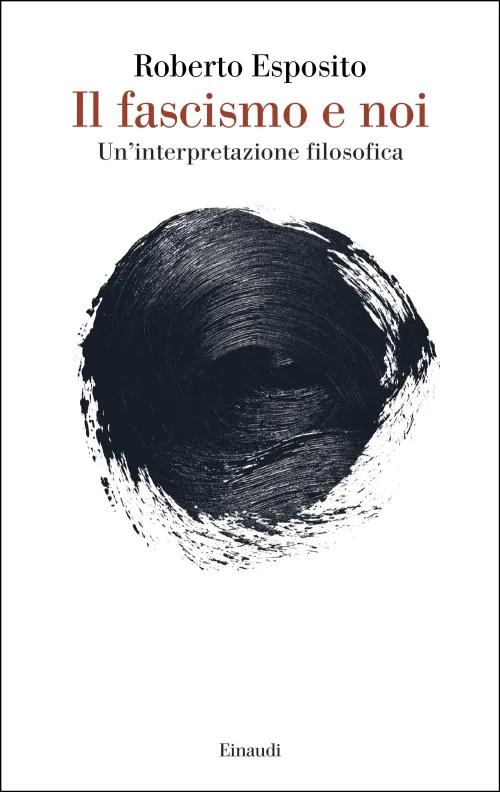Roberto Esposito nelle tenebre del fascismo
La necessità di una riflessione filosofica sul fascismo si impone quando il fascismo diventa una minaccia reale. Per quanto indiscutibili siano tutte le differenze tra la situazione presente e quella vissuta negli anni venti e trenta del secolo scorso, la parola “fascismo” affiora inevitabilmente alla mente quando si vuole inquadrare il fenomeno populista-sovranista. E, con essa, il suo opposto, “antifascismo”, anche questo un termine abusato, gravato da una retorica che ne compromette sul nascere l’efficacia, e, tuttavia, anch’esso, inevadibile, quasi necessario. In attesa di nuovi e più precisi concetti scontiamo, insomma, la limitatezza del nostro vocabolario. Dobbiamo prendere a prestito vecchi termini per eventi nuovi, ma se questo è possibile è perché tra il vecchio e il nuovo vi è, di fatto, una continuità reale che è proprio quanto oggi ci inquieta e ci interpella.
Per queste ragioni il saggio di Roberto Esposito, Il Fascismo e noi (Einaudi, 2025), è un libro importante fin dal suo titolo programmatico: non chiede, infatti, soltanto che cosa sia stato il fascismo storico, ma chiede di “noi” rispetto ad esso, chiede “chi” siamo “noi” che lo abbiamo stigmatizzato come un orrore, ma che, oggi come allora, di fronte a un orrore solo somigliante (perché la via dell’”analogia”, secondo Esposito, è impercorribile) proviamo la stessa sensazione di impotenza, come se fossimo alle prese con una macchina che funziona in modo implacabile, una macchina cieca al senso e votata soltanto alla sua operatività illimitata. Gaza non è un campo di sterminio nazista ma gli somiglia, i militari dell’Idf non sono le SS ma gli somigliano, gli autocrati che impazzano ovunque non sono i duci fascisti ma gli somigliano e “noi” non siamo i nostri padri o nonni, i quali, nel migliore dei casi, hanno assistito come testimoni sgomenti all’avvento dell’orrore, ma gli somigliamo. E la somiglianza diventa quasi una relazione di identità se si considera il desiderio irrefrenabile di sottomissione e di vendetta (sui più deboli) che attraversa quel “popolo” sulla cui incondizionata sovranità tutti i populismi scommettono.
Secondo Esposito, una considerazione meramente storica del fenomeno “fascismo” mostra la corda perché attenendosi doverosamente al documento, come ogni storico che si rispetti deve fare, evita, per amore di rigore e per scrupolo scientifico, il rischio di andare oltre il fenomeno per coglierne il nucleo incandescente, cosa che i filosofi, quelli veri, invece da sempre fanno. “Solo le tenebre parlano alle tenebre”, scrive Esposito in un passo insolitamente enfatico per un autore che normalmente opta per una prosa piana e moderata nei toni. Se il fascismo è tenebra bisogna, insomma, osare farsi tenebra per provare a comprenderlo. Non è allora un caso se nel resoconto delle principali interpretazioni filosofiche del fascismo, che Esposito ordina geograficamente titolando alcuni capitoli con i luoghi fisici in cui sono state sviluppate, siano Parigi e Salò a spiccare. Georges Bataille nel 1933, Emmanuel Levinas nel 1934, Simone Weil poco prima di morire, e poi, più vicino a noi, la coppia Deleuze-Guattari con i due tomi di Capitalismo e schizofrenia e, in un ambito parafilosofico, Jonathan Littel con le Benevole e Pier Paolo Pasolini con Salò-Sade, hanno corso il rischio e hanno elaborato una metafisica del fascismo. Si sono realmente avventurati nella tenebra fascista per guardare finalmente in faccia il nemico. Il rischio, non da poco, era quello di riconoscere alla barbarie nazi-fascista la dignità di un’ontologia (Filosofia dell’hitlerismo era il titolo provocatorio del saggio di Levinas) e perfino di essere confusi con l’avversario, come capitò a Bataille e ai suoi amici del Collegio di Sociologia accusati di essere vittime della stessa fascinazione fascista che denunciavano (situazione che si è replicata dopo la pubblicazione delle Benevole di Littel).
Mentre il fascismo dilagava in Europa, allora centro del mondo, Bataille & co. provavano a spiegarne la genesi e il successo, sospendendo le letture razionalistiche e materialistiche degli intellettuali liberali e marxisti, per cercare di penetrarne il cuore nero, quello che infiammava le masse provocando una devozione che apparteneva all’ordine del religioso. Ciò che vi trovavano era una “macchina” che funzionava con il carburante ancestrale del mito. Furio Jesi, uno dei più brillanti interpreti, negli anni ‘70 del secolo scorso, della “cultura di destra”, l’ha chiamata “macchina mitologica”. La via di fuga che individuavano non era però quella illuministica della razionalizzazione del mito – fare luce sulle tenebre, insomma – ma quella resa possibile da un uso razionale delle tenebre contro le tenebre fasciste: la ragione per essere capace di costruire una comunità di uomini liberi deve cioè abbandonare la sua illusione di autonomia, quell’illusione che l’ha portata a disdegnare il sensibile, il corpo e la “vita”, consegnando di fatto queste potenze telluriche alla macchina mitologica dei fascisti. La razionalità deve riagganciarsi al “sentire”, tornare alle “viscere” su cui la ragione si fonda e che danno alle sue operazioni il loro senso e la loro direzione. L’Acefalo, l’uomo nudo senza-testa “complice dei vulcani” disegnato da André Masson per la copertina dell’omonima rivista di Bataille & co., era l’immagine di questa vertigine antifascista. Quasi negli stessi anni questa via “empiristica” e “iper-romantica” era battuta, seppure con un diverso vocabolario concettuale, tanto da Edmund Husserl nella Crisi delle scienze europee quanto da Alfred N. Whitehead in Processo e realtà: due immensi filosofi che hanno provato a pensare in diretta, mentre il fascismo dilagava, come riscattare l’Europa dalla sua miseria spirituale.
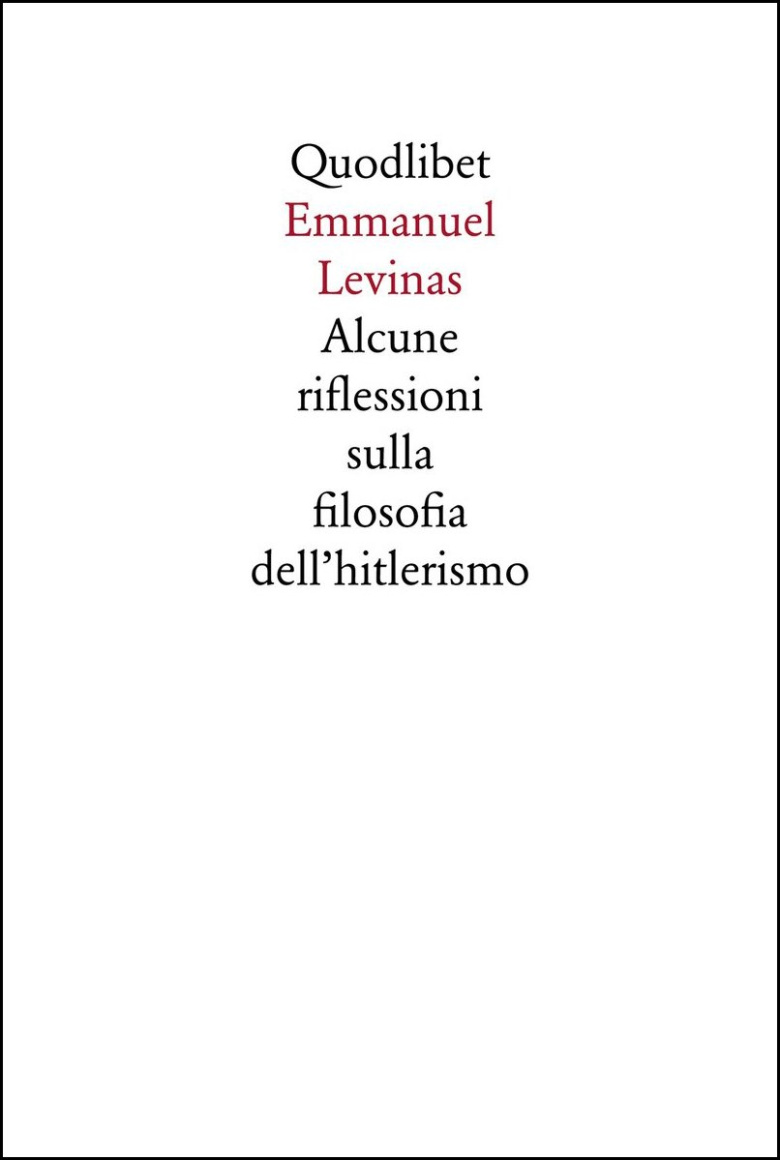
Si noti come si assista qui a una radicalizzazione dell’immanenza, vale a dire a una chiusura quasi claustrofobica del soggetto nel mondo, senza vie di fuga verso una qualche trascendenza, quando invece, per il contemporaneo Levinas della “filosofia dell’hitlerismo” (e per Esposito, il quale sostanzialmente converge con l’interpretazione di Levinas), l’immanenza assoluta costituirebbe proprio l’essenza della pratica fascista. Insomma, farsi tenebra per parlare alle tenebre voleva dire per Bataille, come più tardi vorrà dire per Deleuze-Guattari, osare l’ultimo assalto al cielo: andare più a fondo nell’immanenza, “inchiodare” lo spirito alla carne in modo definitivo (river, inchiodare, è verbo che ritorna continuamente nella critica levinasiana della filosofia dell’hitlerismo), trovando in quei “chiodi” non il “sangue e suolo” della mitologia fascista, ma il principio di un’altra, più che umana, libertà: una libertà al di là del mito, la definirà Bataille (e che Simone Weil farà coincidere con la “necessità”, conclusione veramente bizzarra per una filosofa che è generalmente presentata come paladina della trascendenza in lotta con l’immanenza fascista…).
Esposito fa seguire alle sue analisi delle varie interpretazioni filosofiche del fascismo dei “contrappunti” dove a prendere la parola sono le tenebre stesse, vale a dire i filosofi dichiaratamente fascisti. Il primo a prendere la parola è il nostro Giovanni Gentile. Gentile è stato il filosofo dell’immanenza assoluta, la sua critica di ogni trascendenza è tra le più radicali nella storia della filosofia occidentale. Se si vuole veramente comprendere che cosa significa “morte di Dio” bisogna passare attraverso la sua filosofia dell’“atto in atto”. Indipendentemente dalla compromissione di Gentile con il regime, questo sarebbe sufficiente, per Esposito, per provarne il fascismo intrinseco. Dal mio punto di vista, questo mostrerebbe invece come sia possibile sul piano speculativo portare la filosofia di Gentile dalla parte “giusta” della storia, farla cioè funzionare in un senso “antifascista”, liberandola da quel mito (lo stato “etico”) che la corrode e che la snatura. Perché, insomma, non fare ai fascisti quello che loro hanno fatto a “noi”, appropriandosi sistematicamente del “nostro” vocabolario (nazional-socialismo), risignificandolo e misleggendolo? Perché non liberare l’immanenza assoluta dalla retorica che la soffoca e che la trasforma in ideologia e barbarie? Non è forse questo uno dei compiti, se non il compito precipuo, che si deve proporre una comprensione che si vuole metafisica del fascismo?
Anche Esposito, come Jesi, coglie l’essenza del fascismo nella macchina: “la tesi proposta in queste pagine – scrive nella Introduzione – è che il fascismo non sia un regime, un movimento, una dottrina – o meglio, che sia tutto questo, ma prima di tutto sia una macchina metafisica che si può definire ‘generativa’ in quanto capace di generare le sue stesse condizioni di esistenza e di espansione”. Una descrizione perfetta del fenomeno fascista, che non si può che sottoscrivere punto su punto. Resta però da precisare che tipo di macchina sia questa macchina metafisica. Dalla risposta a questa domanda dipende infatti la possibilità di fare luce sul problema che oggi ci angoscia: quale continuità, ci chiedevamo, c’è – se c’è – tra il fascismo storico e il nostro presente populista-sovranista? Esposito è estremamente prudente a questo proposito. Invita a diffidare del metodo analogico, a tenere conto delle immense differenze, e in ultima analisi, opta per la discontinuità. In effetti non ci può essere continuità alcuna se la macchina metafisica fascista è intesa, come fa Esposito, come un “paradigma”. I paradigmi – Plato docet – sono modelli ideali, svolgono il ruolo di archetipi, sono trascendenze che hanno un valore esemplare e definitivo. Il fascismo-paradigma è un fatto compiuto. Lo sguardo teorico può circoscriverlo e definirlo. Ne può enucleare l’essenza. L’antifascismo verboso e vuoto dei nostri intellettuali progressisti ha di mira proprio questo fascismo codificato e, per così dire, compiuto: il fascismo delle camicie nere e del manganello, il fascismo dei nostri nonni. Esposito ha quindi ragione a criticare chi, per economia cognitiva, riduce frettolosamente il nuovo all’antico.
Ma della macchina metafisica fascista si può dare un’altra interpretazione. C’è un’altra tipologia di macchina. Vi sono infatti macchine che sono prototipi. A differenza degli archetipi, che hanno il loro essere nel passato, i prototipi hanno il loro essere nel futuro, sono gravidi di avvenire, perché sono sperimentali. Un prototipo è un laboratorio. I prototipi sono processi in atto. Corrisponde perciò al meglio alla definizione della macchina metafisica fascista come macchina generativa “in quanto capace di generare le sue stesse condizioni di esistenza e di espansione”. Per parlare la lingua dei filosofi, un prototipo è un essere del divenire, qualcosa che, dati certi vincoli, è letteralmente fatto di cambiamento. Più però dei filosofi, che per deformazione professionale sono abbagliati dal problema teorico dell’essenza, a mostrare una maggiore sensibilità a questa natura processuale del fenomeno fascista sono stati storici originalissimi come Zeev Sternhell e Klaus Theweleit, politologi come Franz Neumann, psicoanalisti anomali come Wilhelm Reich, e naturalmente artisti, come Pasolini e Littel citati da Esposito (ma aggiungerei alla lista il Curzio Malaparte della Tecnica del colpo di stato, formidabile libello che nel 1931 descriveva in diretta la genesi dei cosiddetti totalitarismi europei). Il dato comune a tutte queste diversissime interpretazioni è quello di presentare il fascismo storico come una modalità storicamente determinata di elaborazione di un prototipo, come una stazione di un processo in corso che ci riguarda in prima persona. Non un fatto storico, o non soltanto un fatto storico, dunque, ma un divenire, un evento, una tendenza, un problema all’orizzonte del nostro presente, qualcosa, insomma, che, provenendo indubbiamente dal passato, concerne però il nostro futuro prossimo.
Se la macchina metafisica fascista è un prototipo in via di continua elaborazione (una “macchina generativa”, come scrive Esposito) ne consegue che il problema con il quale “noi” oggi non possiamo non confrontarci non è la rinascita del fascismo ma il suo possibile avvento in una forma inedita. A incombere sulle nostre teste è infatti la minaccia della realizzazione del fascismo. Rispetto alle tenebre che si annunciano, il fascismo dei nostri nonni va allora considerato come un abbozzo sperimentale, come il primo terribile vagito di un essere che è tuttora in via di formazione. Le parole con cui Wilhelm Reich, nel 1933, introduceva il suo grande libro, Psicologia di massa del fascismo, valgono dunque per noi forse ancor di più di quanto valessero per lui: “Il fascismo, scriveva, è un fenomeno internazionale che corrode tutti i gruppi della società umana di tutte le nazioni. Questa conclusione trova la sua conferma negli avvenimenti internazionali degli ultimi quindici anni. Le mie esperienze analitico-caratteriali mi hanno convinto che oggi non esista nessuno che non porti in sé gli elementi del modo di pensare e sentire fascista”