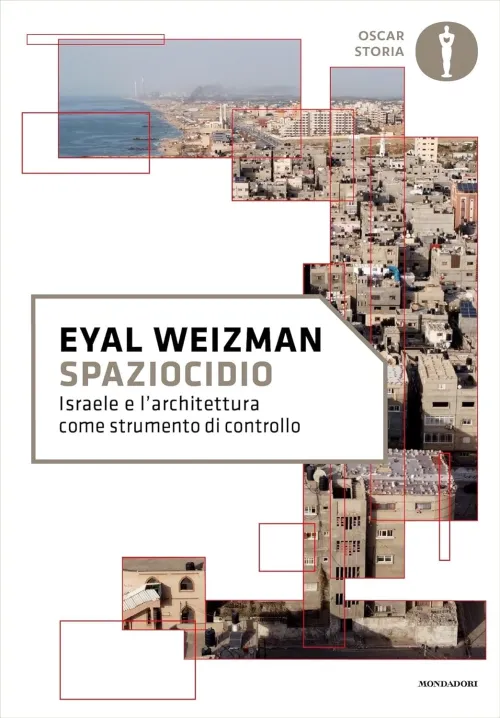Se la filosofia va alla guerra
Mi chiedo se accogliere la proposta di istituire un corso di laurea in filosofia presso l’Università di Bologna riservato agli allievi sottoufficiali dell’Accademia Militare di Modena significava “militarizzare” la filosofia, come probabilmente avrebbero sostenuto, se fosse stata accolta, gli studenti schierati sul fronte pacifista e antimilitarista. La risposta è certamente no, se lo scopo del corso era quello di fornire all’élite militare una generica “cultura filosofica” . Avere ufficiali filosoficamente educati sembra anzi una buonissima cosa perché inietta coscienza critica e libertà di pensiero in un ambiente che, per ovvie ragioni, è caratterizzato dal primato della disciplina e dell’obbedienza all’autorità. Ma è corretto intendere in questo modo inoffensivo e sostanzialmente “pacifico” la richiesta avanzata dai vertici delle forze armate e vigorosamente sostenuta dal Ministero della Difesa? Era veramente la filosofia in quanto “cultura umanistica” la posta in gioco? Oppure in quella richiesta di sapere filosofico è legittimo sospettare anche la presenza di altre esigenze coerenti con le necessità di chi professionalmente si occupa dell’arte della guerra? Non espresso, mascherato sotto l’appello generico alla “cultura”, non agisce forse anche l’idea, un’idea nient’affatto pacifica, di un possibile uso militare della filosofia?
A dare una qualche fondatezza a questo sospetto sono state le parole sdegnate con cui il generale Carmine Masiello ha reagito alla risposta negativa dell’Ateneo bolognese, che, come è noto, adduceva a motivazione del suo rifiuto una serie di ragioni burocratico-economiche. Per spiegare come fosse nata l’idea di un corso di laurea in “filosofia” il generale ha insistito sulla necessità di implementare l’educazione militare con una forte dose di “pensiero laterale”. Lateralizzare il pensiero significa liberarlo dai suoi automatismi percettivi e renderlo così capace di risolvere problemi in modo “divergente”, generando nuove e fino a quel momento impensate possibilità operative. Per raggiungere questo obiettivo il passaggio nei dipartimenti di filosofia era allora, secondo il generale, indispensabile perché la filosofia è l’incubatoio del pensiero “critico”, vale a dire di quel pensiero non conformista che, posto di fronte ai problemi sollevati dall’esperienza, sa tracciare vie inedite che si discostano da quelle abitudinarie. L’insistenza sulla necessità del “pensiero laterale” rende allora per lo meno “formulabile” il sospetto che ad interessare veramente un generale di corpo d’armata, dedito alla formazione dei militari, fosse soprattutto l’esigenza di far fronte, in modo creativo, ai nuovi problemi che una guerra a venire, eterogenea rispetto a tutte quelle che l’hanno preceduta, porrà necessariamente a chi istituzionalmente è preposto a combatterla.
Letta in questa chiave, la richiesta di filosofia era quindi del tutto coerente con quelle che sono le finalità di una preparazione rivolta alla formazione di militari, vale a dire di professionisti della guerra. Se si scrosta la superficie retorica che la riveste (il valore universale della “cultura umanistica”, la necessità per tutti di una “educazione spirituale” ecc.), si scopre che quella richiesta nascondeva un’altra preoccupazione, non riconducibile a un semplice desiderio di arricchimento culturale per l’aspirante ufficiale. Meglio di tanti professori di filosofia, che nei loro dipartimenti trattano la filosofia come un reperto storico, cui destinare soltanto un interesse erudito, le alte gerarchie dell’esercito ne intuiscono invece la potenza performativa: la filosofia è per loro soprattutto un’arma, la cui potenza è pari, se non superiore, a quella dei droni e delle tecnologie elettroniche. Ne hanno bisogno perché ne comprendono lucidamente l’efficacia reale nelle situazioni di crisi. Per orientarsi nella “nebbia della guerra” occorre infatti una “veggenza” di altra natura rispetto al solo sapere tecnico.
La necessità della filosofia come arma per vincere le nuove guerre asimmetriche era già stata posta sul tappeto dagli strateghi militari dell’IDF. Per portare a termine l’opera di disinfestazione del “terrorismo” dai campi profughi palestinesi – così veniva inteso nel 2007 quello che sappiamo oggi essere in realtà un’operazione genocidiaria – occorreva far studiare filosofia ai militari. In quel formidabile libro che è Spaziocidio. Israele e l’architettura come strumento di controllo (Mondadori, 2022), Eyal Weizmann (attuale coordinatore del sito Forensic Architecture che utilizzando tecniche architettoniche e di visualizzazione digitale indaga su violenze di stato e violazioni dei diritti umani) ha raccontato come la più radicale filosofia critica europea, avesse per un certo periodo sostituito nelle scuole di formazione dell’IDF i classici ma ormai inutili testi sulla guerra “tradizionale”. Di fronte al reticolato di tunnel di un campo profughi, dove le distinzioni concettuali classiche della strategia militare standard perdono di senso (dove finisce il militare e inizia il civile? Dove è il campo di battaglia? Chi è il nemico? Come muoversi, insomma, nella palude della guerra a un popolo, nel labirinto di una Città informale?), occorreva infatti un radicale rinnovamento del modo di pensare la tattica militare. Bisognava ripensare lo spazio e il modo di attraversarlo.

A tal fine, i generali israeliani, con un vero e proprio colpo di genio, hanno chiesto lumi al “pensiero nomadico” di Gilles Deleuze e Felix Guattari (e, in particolare, alla riflessione contenuta in Mille Piani sulle “macchina da guerra” e sullo “spazio liscio e spazio striato”). Si è realizzato così un singolare cortocircuito teorico-pratico: un pensiero filosofico “anarchico” nato per dare corpo a istanze libertarie, un pensiero che, tra l’altro, aveva una delle sue fonti di ispirazione proprio nella resistenza del popolo palestinese all’oppressione coloniale, viene assimilato da un apparato di Stato che lo usa spregiudicatamente contro quel popolo. La “macchina da guerra” nomadica teorizzata da Deleuze-Guattari riposava su un principio semplicissimo: a differenza dello stanziale, per il nomade lo spazio è aperto, il nomade non si sposta in uno spazio dato come un mobile si sposta da un punto a un altro, ma lo elegge a sua dimora provvisoria attraverso un movimento continuo, il “luogo”, insomma, è generato dal movimento e non è ad esso presupposto.
Per dirla con il poeta, per il nomade il cammino si fa camminando, la via la si deve costruire percorrendola, la si deve creare liberamente, momento per momento, deviando dalle rotte stabilite, inventando, sperimentando, o, come scrivono i due nel loro immaginoso linguaggio, praticando “linee di fuga”, “deterrittorializzando”. Per dirla con il matematico, lo spazio si fa topologico, dinamico, abbandonando la sua rigida compartimentazione euclidea. Era questa, secondo gli strateghi dell’IDF, l’intelligenza critica di cui si sarebbero dovute dotare le forze di occupazione israeliane per raggiungere il loro obiettivo strategico. Una sua concreta applicazione è stata la scelta di procedere nel dedalo del campo-profughi in linea retta sfondando le pareti delle case private invece di seguire la topografia del luogo, bypassando la canonica distinzione tra uno spazio civile ed uno militare, portando il campo di battaglia dove ci sono famiglie riunite per mangiare, annullando o meglio ricalcolando volta per volta la differenza tra il civile e il militare nemico. Un pensiero strategico efficace, cioè all’altezza della nuova situazione, deve essere, insomma, un pensiero pensante e non un pensiero già pensato: non è l’applicazione di regole apprese sui banchi delle accademie ma è creazione contingente di un ordine a partire dal caos, tenendo anzi i propri piedi in pianta stabile nel caos, che di ogni ordine è il principio intensivo.
Un altro bellissimo libro (Tommaso Tuppini, La caduta. Fascismo e macchina da guerra, Orthotes 2019) ha mostrato come questa logica ”laterale” spieghi lo straordinario successo dell’esercito tedesco nei primi anni di guerra: non una rigida disciplina militare, come si è soliti credere quando si parla dei tedeschi, ma una sorta di anarchia controllata guidava l’avanzata irruenta dei tank della Wermacht in tutta Europa; l’imprevedibilità, la bergsoniana “durata creatrice”, era la logica che spiegava quel movimento frenetico (Tuppini direbbe “vorticoso”) di distribuzione nomadica di una potenza d’occupazione in uno spazio aperto, che sembrava non conoscere arresto.
È allora comprensibile che chi oggi si pone il problema di come dovrà essere combattuta la guerra che verrà – una guerra, lo sappiamo, irriducibile ai modelli noti – si ponga il problema di una educazione al pensiero critico per i militari che va preparando. Ignorare la necessità dell’arma “filosofia” sarebbe infatti da irresponsabili, come trascurare l’importanza delle nuove tecnologie elettroniche guidate dall’intelligenza artificiale. Spacciare però questa domanda di filosofia come una inoffensiva domanda di “cultura umanistica”, priva di qualsiasi connessione con quelle che sono le finalità istituzionali di una scuola di guerra, rischia di essere un esercizio di malafede, smentito per altro dalle intenzioni espresse dagli stessi proponenti che, non a caso, hanno fatto del “pensiero laterale” lo specifico filosofico che a loro veramente interessava. Non sarà infatti un astratto sapere “umanistico” a soddisfare la loro esigenza sebbene in questa forma la presentino all’opinione pubblica. Ciò che realmente vogliono, in quanto professionisti della guerra, è proprio del pensiero critico, della sperimentazione concettuale, della creazione di concetti. che permettano, nella nebbia della guerra, di inquadrare l’obiettivo e di distruggerlo.
Non infondato è allora il sospetto di chi vi ha paventato una possibile militarizzazione della filosofia. Le ragioni che hanno portato l’Ateneo bolognese a non accoglierla sono di tutt’altro ordine, e non riguardano nessuno dei problemi che abbiamo qui sollevato, ma mi piace pensare che all’origine del diniego vi sia anche una sorda, irriflessa e forse inconscia resistenza ad un “uso” perverso della filosofia che è in aperta contraddizione con la natura dell’istituzione universitaria.