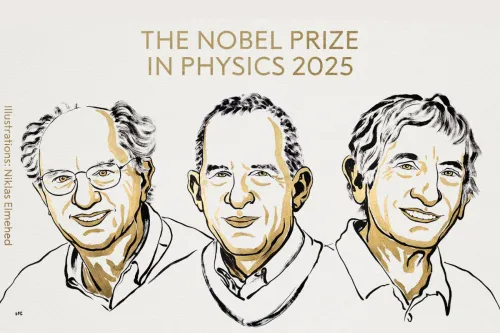Scienziati da Nobel 2025
Per molto tempo, non mi sono coricato affatto la sera. Parafrasando, potrebbe essere l’incipit di tante veglie quanti sono gli scienziati che, la notte prima dell’annuncio dei premi Nobel, non hanno preso sonno sapendo, immaginando, comunque sperando di poter essere raggiunti dalla telefonata della Reale Accademia delle Scienze Svedese, all’alba del fuso orario di Greenwich. Sembra che almeno uno dei premiati di quest’anno, John Martinis, dopo aver vagato insonne per troppe notti, a quarant’anni dalla pubblicazione del lavoro che è stato giudicato meritevole del massimo riconoscimento scientifico per la Fisica (un esperimento “cristallino, la quintessenza del metodo popperiano”, come lo ha definito Enzo Barone, fisico dell’università del Piemonte Orientale), si fosse rassegnato, concedendosi da tempo a good night sleep, come raccomanda il buon senso anglo-sassone. Sembra – di nuovo – sia stata la moglie a ricevere la telefonata e a comunicare al marito la buona novella al suo risveglio: dietro ogni grande uomo c’è una moglie all’erta. Miglior sorte, ma solo apparentemente, era toccata a Brian David Josephson, fisico gallese che la sua scoperta dell’effetto quanto-meccanico detto “tunnel” l’aveva fatta già a 22 anni, e che ne aveva dovuti attendere solo undici per diventare nel 1973 uno dei Nobel più giovani mai premiati: che il paper uscito su Physical Review Letters del 1985 a firma di John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis –, i tre Nobel per la fisica appena annunciati – titolasse, Energy-level quantization in the zero-voltage state of a current-biased Josephson junction, fa ben intendere la relazione tra le due storie. Che poi si possa dubitare che quella di Josephson sia stata più fortunata, dipende dal prosieguo della carriera del precocissimo Nobel, tutta dedicata allo studio dei fenomeni parapsicologici: un po’ come capita agli sportivi, se il cielo lo tocchi con un dito tra i venti e i trent’anni, il resto della vita te lo devi inventare.

Al contrario, nonostante le sue 83 primavere, il commento di John Clarke, “Mai mi sarei aspettato il Nobel!” non deve stupire, tanto meno autorizzare il sospetto di un understatement di calcolata sincerità: di norma, tra i fisici, sono quelli teorici che devono attendere una conferma sperimentale prima che gli siano riconosciuti meriti ed eventuali premi, come è accaduto da ultimo a Peter Higgs: dagli anni ’60 della teorizzazione del suo “meccanismo”, fino all’esperimento del CERN, annunciato il 4 Luglio del 2012, e al conferimento del Nobel appena un anno dopo, il 10 Dicembre del 2013. L’esperimento di Clarke, Devoret e Martinis, invece, viene premiato quando oramai nessuno di loro se lo aspettava più: come mai? La coincidenza con il centenario della meccanica quantistica può essere un primo motivo/indizio: è del 1925, infatti, l’articolo di Werner Heisenberg che segna l’alba della teoria che definirebbe il comportamento della materia e dell’energia su scala microscopica, a livello di atomi, elettroni, fotoni e altre particelle elementari. E usiamo il condizionale non in relazione alla capacità esplicativa della teoria stessa, ormai comprovata oltre ogni più ragionevole dubbio, ma proprio perché gli esperimenti dei neo premiati dimostravano, già quarant’anni fa, le “proprietà quantistiche anche su scala umana”, come recitano i comunicati. Certo non a livello di una pallina da tennis, per dire, che non può attraversare un muro ritrovandosi integra dall’altra parte, ma sicuramente di un ensamble, un aggregato di miliardi e miliardi di quelle particelle elementari: una giunzione Josephson tra semi conduttori, un effetto “tunnel” genuinamente quantistico in sistemi che vanno verso il macroscopico. Vanno… fin dove? Concettualmente si trattava già allora di un risultato importantissimo, inserendosi nel solco di ricerche già premiate come quelle di Robert Laughlin, nel 1988 e, più direttamente, di Anthony Legget nel 2003, dimostrando sperimentalmente come la meccanica quantistica non fosse limitata a un angolo del mondo ma che è invece una teoria universale, in linea di principio applicabile anche a oggetti macroscopici: ma fino a dove, di nuovo? Fino a quale limite di grandezza? Problema non da poco, quale sia il confine tra microscopico e macroscopico, uno di quei “fronti” della ricerca e della conoscenza che autorizzerebbe il riferimento al “mistero”: ciò che è sempre stato e rimane tale, fino a quando qualcuno attrezzato scientificamente non lo affronta come un problema, e poi lo risolve. Come sia, a metà degli anni ’80, forse solo nella testa di Richard Feynman potevano prendere forma quelle applicazioni pratiche che oggi, con riferimento allo sviluppo dei computer quantistici, sembrano più vicine. E potremmo trovare qui una seconda spiegazione per il ritardo del Nobel, ricordando che il riconoscimento premia scoperte che possono rappresentare effettivamente “un progresso per l’umanità”. Quel progresso, ora, si intravede. Poi certo bisogna intendersi, queste “giunzioni”, questi sistemi sono alcuni tra quelli che potranno essere utilizzati per realizzare dei chip quantistici, per poi eventualmente assemblarli in vista di un processore quantistico: siamo ancora ben lontani dal “computer” realizzato, siamo ancora agli elementi basilari del calcolo, alla soglia delle porte logiche tra i Qubit. Ma la strada è segnata.
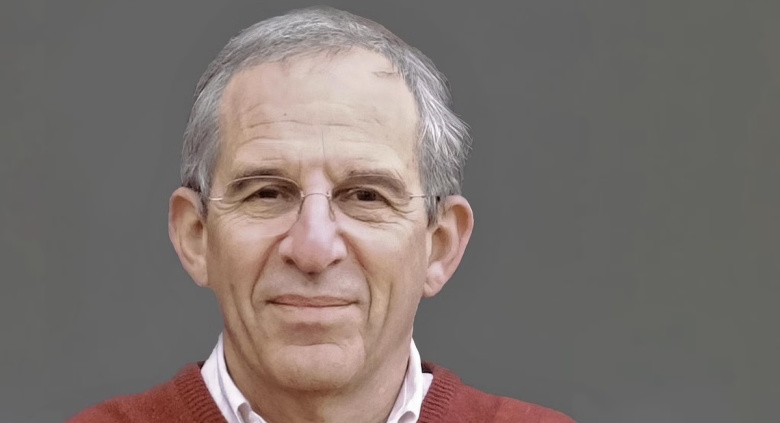
Una pista, la terza, per comprendere le ragioni per cui Clarke, Devoret e Martinis vengono premiati oggi, può riferirsi anche all’“aria che tira”: la tendenza a privilegiare l’osservazione, non già e non solo del livello microscopico delle singole particelle, ma cercando invece di capire come funzionano i sistemi, gli ensamble, gli aggregati. Un’attenzione ai fenomeni emergenti che aveva motivato nel 2021 il premio al nostro Giorgio Parisi per lo studio di quelli collettivi, nell’interazione tra disordine e fluttuazione dei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria, e quelle dello scorso anno a Geoffrey Hinton e John J. Hopfield per il lavoro sulle teorie e gli strumenti di base che rendono possibili le reti neurali.
Al concetto di rete – si potrebbe dire, non a caso – si rifà anche la motivazione per i Nobel per la Fisiologia e Medicina, assegnato a Mary E. Brunkow, Frederick J. Ramsdell e Shimon Sakaguchi, un premio per studi sull’immunologia, nello specifico “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance”, ovvero per aver scoperto come il sistema immunitario evita di attaccare i tessuti del proprio corpo, tramite le cosiddette cellule regolatorie T (regulatory T cell). Anche questo un Nobel che non aveva raccolto puntate significative alla borsa di Stoccolma e che, al pari dei colleghi fisici, vanta un precedente illustre a indicare la via. Nel 1974, sugli Annales d’Immunologie, il biologo danese Niels K. Jerne pubblicava uno studio teorico fondamentale intitolato Towards a network of the immune system, proponendo la cosiddetta teoria della rete idiotipica, l’ipotesi che il sistema immunitario sia regolato non solo dagli antigeni esterni ma anche da interazioni tra anticorpi, formando una rete complessa che può mantenere memoria immunitaria o tolleranza. La motivazione del Nobel a Jerne, del 1984, recitava : “Per le teorie sulla specificità nello sviluppo e nel controllo del sistema immunitario e per la scoperta del principio alla base della produzione di anticorpi monoclonali”. In sostanza, per Jerne, il sistema immunitario è una rete di interazioni, ovvero: non è sufficiente analizzarne i singoli pezzi ma bisogna studiare le sue caratteristiche generali, di un sistema fatto di molte cellule diverse – macrofagi, linfociti T (e tutte la varie tipologie), linfociti B (Bone marrow, dal midollo dove nascono), piastrine – che certamente devono riconoscere gli attacchi esterni, discriminando gli invasori dalle legittime cellule dell’individuo, evitando lo sviluppo di patologie autoimmuni, ma che deve anche capire, se è legittimo esprimersi in questi termini, quand’è che bisogna cominciare il lavoro e quando deve finire. La rete dell’insieme delle interazioni tra queste cellule è cablata in maniera tale da non arrivare mai a quell’aumento catastrofico di risposta immunitaria del sistema che diventa ben più fatale dell’agente patogeno: vedi alla voce Sars-Cov-2. In sostanza, esattamente trent’anni fa Shimon Sakaguchi ha scoperto la classe di cellule T, regolatorie, specializzate nel frenare la risposta immunitaria, Brunkov e Ramsdell, circa sei anni dopo, hanno identificato la molecola che programma queste cellule e il cui eventuale difetto determina una grave malattia autoimmune. Capire quando il lavoro deve cominciare e quando deve necessariamente terminare vuol dire saper discriminare il da farsi e mantenere autocontrollo: in prospettiva, può significare sapere come e quando potenziare l’azione immunitaria per prevenire rigetti e autoimmunità come, al contrario, poter inibire il freno, quando serve scatenare la risposta contro una crescita tumorale. Controllo e tolleranza. Le ricerche dei neo premi Nobel, sulla “tolleranza immunitaria periferica” hanno messo in evidenza la capacità adattiva del sistema immunitario nel riconoscere ciò che non deve attaccare, mentre si sviluppa in forme coevolutive e di coadattamento con le altre cellule dei tessuti, imparando a conoscerle, a “conoscersi” e, nella stragrande maggioranza dei casi, rieducando le mutazioni potenzialmente degenerative. Il legame concettuale profondo tra le scoperte di Jerne e quelle che oggi vengono premiate, si basa sull’evidenza per cui il sistema immunitario è una rete autoregolante, in cui anticorpi e cellule immunitarie si controllano reciprocamente impedendo reazioni eccessive contro il “sé”: a Sakaguchi, Ramsdell e Brunkov il merito di aver identificato i reali meccanismi che esercitano questa autoregolazione in modo concreto. E sia gloria!

Mentre scrivevamo queste righe a commento dei primi due premi della terna scientifica (il Nobel per la Chimica è andato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, per aver sviluppato una particolare architettura molecolare – le MOFs, metal-organic frameworks –, in sostanza dei materiali che contengono cavità con grande potenziali di applicazione, quali la cattura di CO2, la raccolta di acqua nell’aria dei deserti, lo stoccaggio di gas tossici… un più che evidente “progresso per l’umanità”), abbiamo atteso senza particolare apprensione l’annuncio del Nobel per la Pace, ché da Oslo non sarebbe stata la prima volta di una scelta controversa, e con gran grande curiosità quello per la Letteratura. Così come lo scorso anno, alla curiosità si è aggiunto lo stupore e la soddisfazione di poter conoscere un autore mai letto prima, Han Kang ieri (memorabile, nella sua terribilità, Atti umani), Lazlo Krasznahorkai oggi, di cui ci accingiamo alla conoscenza diretta. Sennonché, leggendo le motivazioni del premio, e anche alcuni articoli a commento, compresi quelli appena usciti su Doppiozero, si è imposta un’osservazione perturbante per chi, come il recensore, ha speso una vita a sfumare se non contestare fieramente l’opposizione tra le famigerate due culture di cui al pamphlet di Charles P. Snow (specialmente avendolo letto, eventualità non così conseguente tra chi lo cita). Nel rileggere le righe che abbiamo appena scritto e quelle a firma, tra gli altri, di Francesco M. Cataluccio e Carlo Tirinanzi De Medici, non abbiamo potuto non considerare come vi è chi sembra disegnare fantastici scenari progressivi, spostando in avanti l’orizzonte della scoperta e costruendo mondi dove, tra le altre cose, si può sopravvivere a malattie che in passato non lasciavano speranza, insieme a chi riferisce di un mondo che la speranza non l’autorizza più, raccontandone la definitiva desolazione, uno sguardo sul dolore e sulle macerie. Da una parte la rinnovata promessa di un sol dell’avvenire (paradossalmente, forse, per via scientifico-tecnologica), dall’altra la rappresentazione della fine del tempo, il definitivo raggiungimento di una “stabilità eterna fatta di dissoluzione e devastazione”.
Tra le tante contraddizioni del tempo in cui viviamo non è forse la più dissonante, pure segnala come si possa stare al mondo estraendo, dagli stessi materiali dell’esperienza, ragioni per dare vita ad una pluralità di avventure, di storie di conoscenza e di lucidi quanto disperati resoconti. Che i rispettivi protagonisti possano sedere l’uno accanto agli altri nello stesso salone delle feste, non appaia contraddittorio ma conferma della complessità e della ricchezza dell’esistere.
Leggi anche:
F. Cataluccio, C. Tirinanzi De Medici | László Krasznahorkai a due voci