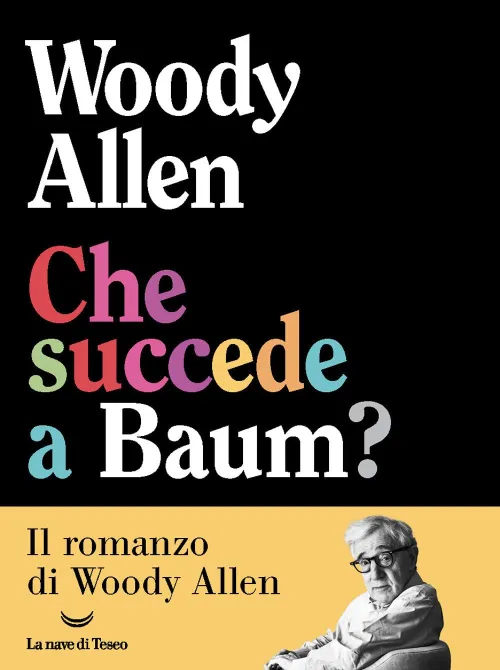Woody Allen: il romanzo
La prima cosa che salta agli occhi aprendo Che succede a Baum? (La nave di Teseo, 184 pp., € 20), romanzo d’esordio del novantenne Woody Allen, è che il suo protagonista parla da solo. Non sporadicamente come capita di fare a tutti ma sistematicamente. Per il resto è perfettamente normale. Un normale alla costante ricerca di momenti di solitudine, in cui poter dare cittadinanza alla sua introversione senza destare sospetti. È lo strambo comportamento di Asher Baum a far letteralmente uscire il romanzo dai canoni: Che succede a Baum? si propone, infatti, come una narrazione stilisticamente originale, che, invece di appellarsi al consueto “monologo interiore” preferisce dar forma al suo paradossale rovesciamento dialogico. Innovazione di non poco conto, per giunta guadagnata “fuori casa”, non nell’ambito del linguaggio cinematografico ma in quello letterario.
A dispetto del discorso costruito dai media – che lo hanno presentato con slogan come “Tutto ciò che ci si aspetterebbe da Woody Allen”, “Un film di Allen su carta” (Santoni, Corriere della Sera), o “Sembra un film, questo Woody Allen in formato romanzo” (Culicchia su La Stampa) – il primo romanzo di Allen si offre come un’espansione, se non altro mediale e stilistica, del suo universo poetico. La qual evenienza ci aiuta a immaginare che la storia di Asher Baum possa occupare, nella poetica di Allen, un posto tutt’altro che marginale: non un capriccio autoindulgente di un artista a fine carriera, ma un vero esperimento di pensiero, che non avrebbe potuto esistere in altra forma.
È la sua forma inedita a imporci, insomma, di prendere le distanze da quanto si dice in giro, lasciandoci presagire che l’obiettivo perseguito non sia soltanto consolatorio ma che, in Baum, si esprima un estremo tentativo di continuare, di aggiungere un tassello oltre la sensazione di domesticità a cui la produzione artistica alleniana ci ha abituato.
Si può facilmente concordare, infatti, sul fatto che ognuno dei suoi spettatori-fan, esattamente come i critici poc’anzi citati, sarebbe tentato di ri-conoscere Woody Allen per il tramite della coerenza del suo universo poetico, organizzato secondo grandi temi: ateismo radicale, insignificanza metafisica della vita e della morte, dominio del caos oltre la morale e sulle cose della vita. Di fronte alla durezza di questa condizione generale e umana, ognuno dei personaggi alleniani si posiziona, illuminando progressivamente sulle alternative a disposizione del singolo per riempire di senso la propria vita: quella del distacco ironico, della scommessa sulla fortuna, la via dell’illusione e della nostalgia, dell’impegno sentimentale ed erotico orientato a privilegiare whatever works contro i legami disfunzionali della famiglia tradizionale, ma anche la via dell’eroismo tragico. Pochi (ma buoni) personaggi di Woody Allen prendono il toro per le corna, ribellandosi al loro destino, determinando così la propria ineluttabile fine. Questi temi ci sono tutti, in effetti, nel romanzo.
Si potrebbe aggiungere che i personaggi di Woody Allen – e anche qui Asher Baum non fa eccezione – sono sempre nevrotici e iperattivi. La coscienza che essi mostrano di possedere della tragicità del tutto, non li porta al nichilismo, quanto piuttosto alla volontà di approfittare del poco tempo a loro disposizione, vivendo nell’ansia di riempire di cose la propria vita. Quella stessa ansia che ognuno degli spettatori ritrova su di sé e che gli permette di rispecchiarsi in essi, mentre reclamano con trepidazione il “prossimo” film di Woody Allen.
La varietà di casi umani chiamati in causa nei suoi 50 film e 90 anni di vita (entrambi numeri tondi), appaiono, dunque, tutte come modi per dire “quasi” la stessa cosa. La ripetizione, ovvero la variazione infinitesimale nella continuità, sembra essere la cifra del suo lavoro.
Ed è allora che, ogni tanto, il gioco si scopre. C’è sempre qualche primo della classe che alza la mano per annunciare che “Woody Allen non è più lo stesso”, intendendo che abbia tradito, che si sia lasciato corrompere, si sia montato la testa o, che si sia adagiato sugli allori dell’autocompiacimento e della faciloneria. È successo quando ha abbandonato lo slapstick degli esordi in nome delle commedie romantiche, quando ha lasciato le commedie romantiche per il suo “periodo bergmaniano”, quando è uscito Misterioso omicidio a Manhattan (a suo tempo annunciato come il film in cui Woody Allen tornava a essere sé stesso, il sé stesso di Io e Annie, suo sesto film), è successo ancora con gli ultimi film, accusati di essere facili, grossolani, e ultimamente di essere “stanche” ripetizioni di formule superate (con riferimento alle ambientazioni, ai ruoli di genere, al politicamente corretto etc.). Fino ad arrivare al suo ultimo Coup de chance, accolto con l’affettuoso paternalismo di chi, dopo aver detto che Woody Allen tornava ancora una volta a essere sé stesso (il sé stesso di Match Point, suo trentacinquesimo film), aggiungeva però con un’alzata di spalle che si trattava pur sempre “di un film girato da un regista quasi novantenne” – volendo alludere a presunte manchevolezze del medesimo. Si può pensare che, sebbene sempre visibili nelle cerchie di quelli che la sanno lunga (con cui Woody aveva già a suo tempo “pareggiato i conti”, 1976), queste critiche non siano mai riuscite a intaccare il suo prestigio, il suo essere “lo stesso” per la stragrande maggioranza dei suoi spettatori. E pazienza se questo “stesso” grattando la superficie si riferisce (spesso inconsapevolmente) a Allen diversi, agli slapstick degli esordi, al periodo bergmaniano, ai suoi “film europei” e chi più ne ha più ne metta.

Veniamo al dunque: succede davvero qualcosa di notevole a Baum tale da fargli segnare una differenza o si tratta dell’ennesimo caso in cui Allen torni a essere sé stesso?
Offrire una risposta plausibile a questa domanda impone alcune scelte di metodo. La più ovvia è quella di scegliere di non dividere la sua opera sulla base dei “linguaggi” utilizzati (biografia, cinema, musica, letteratura) ma inseguire, come si è provato a fare finora, un intento di ricostruzione complessiva, in cui il problema del linguaggio si pone come modalità locale, scelta ad hoc sulla base delle esigenze espressive contingenti. Se, come si diceva in apertura, rappresentare visivamente il continuo “dialogo interiore” del protagonista sarebbe stato arduo (ma non impossibile), la letteratura fornisce strumenti più consoni, allora bene la letteratura.
Superato questo primo scoglio, ci si deve liberare dall’idea che possa esistere una corrispondenza uno a uno fra evoluzione della poetica e testo artistico. Non tutte le opere di Woody Allen avanzano nel ragionamento allo stesso passo.
Metto Baum dentro una differenza segnata da Rifkin Festival (di cui parlo qui).
Fino a Rifkin, a dispetto delle loro nevrosi, i personaggi di Allen sono tutti integrati, amano la New York del loro tempo, le opportunità che offre, la possibilità di realizzarsi, dandosi da fare, facendo a modo proprio ma adattandosi. Per lo più vincono, perché sanno essere flessibili: hanno in mente di prosperare nella città, di fondersi con essa (Zelig). Anche i gangster – prediletti dal Woody ragazzino – rientrano in questo quadretto. Una tale propensione è vera anche quando perdono, magari perché confidano troppo nella fortuna oppure perché, come Jasmine, mostrano di non sapersi adattare (contrappasso). È il loro non avere certezze granitiche, la volontà di essere assunti come puntini accesi delle luci della città che in fondo piace dei film di Allen: la promessa di integrazione che realizzano. Ed è forse proprio questo aspetto ad aver affascinato lo spirito che a Woody Allen appare più affine, Umberto Eco.
Rifkin è diverso. Per la prima volta, ci innamoriamo di un disadattato che non vuole integrarsi. Uno che, confortato dai consigli dalla Morte in persona, decide di lasciar correre e che impara a farsi piacere “le solite cazzate”: famiglia, lavoro, amori. È di fronte al fallimento che arriva la saggezza: la vita non è mai vuota anche se si perde, anzi, si può perfino arrivare a desiderare di prolungarla un po’, scegliendo di tenere una dieta ben calibrata unita a del sano esercizio quotidiano.
E veniamo, infine, a Baum. Sebbene lo scarto fondamentale arrivi da Rifkin, Baum continua. Baum è anche qui uno scrittore disadattato. Egli sente di non potere vendere aria fritta come il suo figliastro-rivale, scrittore vacuo e più che venerato. La sua vita intellettuale e sentimentale è segnata dall’emarginazione e dall’umiliazione: non vanno più di moda i grandi temi, non c’è più un terreno comune su cui intendersi con la sua compagna né con il mondo. Nessuno è più interessato a Dostoevskij né a Kafka: ai grandi temi si preferisce l’intrattenimento. Vince la trama, la letteratura consolatoria. E di fronte a questo disfacimento, Baum, continuando a vivere come se il Novecento non fosse passato, appare come un velleitario, un eremita, un pazzo patentato. Che parla perfino da solo.
Ma, al contrario di Rifkin – ecco la differenza – non si rassegna. Una volta che il caso gle ne offre l’occasione, passa all’azione, scegliendo di non arrendersi all’evaporazione della Verità. A essa si appella per avere ragione, come si sarebbe fatto nel suo Novecento. Agisce così con un doppio obiettivo, salvare la purezza d’animo e la buona fede di una persona cara che sta per cadere vittima di un raggiro e per non far prosperare gli imbroglioni, in modo che le due cose – dimensione esistenziale e politica – vengano a coincidere nell’azione. E lo fa senza pensare alle conseguenze.
Ingaggia una lotta apocalittica contro il suo tempo comportandosi eroicamente. Finisce in manicomio ma vince. Chi lo avrebbe detto?