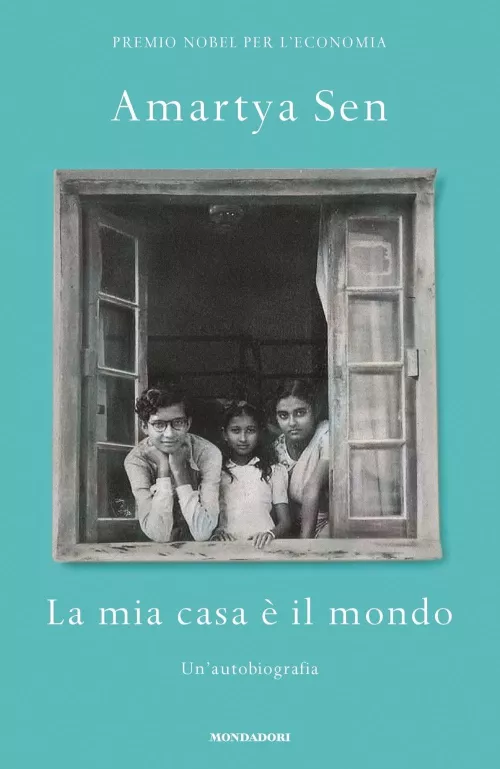Autobiografia / Amartya Sen: cittadino indiano nel mondo
Nel 1953, non ancora ventenne, si imbarca sulla SS Strathnaver, un transatlantico della P&O che svolge un regolare servizio passeggeri tra Brisbane nel Queensland australiano e Tilbury in Essex. La ragione del lungo viaggio via mare è strettamente economica: pur prevedendo una sistemazione confortevole – incluso il vino a pasto e perfino la possibilità di giocare tutte le sere a bingo, a condizione di essere disposti a svagarsi con “il gioco più noioso al mondo” – la crociera di quasi tre settimane costa molto meno del più economico dei voli operati dalla BOAC, la progenitrice della British Airways. Gli erano serviti due giorni di viaggio da Calcutta per raggiungere l’imbarco a Bombay, su un treno affollato il cui clima festoso gli aveva ricordato le scene iniziali di Riso Amaro, un pensiero “abbastanza sinistro” sapendo come finisce il film con Silvana Mangano. Dopo una tappa ad Aden e l’attraversata del Mar Rosso, la SS Strathnaver si ferma a Suez per un giorno intero, rendendo possibile un’escursione a terra. Mentre aspetta in fila tra due gruppi di uomini che si lamentano rumorosamente della lentezza con cui le autorità egiziane permettono lo sbarco, un funzionario di frontiera lo avvicina e gli chiede di dove sia: una volta saputo che è indiano, lo fa scendere immediatamente a terra e salire su uno degli autobus in cui è in attesa un gruppo di persone di colore.
“Questa è stata l’unica occasione in tutta la mia vita in cui la mia cittadinanza indiana mi abbia garantito un trattamento di riguardo ai controlli di frontiera. … Non capii allora quanto si sarebbe rivelato inconsueto questo trattamento di favore”. Tre anni dopo, la fallimentare spedizione anglo-francese a Suez avrebbe simbolicamente segnato la fine dell’impero britannico.
Quel giovane era Amartya Sen, oggi professore di economia e filosofia all’Università di Harvard, ultimo approdo di una straordinaria carriera culminata con il Premio Nobel per l’economia nel 1998, che l’ha visto insegnare all’Università Jadavpur di Calcutta, alla Delhi School of Economics, alla London School of Economics e all’Università di Oxford e ricoprire il ruolo di Master del Trinity College a Cambridge. L’episodio è narrato da Sen in un passaggio significativo di Home in the World: A Memoir, il bellissimo volume di memorie pubblicato lo scorso anno (Allen Lane, 480 pagine) e appena tradotto in italiano con il titolo La mia casa è il mondo. Un’autobiografia (Mondadori, traduzione di Aldo Piccato, 540 pagine).
Il viaggio dall’India all’Inghilterra rappresenta narrativamente la cerniera tra gli anni in cui Sen è cresciuto, si è formato e ha studiato fino alla laurea e gli anni in cui, in una Cambridge ai vertici dell’eccellenza accademica mondiale, maturerà una profondità di pensiero che lo pone tra i più grandi e influenti intellettuali contemporanei, non solo nelle discipline economiche. D’altro canto, l’episodio di Suez coglie uno dei temi centrali del libro, quello dell’importanza dell’identità, nel bene e nel male.
Sen nasce nel 1933 a Santiniketan, a casa dei nonni materni. Passa i primi anni di vita a Dacca nel Bengala orientale, oggi Bangladesh, e poi a Mandalay in Birmania, dove il padre Ashutosh insegna chimica all’università. Al ritorno della famiglia a Dacca, a sei anni viene iscritto alla St. Gregory’s School, un istituto prestigioso gestito da padri missionari secondo canoni tradizionali e fortemente competitivi che poco si adattano alle sue inclinazioni. Sen racconta divertito come, partecipando a una celebrazione in suo onore dopo aver ricevuto il premio Nobel, il preside della scuola avesse scoperto sconsolato che i suoi voti lo classificavano al 33° posto tra i 37 studenti della sua classe.
L’invasione giapponese di Burma e il timore dei possibili bombardamenti aerei su Dacca o Calcutta, convincono il padre che sarebbe stato più sicuro per lui continuare gli studi in una piccola località come Santiniketan. Così, nel 1941 Sen ritorna al paese natio e vi inizia a frequentare Visva-Bharati, la scuola sperimentale e progressista fondata nel 1901 dal poeta Rabindranath Tagore, il primo scrittore non europeo a ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1913. È un ambiente completamente diverso dalla St. Gregory’s School, in cui è lasciata ampia facoltà agli studenti di scegliere cosa studiare, sono proibite le punizioni fisiche e le lezioni si tengono generalmente all’aperto, tra gli alberi, affinché nulla possa imprigionare il pensiero, neanche i muri della scuola.
A diciotto anni, Sen si iscrive al Presidency College di Calcutta dove studia matematica ed economia, disciplina quest’ultima che finisce per scegliere al posto di fisica perché più vicina ai suoi interessi sociali e al suo impegno politico. “Calcutta è una città fantastica per le chiacchiere oziose – ciò che i bengalesi chiamano adda – una discussione libera, senza alcun ordine prestabilito, su qualsiasi tema che possa saltar fuori”. Nel clima multiculturale della città, ricca di teatri, caffè e librerie ben fornite, gli capita tra le mani un libro appena pubblicato che si rivelerà fondamentale per il suo futuro percorso intellettuale: Social Choice and Individual Values di Kenneth Arrow (Wiley, 1951). Il teorema di impossibilità di Arrow – secondo cui, in estrema sintesi, nessun sistema non dittatoriale di scelte sociali può generare decisioni coerenti o utilizzabili, una volta accettati pochi postulati apparentemente ragionevoli – gli appare come una sfida per l’India appena divenuta indipendente e alla ricerca della democrazia: “potevamo avere un coerente processo democratico, o era quella una chimera?”. Nei decenni seguenti dedicherà molta della sua ricerca a sviscerare questo tema, chiarendo, come recita la motivazione del premio Nobel, “le condizioni che consentono l’aggregazione dei valori individuali in decisioni collettive e le condizioni che consentono che le regole per la formulazione di decisioni collettive siano coerenti con una sfera di diritti per l’individuo”.
Dopo la laurea a Calcutta, prosegue gli studi al Trinity College a Cambridge, dove rimane dal 1953 al 1963. È spinto a questa scelta dal padre, che aveva egli stesso conseguito il dottorato in Inghilterra, e decide di far domanda solamente per il Trinity College perché lì erano Maurice Dobb (“l’economista marxista più creativo del XX secolo”), Piero Sraffa (“un grande pensatore sia in economia sia in filosofia, che era stato amico intimo e collaboratore del grande intellettuale marxista Antonio Gramsci”) e Dennis Robertson (“il principale economista utilitarista e un brillante pensatore conservatore”). A Cambridge rivive il gusto per il dibattito intellettuale degli adda iscrivendosi ai tre club socialista, liberale e conservatore (non a quello laburista perché incompatibile per statuto con l’appartenenza al club socialista), oltre a far parte degli Apostoli, l’esclusivo gruppo cui avevano partecipato, tra le tante personalità, Bertrand Russell, G. E. Moore, Ludwig Wittgenstein, Frank Ramsey, John Maynard Keynes, Lytton Strachey, E. M. Forster.
Quelle frequentazioni e ovviamente gli studi universitari gli permettono di incontrare molti studiosi e intellettuali di primo piano, dei quali nel volume fornisce ritratti brillanti ed eleganti. Non mancano aneddoti che oltre a delineare il carattere dei protagonisti, danno il senso della particolare atmosfera che si respirava a Cambridge a quel tempo. Tra i tanti, ne scelgo uno che coinvolge i tre studiosi che lo avevano attratto in quell’università. Stando a un racconto di Sraffa, quando Robertson offrì a Dobb una posizione al Trinity College, questi prontamente accettò, salvo poi sentirsi in dovere di avvertirlo che lui era iscritto al partito comunista britannico e che avrebbe compreso se Robertson avesse ritenuto di ritirare quell’offerta. Roberstson si limitò a rispondergli: “Caro Dobb, purché tu ci dia un preavviso di quindici giorni prima di far saltare in aria la cappella, non ci sono problemi”.

Le pagine dedicate al periodo cantabrigiense sono ricche di considerazioni sui temi di economia e filosofia che Sen ha studiato durante la sua vita accademica. Le osservazioni sulle persone con cui viene a contatto, tra le quali Sraffa, occupano un posto preminente, sono esse stesse rivelatrici del pensiero di Sen. Preferisco però tornare alla prima parte del libro in cui Sen racconta gli anni giovanili perché da un lato ci dà un’idea del milieu in cui è cresciuto, quello di una borghesia colta e impegnata, benestante ma non ricca, e dall’altro ci porta a comprendere la ricchezza di una cultura antichissima come quella indiana.
Sen alterna il ricordo meticoloso e partecipe delle vicende personali e familiari con ampie e meditate digressioni, soprattutto sulla situazione sociale e politica dell’India nel periodo cruciale in cui ne veniva maturando l’indipendenza.
Della madre Amita ricorda che da giovane aveva praticato il judo e aveva interpretato il ruolo di prima ballerina in vari spettacoli di Tagore, qualcosa che non si addiceva a quel tempo alle ragazze di buona famiglia. Tagore è una presenza fondamentale, seppur non direttamente ma attraverso l’eredità del suo pensiero, poiché Sen si trasferisce a Visva-Bharati appena dopo la morte del poeta. Il nonno materno Kshiti Mohan Sen emerge come la figura più influente sulla sua crescita intellettuale negli anni dell’adolescenza: grande studioso di sanscrito e uno dei più stretti collaboratori di Tagore, lo introduce a una lettura pluralista e non elitaria della letteratura e filosofia indiana, attenta alla tradizione popolare orale, fino a fargli scoprire il filone agnostico e ateo del corpo dottrinale dell’induismo. Sen parla di innumerevoli parenti, amici e conoscenti e racconta come vari zii e cugini fossero impegnati, in modi e partiti diversi, nell’opposizione alla dominazione inglese e per questa ragione fossero spesso imprigionati, per lo più in base alla pratica coloniale ampiamente utilizzata della detenzione preventiva.
Questi ricordi personali sono continuamente plasmati dalle circostanze drammatiche che scuotono l’India in quegli anni. Il dramma dei violenti scontri tra le diverse comunità, in particolare quelle induista e musulmana, che insanguinarono la colonia britannica negli anni quaranta e poi portarono alla sua “partizione” tra India e Pakistan al momento dell’indipendenza, gli si manifesta in tutta la sua tragicità quando nel 1944 un uomo sanguinante e urlante per il dolore entra nel giardino della sua casa e gli chiede aiuto. Quell’uomo aveva avuto il solo torto di andare a cercare lavoro, spinto dalla fame e dalla povertà della sua famiglia, in un quartiere hindu, dove era stato accoltellato a morte unicamente perché musulmano. Vi era, nota Sen, un forte connotato di classe in quegli eventi, poiché le vittime di quegli scontri provenivano in gran parte dalle classi popolari.
Era d’altra parte il risultato di una divisione artatamente costruita su basi comunitarie e religiose, contraria a una secolare tradizione di convivenza che aveva visto le classi medio alte induiste fiorire senza dover rinunciare alla loro fede al tempo della dinastia musulmana dei Mughal: l’imperatore Akbar predicava ad Agra l’importanza della tolleranza religiosa nella seconda metà del XVI secolo, quando a Roma Giordano Bruno veniva condannato al rogo per eresia. Alla fine, circa un milione di persone morì negli scontri tra le diverse comunità, migliaia di donne furono stuprate e quindici milioni di persone furono costrette a lasciare le loro case. Non meno drammatico è il racconto dell’ultima tragica carestia che colpì il Bengala nel 1943, nella quale perirono tra due e tre milioni di indiani. Come Sen ha mostrato in uno dei suoi libri più famosi (Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, 1981), la carestia dipese non dalla mancanza di beni alimentari, ma dalla loro cattiva allocazione: “la fame è caratterizzata dal fatto che le persone non sono in grado di acquistare cibo a sufficienza sul mercato – non dal fatto che non ve ne sia a sufficienza nel mercato”. Anche questa fu una calamità di classe, che non colpì le famiglie anche moderatamente benestanti, e che fu resa possibile, almeno in parte, dal silenzio dei mezzi di stampa, sottoposti alla stretta censura imposta dal governo coloniale britannico per non compromettere lo sforzo bellico.
Alla dominazione britannica Sen dedica alcune delle pagine più efficaci del libro, non a caso pressoché integralmente anticipate sul quotidiano inglese The Guardian. La sua condanna è senza appello, nonostante la passione e il rispetto per la cultura inglese che permea l’intero volume. Egli riconosce che l’India alla metà del XVIII secolo fosse più arretrata rispetto ai paesi dell’Europa, a dispetto dei grandi progressi raggiunti nel passato nella scienza e nella cultura ma anche nella sfera economica, e che avesse bisogno di un cambiamento radicale. Da ciò non discende però che il dominio britannico fosse l’unico modo di ottenerlo. Per Sen, l’India aveva bisogno di una “globalizzazione costruttiva” fatta dello scambio con il mondo esterno delle idee così come delle merci, come aveva fatto per secoli. Non è dato sapere come il paese si sarebbe evoluto se non fosse finito sotto il giogo della Compagnia delle Indie e sarebbe sbagliato fondare questo esercizio “contro fattuale” sullo stato del paese al momento della conquista, implicitamente ipotizzando che non vi sarebbe stato alcuno sviluppo. Né gli acclamati risultati di duecento anni di dominio britannico possono dirsi davvero effettivi, almeno non prima che l’India avesse guadagnato l’indipendenza. Una democrazia multipartitica e una stampa libera, forse gli aspetti più importanti dell’eredità britannica, sono inconciliabili con un regime coloniale: essi sono sì garanzia di libertà, ma per i dominatori, non per i sudditi dell’impero.
Le memorie di Sen rappresentano un’introduzione accessibile, elegante e accattivante al suo pensiero. Il racconto della sua formazione rivela quanto sia radicato nella sua esperienza giovanile l’interesse per alcuni dei temi a lui più cari: l’importanza della discussione pubblica e della persuasione per migliorare il processo decisionale in una democrazia; il ruolo della libertà di stampa nel prevenire le carestie e più in generale gli eventi drammatici che tendono a colpire soprattutto le classi più svantaggiate; l’interazione tra le condizioni economiche (la classe) e le identità collettive nel determinare gli esiti politici e sociali; la necessità di riconoscere le molte identità delle persone e contrastare il ruolo distruttivo di un’identità dominante basata sull’appartenenza a una religione, a una comunità, a una nazione. Certo, è una ricostruzione a posteriori, in cui il ricordo è filtrato, forse alterato, dai decenni di ricerca successiva, ma la vividezza del racconto mantiene intatta la sua forza evocativa. Vi riconosco Sen e il suo modo di argomentare, che scriva dei fiumi del Bengala (capitolo 2), che si domandi che fare del pensiero di Marx (capitolo 13), oppure che affronti la spinosa questione del rapporto tra malato e medicina nel racconto del carcinoma alla bocca che lui stesso si diagnosticò quando era studente a Calcutta (capitolo 14).
Il titolo del libro, che si ispira a quello di un libro di Tagore, The Home and the World (Macmillan, 1921), cattura l’essenza di Amartya Sen: un uomo che non ha mai rinunciato ad avere solamente la cittadinanza indiana, nonostante le difficoltà pratiche che questo ha spesso comportato, e che pure si è sempre trovato a proprio agio nei paesi in cui è vissuto. La sua prima visita da giovane turista, una volta giunto in Inghilterra, è in Italia, un paese cui si sentiva legato dall’attrazione per le opere del Rinascimento, dall’interesse per la Resistenza e le sue vicende politiche e dal fascino del cinema neorealista, come rivela il riferimento a Riso Amaro. Il viaggio effettuato in compagnia di alcuni studenti stranieri è un successo. A Sen piacciono l’arte e il cibo, il rumore e la convivialità della vita italiana: “Una notte – penso a Perugia – sono stato svegliato da una rumorosa conversazione nella strada sotto la mia finestra. Ho perso un po’ di sonno, ma ho apprezzato questa prova che vi fosse vita. A colazione la mattina dopo, ero l’unico che non si lamentava del chiasso degli italiani. Mi era piaciuto quanto poco fossero repressi”.
Nella primavera del 1996 mi è capitato di frequentare quasi giornalmente Sen, in un periodo in cui era visiting scholar presso il Servizio Studi della Banca d’Italia. Leggendo il racconto dell’episodio di Perugia, la mia memoria è andata immediatamente a una serata in un’affollata trattoria di Testaccio a Roma e a come Sen vi si fosse trovato perfettamente a suo agio a discorrere di economia, politica e tanto altro, nonostante la confusione e il rumore. A dispetto della lunga frequentazione del nostro paese, Sen non parla italiano (neanche francese, perché, come mi ha detto una volta, una lingua coloniale basta). Ciò nonostante durante la sua permanenza a Roma riuscì a stabilire un rapporto diretto con tutti in Banca d’Italia: ricordo che gli addetti della mensa lo salutarono calorosamente come un vecchio conoscente quando li salutò alla sua partenza, benché avessero comunicato solo per gesti e sorrisi. Non so se l’abbia imparato a Santiniketan o se sia una dote innata, ma non ho dubbi che la grande umanità di Amartya, unita alla sua straordinaria intelligenza, sia stato ciò che gli ha reso possibile sentirsi sempre un cittadino indiano nel mondo.
* Banca d’Italia, Dipartimento Economia e statistica. Le citazioni dal libro di Sen sono mie traduzioni dalla versione inglese. Le opinioni qui espresse sono mie e non riflettono necessariamente quelle della Banca d’Italia.