Bartezzaghi. Combustioni sedicenti innovative
‘Novità’ non è anagramma di ‘vanità’. Ma ci si approssima molto, e sotto sotto ambirebbe esserlo. Sta qui, per molti versi, il senso dell’ultimo libro di Stefano Bartezzaghi, Il falò delle novità (Utet, pp. 238, € 12,00), che pone il problema già dal titolo, facendo il verso a quello del celebre romanzo di Tom Wolfe, ma anche, più indietro, al celebre episodio savanaroliano che lo ha ispirato o, più avanti, al bel film che Brian De Palma ha tratto dal libro. Difficile pensare che Bartezzaghi – che sui titoli riflette settimanalmente in una sua specifica rubrica, per non parlare degli anagrammi, alla cui realizzazione dedica gran parte della sua più verace esistenza – non abbia volutamente giocato con questo piccolo slittamento di significante, assai produttivo in termini di significato. Dunque: è vanità rincorrere le novità. Ma anche e soprattutto: quello a cui oggi assistiamo è un vero e proprio falò delle novità, analogo se non peggiore di quello delle vanità. Al rogo l’originalità, l’arditezza, l’inventiva. E dunque sotto processo – benevolo e accigliato al tempo stesso – il fenomeno (in tutti i sensi del termine) della creatività. La quale del resto viene assai spesso descritta come una scintilla prodotta da uno spinterogeno: da cui, ancora una volta, il falò prossimo venturo. L’epigrafe del libro è una citazione da David Lynch: “fire, walk with me”. E nell’ultima pagina, a testo concluso, affiorano alcuni versi di Valerio Magrelli: “Io cammino fumando / e dopo ogni boccata / attraverso il mio fumo / e sto dove non stavo / dove prima soffiavo”

Così, dinnanzi all’inesausto rifiorire del mito della creatività, illimitata carta di credito per fiere, saloni, festival, ‘eventi’ d’ogni tipo, l’autore del relativamente recente L’elmo di Chisciotte, argomentato pamphlet – chiariva il sottotitolo – contro la mitologia della creatività, non si dà pace. E compie un nuovo, calcolato gesto strategico per riprendere in mano, con sufficiente arditezza, la vessata questione: quello di spostarsi sul piano metalinguistico, o se si preferisce meta-teorico, discutendo non tanto della creatività come tale ma dei modi in cui può essere, ed effettivamente viene, definita dai più. Partendo da un corpus di circa duecento tweet atti a fornire una stringata descrizione del concetto, Bartezzaghi ricostruisce una complessa, argomentata, minuziosa tipologia dei modi in cui la creatività viene oggi pensata – o meglio, poiché spesso legata a idee ricevute, si crede di pensarla.
Classificazione certosina, analizzata sin nei più piccoli dettagli linguistici e semiotici, da cui emergono alcune interessanti costanti: ogni tentativo di definire la creatività, volente o nolente, mette in scena una coppia di termini opposti – per esempio: regolare e irregolare, effabile e ineffabile, calcolo e intuizione, vecchio e nuovo, originale e banale, retorica e antiretorica, attivo e passivo, catastrofe e continuità … – che in qualche modo convivono entro la capacità creativa e si estrinsecano nell’atto creativo medesimo. La logica della creatività, ne deduce allora Bartezzaghi, non è quella di non averne, come pure potrebbe sembrare; ma, molto diversamente, coincide con la classica razionalità della mitologia: la quale ammette, anzi ha bisogno, dell’antinomia per potersi produrre e riprodurre, affermare e trasformare. Da qui la continua epifania di ossimori e contraddizioni che la creatività è come costretta a mettere in gioco. Vissuti però, più che come opposizioni statiche, come altrettanti tentativi di passare da un termine al suo contrario; e dunque come vere e proprie storie che narrano di una metamorfosi possibile, di un costante dinamismo da storytelling grazie al quale nell’opacità del quotidiano emerge una macchia di colore, dalla banalità del vissuto emerge una discontinuità, piega o frattura a seconda dell’intensità, che lascia ben sperare in una svolta qualunque, ora verso il passato verso cui nostalgicamente ritornare ora verso il futuro a cui confusamente aspirare.
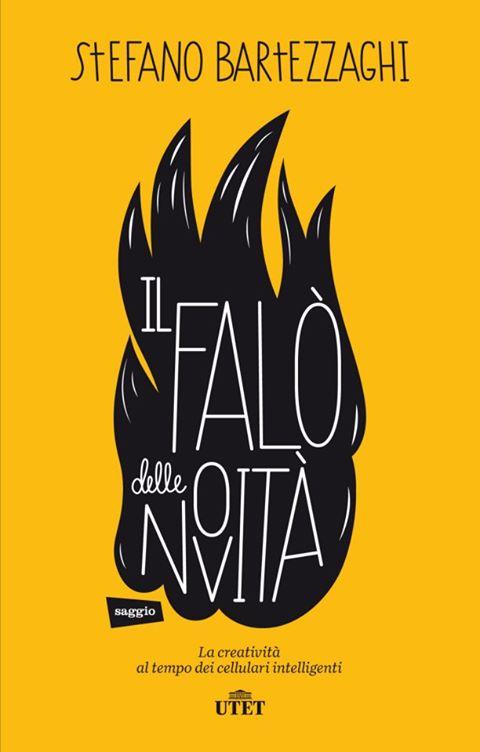

Questa serie di contraddizioni sottesa a ogni illogica logica della creatività, più o meno velata, più o meno dinamica, ha comunque una sua precisa ragion d’essere. Per Bartezzaghi, sta tutta nel passaggio – lessicale e antropologico nello stesso tempo – della creazione alla creatività: che è la dipartita storica dal mondo dell’arte (che, come tale, della pura inventiva non ha necessariamente bisogno) e il successivo approdo nell’universo dei consumi (che della pira del nuovo a ogni costo invece si pasce). La società dei consumi, respirando le maleodoranti esalazioni della morte dell’arte, impone il rinnovamento costante dei desideri spacciandoli per bisogni: per farlo, ha bisogno di moltissima capacità creativa.
L’impressione che se ne ricava, a conti fatti, è che le mitologie della creatività, messe in gioco nello spazio euforicamente conciso di twitter, siano vecchissime. Assai tradizionaliste, se non reazionarie. Apocalittiche e integrate nello stesso momento. È come se si rivendicasse, con ostentata volontà creativa, una specie di capacità diffusa ad andar contro il grigiore quotidiano, tutto fatto di massificazione forzata e astuto dominio della meccanica, capitalismo duro e industria devastatrice. La tecnologia, per esempio, viene per lo più ottusamente percepita come il nemico, mai in sé fonte di possibile inventiva ma semmai causa dei peggiori mali del mondo e dell’esistenza, e perciò nemico da combattere… creativamente. Idea veicolata, manco a dirlo, da una tecnologia, che è quella dei cellulari sedicenti smart coi quali cinguettare a più non posso.
Del resto, Wolfe e De Palma avevano già perfettamente narrato il destino di ogni falò delle vanità/novità. Alla fine, lo spregiudicato broker Sherman McCoy perde tutto e ritrova l’anima. Mentre Peter Fallow, giornalista alcolizzato, trova tutto e perde l’anima. Soluzioni? Una forse sì, e sta alle pagine 165-166: “Un’alternativa reale, però, c’è: è meno deprimente, e, al contrario di quella della rassegnazione, contesta radicalmente il processo mitologico della creatività e non si limita ad accomodarsi nella posizione terminale che il processo stesso prevede. Consiste nel cessare di perseguire il mito della creatività non per esaurimento delle energie ma perché si smette di esigere e mitizzare il nuovo e il distinto in quanto tali. È l’unico modo di togliere ossigeno al falò delle novità. Giorgio Morandi non si annoiava a dipingere quelle che possono apparire come le stesse (e banali) bottiglie: l’oggetto della sua ricerca non era l’originalità di superficie, ed esibita. Come qualsiasi altro artista, non pensava al mass marketing, ma a un pubblico disposto a comprendere il suo linguaggio. Le sue soluzioni espressive non si sono imposte per la loro novità, ma per la loro forza”.







