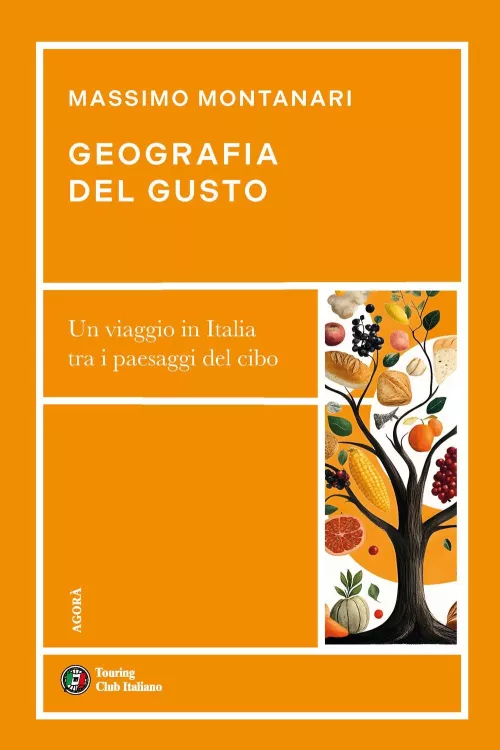Speciale
Il gusto della geografia
Che cos’è un terroir? In Francia, dove la cosa è un mostro sacro, la parola sta a indicare, come è noto, non soltanto un territorio fisico, la mineralità del suolo, la composizione geologica e biologica del terreno, il microclima, ma anche chi lo lavora e lo ha lavorato, plasmandolo secondo abitudini, gusti, tradizioni e valori locali: colture sì, ma anche culture; non solo geografia ma anche storia. Concezione che dal mondo del vino s’è estesa a quello agro-alimentare in generale.
Deve aver preso alla lettera tale questione Jannick Alléno, pluristellato cuoco francese, ristoranti un po’ dovunque nell’Esagono e oltre, che alcuni anni fa ha pubblicato un libro di ricette intitolato Terroir parisien, dove propone di usare esclusivamente prodotti dell’Ile de France. Una metropoli ripensata come terroir? Basteranno gli orti urbani e la buona volontà di un pugno di agricoltori residenti in città a giustificare questa terminologia che sa di provocazione? Non esageriamo con la retorica del chilometro zero? E che ne pensano i produttori della Borgogna, della Provenza o della Linguadoca? Vale ancora la diade città/campagna?
In un’intervista al prestigioso mensile L’Histoire, su di un numero interamente dedicato a “La cuisine et la table: une culture française”, Alléno è tornato sulla questione. Innanzitutto, alla domanda di rito circa l’innovazione gastronomica, lo chef risponde in un modo che piacerebbe a Tim Ingold: il futuro sta alle nostre spalle, nel nostro passato. Oggi, spiega, usiamo in cucina non più del trenta per cento delle materie prime che venivano utilizzate a inizio Novecento da quel maestro assoluto che era Auguste Escoffier. A fronte di una patente apertura alle cucine di tutto il mondo (e per i francesi è un peso niente male), la tradizione parigina viene rimossa… Da qui, appunto, la ricerca di ingredienti e alimenti prodotti a Parigi: “Bisogna immaginare le campagne intorno a Parigi, cioè nella capitale, sino agli anni Trenta del Novecento. C’era un’enorme produzione agricola di birra. C’erano orti, mercati agricoli, vigneti magnifici. Il terroir parigino era straordinario: una delle immagini feticcio in merito è la fotografia di un orto proprio sotto la Tour Saint Jacques dove si coltivavano zucche superlative”. E oggi? Alléno è un fiume in piena: “Troviamo piselli a Clamart, asparagi a Argenteuil, ciliegie a Montmorency, pesche a Montreuil. Si possono fare delle meraviglie col terroir parigino. Come la poire marquise di Escoffier”. Eppure, manco a dirlo, gli interessi immobiliari marciano in direzione opposta: gli agricoltori vengono cacciati via, anche violentemente, per far posto a nuovi investimenti, a nuove costruzioni. Come dire che, se l’innovazione sta nel recupero della tradizione dimenticata, la tradizione è una invenzione non riuscita abbastanza.
Ci aiuta a capire il senso di tutto questo il nuovo libro di Massimo Montanari intitolato Geografia del gusto e pubblicato dal Touring club. A un grande cuoco che si interroga sulla storia, risponde un grande storico che discute di geografia. Ma non è un gioco delle parti: comprendere un territorio, e anche soltanto il suo concetto, è arretrare lo sguardo inserendo il tempo nello spazio. “Il paesaggio – leggiamo difatti – non è semplice geografia fisica, ma geografia ridisegnata dalla storia”. Cosa che vale per il passato come per il futuro: da un lato ci volgiamo indietro per ricercare lo spazio perduto; dall’altro guardiamo avanti per ritrovare i territori dimenticati. In mezzo sta il presente, epoca di una globalizzazione compiuta che, per nulla paradossalmente, proprio perché vincente, genera per contraccolpo una certa quantità di resistenze (etiche, estetiche, politiche: cioè gastronomiche) più o meno forti, come quella che porta a “un attaccamento a forme di identità locale e di affezione ai territori” da vivere come “conquiste da fare ogni giorno con tenacia e consapevolezza”.
Il libro di Montanari è ricco di informazioni e di idee. Qui ci riguarda per due punti molto precisi. Il primo, niente male, è che, se l’idea di terroir nasce e cresce a partire dalla volontà di salvaguardare le bio- ed etno-diversità (ogni terroir ha le sue caratteristiche colturali e culturali), è pur vero che possiamo ritrovare, storicamente e geograficamente, alcuni modelli generali a cui molti di essi possono essere ricondotti. In tal modo le ripartizioni geografiche sono molto variabili, più o meno grandi, più o meno piccole. Così se, come è noto, la cucina italiana si è sempre caratterizzata dal mettere insieme varietà territoriali diverse, di modo che le ricette sono spesso battezzate “al modo di” una certa realtà geografica (“alla romanesca”, “alla fiorentina”, “alla lombardescha”, “alla zenovese” etc.), tale realtà geografica può essere ora una singola città, ora un paesello, ora una piccola contrada, ora invece un intero stato. Quasi mai una regione. L’idea di cucina regionale, in Italia, è assai recente: ha poco più d’un secolo. A lungo hanno funzionato piuttosto due modelli opposti. Da una parte, nel Nord, l’Italia delle città, con una loro autonomia e identità, anche e soprattutto gastronomica, senza alcun potere centrale che le risucchi. Dall’altra, nel Meridione, un potere unico e fondamentale, a Napoli, e una miriade di piccolissimi paesi che, gravitando intorno alla capitale, si fanno portatori di alimenti, ingredienti, piatti specifici. Il primo è un modello decentrato, il secondo esattamente il contrario. Cambiando la scala, cambia tutto.

Così, nel primo caso, ecco la gallina padovana, il prosciutto di Parma, la mortadella bolognese, il tartufo di Alba, l’aceto balsamico di Modena, l’insalata romana, il radicchio trevigiano etc., ma anche, passando dai prodotti alle ricette, il risotto alla milanese, il fegato alla veneziana, il pesto alla genovese, la bistecca fiorentina, i saltimbocca alla romana, la pizza napoletana e così via. Dove assai poco importa stabilire come e perché vengono fuori queste indicazioni di tipicità urbane. Il radicchio o l’insalata, con buona pace di Alléno, si coltivavano ovviamente nelle campagne extraurbane ma si vendevano nei mercati cittadini. Analogamente, il parmigiano porta il nome di Parma per ragioni politiche (prima si chiamava lodigiano), mentre la parmigiana di melanzane ha poco a che vedere con la medesima città. È la circolazione delle materie prime e dei piatti che conta, non la loro origine fisica.
Il modello concentrato del Meridione d’Italia funziona in tutt’altro modo. Laddove al Nord lo sviluppo delle singole città aveva portato a una specie di occultamento delle campagne, la precoce affermazione di un Regno centralizzato portava invece a una loro messa in rilievo. Nel 1692 il ricettario di Antonio Latini, il più importante dell’epoca, si chiude con una descrizione gastronomica del Regno di Napoli: da cui un lunghissimo elenco dove appaiono cose come i finocchi di Poggio Reale, le verdure di Padula, i cavolfiori di Chiaia, le insalate di Posillipo, i cocomeri di Orta, le soppressate di Nola, il torrone di Aversa, i meloni di Cardito, le olive di Gaeta, i cardoni di Giugliano, i fichi secchi di Agropoli, le trote di San Severino, i capponi di Nocera, e via continuando per un altro paio di pagine. Come si vede, le località nominate sono prevalentemente rurali, piccoli paesi, una miriade di centri minori e villaggi agricoli sparsi per il territorio, ognuno dei quali portatore di specialità che, tutte, finivano per riunirsi nei mercati e nelle tavole della capitale. Qui le altre città, che pure esistono (Bari, Salerno, Teramo…), contano assai poco. Conta piuttosto il mosaico di prodotti che si incamminano verso Napoli, e da lì, rielaborati sotto forma di ricette e pietanze, vanno in giro per la Penisola intera.
Il secondo punto che ci interessa non è da meno. Montanari insiste molto sul fatto che l’idea – e la relativa pratica – di cucina del territorio è moderna. La storia della cucina, popolare e d’élite, è a lungo stata l’insieme dei tentativi, spesso felicemente riusciti, di uscir fuori dal territorio, andando alla ricerca di specialità prodotte altrove, di materie prime, per così dire, extraterritoriali. Abbattere i confini geografici, far circolare merci e sostanze, era imperativo categorico. E l’obiettivo, del ricco come del povero, era quello di importare ed esportare di continuo, creando ibridi geografici sotto forma di altrettanti manicaretti. Mangiare fuori stagione e fuori territorio era il non plus ultra. Ed era proprio questa pratica, alla fin fine, a generare la tipicità, a costruire l’identità di un ingrediente o di una pietanza. Il fegato alla veneziana, una volta assaporato a Firenze, diventava riconosciuto come tipico di Venezia, e diventava tale. Il contrario con la bistecca fiorentina, che, consumata a Milano, diventava fiorentina. In altre parole, per esserci cucina di territorio, è necessario che se ne esca fuori: se un prodotto resta sempre e soltanto locale, non è tipico: prodotto e consumato, direbbe Catarella, in loco, non assume alcuna identità caratteristica. A creare l’identità, a costruire una tipicità, è sempre lo sguardo dell’altro: lezione che la cucina tiene costantemente, con tutte le ricadute forse filosofiche e sicuramente politiche facilmente immaginabili.
Del resto, gli americani pensano che la pizza l’abbiano inventata loro. Ed è vero due volte. Come ha chiarito Luca Cesari nella sua Storia della pizza (qui la recensione), questa focaccia informe e poverissima è emigrata in USA insieme alle migliaia di poveracci che sognavano l’America. E come questi sono divenuti americani, lo è diventata anche lei, che da Brooklyn s’è diffusa nel mondo intero. Se non ci fosse stata la migrazione, delle persone e dei loro piatti, non ci sarebbe stata nessuna tipicità da custodire, rivendicare, magnificare alla bisogna. La geografia del gusto porta così al gusto della geografia: a patto di saperlo condividere, superando sciocchi campanilismi. La moda del terroir ha bisogno di questi spostamenti, traduzioni e tradimenti, pena l’insignificanza e l’insapore.
Viene da chiedersi allora: da dove guardare al terroir parigino? Se lo rivendichiamo, dobbiamo cancellare lo sciovinismo che da troppo tempo continua a covare nella gastronomia francese. Enfin! Alléno lo ha chiaro?
Leggi anche:
Gianfranco Marrone | Santi bagnati, bevitori asciutti
Gianfranco Marrone | Tra gli scaffali del supermercato
Gianfranco Marrone | Tre stelle a McDonald's
Gianfranco Marrone | Il panino: attenti a quei due!
Gianfranco Marrone | Dal tagliere alla città
Gianfranco Marrone | Cucina a vista e passioni tristi
Gianfranco Marrone | La pasta, questa conosciuta
Gianfranco Marrone | La rivoluzione wok