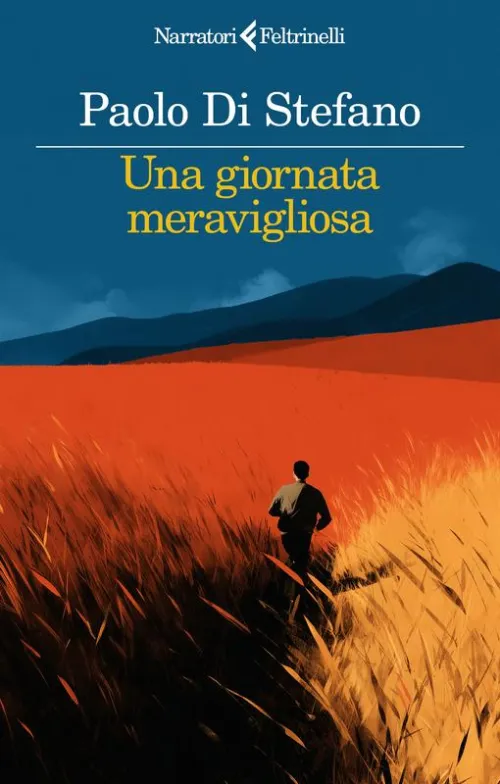Vite non illustri nell’Italia di oggi
Sebastiano Vassalli era solito ripetere come un mantra che non si può raccontare la contemporaneità perché ne verrebbe fuori solo rumore di fondo, brusìo fastidioso. Le voci – diceva – arrivano solo dal passato. Ecco, sembra che con il suo nuovo romanzo Una giornata meravigliosa (Feltrinelli, 2025) Paolo Di Stefano abbia voluto sfidare l’anatema del suo amico Vassalli e provare a fare romanzo proprio di quel brusìo. Per fare questo Di Stefano prende una giornata feriale dalle sette di mattina alle nove e mezza di sera e la riempie di personaggi dislocati perlopiù a Milano e in Sicilia, ma anche in altri luoghi e non luoghi come Whatsapp, Facebook, Instagram. Ci sono alcuni personaggi principali ma i loro segmenti narrativi sono polverizzati in un accumulo di storie minori, di notizie, di voci che si accavallano in un ritmo che ben evoca l’infinito formicaio umano, nella sua alternanza di tragedie e di situazioni comiche e grottesche, di dialoghi stupidi e intelligenti, di commozione e caricatura. E ci sono pagine in cui la congerie della varia umanità è chiamata in causa con lo schema di una famosa poesia di Prévert, poi passato in una ancora più famosa canzone di Jannacci (Ceux qui…, Quelli che…). Ma la vera invenzione che dà nerbo a questa rappresentazione di ordinary people è quella del «passante ubiquo». È attraverso di lui che noi veniamo a conoscere tutti i piccoli e grandi casi umani raccontati nel libro. La sua è una figura fantasmatica che saltabecca di qua e di là, sempre spaesato. La sua estraneità al mondo ci dà una fondamentale distanza di sguardo, ma anche un amore per la vita che solo chi ne sta fuori (o quasi fuori) può trasmettere in modo così forte. Il «passante ubiquo» viene dal mondo dei sospesi tra la vita e la morte, ma potrebbe essere un’ombra degli inferi come quelle omeriche e virgiliane, oppure un non nato. E anche se nel suo vagare incontra la pochezza e l’inanità delle vicende umane, la sua nostalgia per il mondo sembra inestinguibile. Naturalmente tutte le parti del libro che riguardano questa figura hanno un timbro linguistico molto particolare, intenso, interrogativo, vagamente enigmatico (ma niente di lirico-sacrale), si potrebbe dire profetico se possedesse le categorie di passato, presente e futuro, ma non le possiede.
Questa invenzione di un personaggio estraneo (o apparentemente estraneo) che muove e contrappunta la narrazione con una diversa “musica” proviene senz’altro dal romanzo precedente di Di Stefano: Noi. Lì il piccolo Claudio, morto bambino di leucemia, inseriva la sua voce (che spiccava per la scrittura in versi e per l’inchiostro rosso con cui le sue parti erano stampate) nella storia di famiglia raccontata in prima persona dal narratore. Erano interventi che spostavano il racconto, lo acceleravano andando al cuore delle ossessioni e dei sensi di colpa dell’autore. Il «passante ubiquo» è senz’altro figlio di Claudio, per quanto tra fantasmi si possa parlare di padri e di figli… Ma è più indistinto, come d’altra parte sono più indistinti i personaggi di questo romanzo rispetto a una precisa, quasi filologica storia di famiglia come era Noi. Ma per un fantasma l’indistinzione è una medaglia. In fondo Claudio, sia pure in modi diversi, faceva parte della storia familiare, mentre il «passante ubiquo», sì, alla fine può far parte di una delle storie del libro, ma è fondamentalmente il necessario punto di estraneità che permette di esistere, di prendere corpo a tutti i personaggi e le comparse del romanzo. Che sarebbero loro fantasmi senza storia se non ci fosse il «passante ubiquo» che si fa fantasma per loro, per riscattarli dalla loro insignificanza con la sua nostalgia per la vita. E ovviamente è anche la parabola del narratore e della letteratura.
Detto così, il libro può sembrare meno divertente di quel che è. In realtà nel romanzo ci sono pagine che fanno molto ridere e comunque il filo dell’ironia è una presenza quasi costante. Decisamente comico è il personaggio di Samantha, una ragazza di Catanzaro che mette su TikTok le descrizioni dei suoi pasti: «Buongiorno, stamatthina ho fatto golazione con il gaffè. Ma al posto di aggompagnarci il solido cornetthom con la nudhella, guesta matthina preferisgo la brioche alla grema». Un esempio di ironia pensosa è invece quando un personaggio legge sul cellulare una notizia intorno alla morte di Messina Denaro e si domanda se la definizione di «ex latitante» che gli viene attribuita dipenda dal fatto che è morto. Dunque ci saranno anche gli ex ingegneri, ex figli, ex madri, ex suicidi, ex malati terminali di cancro… E si conclude che l’unica cosa di cui non si può diventare ex è ex morti (a parte, Lazzaro e Gesù Cristo…). L’ironia si snoda generalmente su un innesco linguistico (spesso mimetico-caricaturale) e si impasta con tutto, anche con le parti più commoventi del libro, come quando viene comunicato alla moglie che il marito non è morto, come per «un increscioso equivoco burocratico» era stato comunicato in precedenza. E la parola «increscioso» diventa un leit motiv in cui si avvolge l’imbarazzo dell’impiegato mescolandosi con il turbinio di emozioni della moglie.
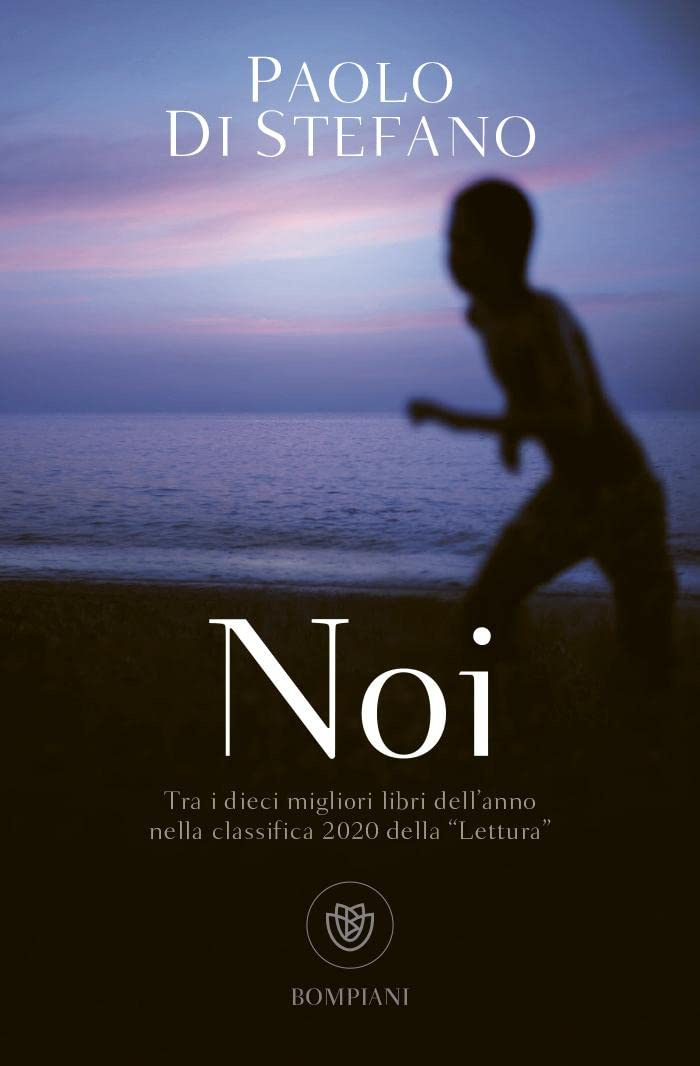
Molto del libro nasce dall’orecchio di Di Stefano, che sa cogliere e rifare “gli scritti e i parlati” di tutti mettendo in luce i toni, i registri, i tic non solo in chiave caricaturale (per esempio l’italo-francese dell’immigrato senegalese non ha niente di ridicolo).
Romanzo corale quant’altri mai, però qualche personaggio merita di essere presentato. E inizierei da Pino Resta, un ricercatore universitario in vacanza in Sicilia con la moglie, che scopre di avere vinto novantatré milioni di euro al Superenalotto. Prende in considerazione le cose che potrebbe fare con tutti quei soldi: comprarsi un Van Gogh, forse anche la Torre di Pisa, cinque isolotti sull’arcipelago di Dubai, un paio di ottimi calciatori da prestare alla sua squadra del cuore, una ventina di ospedali in Africa, un abbonamento a vita con escort orientali o sudamericane… Intanto vaga per i campi da solo, passa due notti in un grande albergo, non sa se tornare dalla moglie, dall’amante o da nessuna delle due. Non staremo a dire come va a finire. E poi Marco Trucco, impiegato regionale, la moglie Loredana e la figlia Carlotta, anoressica. E il loro gatto Gioi. I dialoghi fra il signor Trucco e Gioi (sì, perché Gioi risponde) sono fra le cose più belle del libro e riescono a dare una qualche sospensione alle parti più plumbee del romanzo, quelle legate al decorso clinico di Carlotta. E poi ci sono due personaggi ben conosciuti: un giornalista-scrittore, alter ego dell’autore, e un pittore famoso, che non è difficile individuare in Tullio Pericoli. I due si ritrovano nello studio del pittore, vanno a pranzo insieme, chiacchierano un sacco. Su temi generali come il tempo, la morte, la fama, ma anche su questioni più tecniche legate al mondo della pittura, che affascinano il giornalista perché gli sembrano appartenere a un mondo più artigianale rispetto a quello della scrittura. Ma c’è anche una discussione su come Pericoli abbia potuto fare un autoritratto dipingendo un paesaggio. E si intuisce che questo è proprio lo spunto teorico del romanzo. L’intenzione di sciogliere la scrittura del disegno collettivo ha prodotto il libro più dettagliatamente e coraggiosamente autobiografico di Di Stefano, in cui l’io è disseminato in personaggi maggiori e minori. E d’altra parte la vicenda relativa all’anoressia della figlia è nota perché Di Stefano ne ha già scritto pubblicamente.
Dunque la sfida che si diceva all’inizio – raccontare il brulichio del mondo contemporaneo – è in realtà qualcosa di più complesso, in cui autobiografia e quadro d’insieme convivono all’insegna della stessa perplessità e dello stesso desiderio di un lieto fine, che sarà sempre provvisorio. Nonostante qualche personaggio o situazione proveniente un po’ troppo direttamente dalle cronache (una ex famiglia albanese sul filo del femminicidio, il tormentone della pubblicità Esselunga, quella della pesca regalata dalla figlia al padre separato) direi che la sfida è vinta. Il quadro che viene dato della società italiana di oggi è variegato e tiene conto della realtà ormai multietnica. E il montaggio è sapiente e sa distinguere i fili che non vanno chiusi da quelli da chiudere perché è un romanzo aperto ma è comunque un romanzo, ed è nelle conclusioni che il romanziere-demiurgo deve sempre dare il suo meglio.
Un’ultima notazione: il libro si apre su un’epigrafe di Montale, dalla Casa dei doganieri: «Ed io non so chi va e chi resta». Alla fine, proprio all’ultima riga, il «passante ubiquo» dice: «E in tutto quel che ho visto io non so chi va e chi resta». Perfetta epanadiplosi. E ricordiamoci di Pino Resta, che è uno che va, o che vorrebbe andare… La confusione tra i vivi e i morti, da sempre, è uno dei temi dei romanzi di Di Stefano. Come anche, da sempre, Di Stefano usa la poesia come elemento suggestivo e cifra interpretativa: addirittura un verso di Caproni e uno di Saba sono stati i titoli di due suoi romanzi. Questo poteva anche essere intitolato Chi va e chi resta, ma credo che la scelta, alla fine, sia stata giusta perché Una giornata meravigliosa introduce fin dal titolo quella modalità ironica che abbiamo visto essere così importante per il libro. Se Patrizia Cavalli aveva intitolato il suo ultimo libro Vita meravigliosa, Di Stefano riprende quel tipo di sberleffo ma in minore. E comunque l’unico che potrà dire seriamente che la vita è meravigliosa è il «passante ubiquo».
Leggi anche:
Alberto Saibene | Tre domande a Paolo Di Stefano