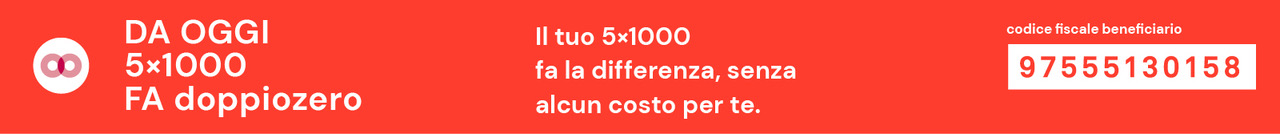La filosofia come esercizio / Perturbare l'ordine stabilito
Il nuovo libro di Rossella Fabbrichesi è scritto “per tutti e per nessuno” e così anche chi non ha dedicato la propria vita alla vocazione filosofica può rintracciarvi alcuni elementi decisivi per la propria pratica. La filosofia viene infatti presentata come un sapere vivente che trova la propria specificità nel suo farsi, nel suo prendere corpo in una serie di pratiche che trasformano il sapere in opera viva. Il taglio pragmatico che viene dato al sapere consente di ripercorrere la storia della filosofia recuperandone la valenza politica. La filosofia è un esercizio da praticare in una relazione e può trasmettersi solo attraverso le vie della testimonianza. E nella testimonianza ciò che viene insegnato può essere appreso solo se diventa sapere incarnato: “un maestro ci guida, ma poi dobbiamo riuscire a progredire da soli, senza il suo aiuto, avendo incorporato le verità apprese”.
In tal modo possiamo subito comprendere come la tendenza ad archiviare il sapere filosofico negli scaffali impolverati di biblioteche ormai scarsamente frequentate rispecchi la tentazione umana di cristallizzare e ipostatizzare il movimento attivato da un sapere che punta invece a scombinare e rimettere in discussione ogni accumulo di conoscenze. Perché il cuore dell’esercizio filosofico consiste nel modo di esplorare e dare forma al sapere, il fine non è produrre certi contenuti utili per il raggiungimento di determinati obiettivi, ma esprimere in figure flessibili l’evento dell’accadere. L’attività del pensiero e le navigazioni nel mondo delle conoscenze vanno intese non come la manipolazione pratica di contenuti filosoficamente rilevanti perché il pensiero non è un oggetto che possediamo: “forse non dovremmo dire che il pensiero è in noi, ma che noi siamo nel pensiero, così come diciamo che siamo in movimento”.
In Cosa si fa quando si fa filosofia? l’autrice riprende l’immagine deleuziana dell’uomo che sta sotto un ombrello: guardando in alto trova una costellazione di conoscenze che lo proteggono, ebbene l’atto filosofico consiste nell’incidere con un taglio quell’ombrello per far passare attraverso uno squarcio ciò da cui ci stavamo proteggendo con le nostre conoscenze. L’esercizio filosofico si nutre quindi del coraggio e del desiderio di entrare in relazione con quel qualcosa da cui ci proteggiamo con quelle forme di sapere che sono già stabilite. La filosofia introduce una perturbazione nell’ordine prestabilito cercando di mettere in luce quel lato tenebroso dell’esistenza da cui ci teniamo al riparo. Nella parete troppo levigata della nostra realtà l’agire filosofico mira a far riemergere le crepe di un reale scabroso che scompagina le certezze acquisite. Il gesto filosofico è quanto di più lontano possiamo immaginare da ogni forma di catalogazione del sapere, è semmai un “atto di coraggio con cui si lacera l’ombrello protettivo e ci si espone alla caduta libera degli eventi”.
Se ci facciamo appassionare dal fare filosofia saremo piuttosto condotti attraverso le maglie del sapere cercando di indagare i punti e i momenti di snodo in cui il sapere sta per prendere forma, quel momento in cui il vivente non è ancora vissuto, in cui lo scriversi non si è ancora scritto. Si tratta in pratica di deviare dai tracciati già saputi imparando a scandagliare profondità non ancora espresse. La pratica filosofica è allora esercizio di una “ragione flessibile” che vuole sondare il punto di insorgenza e le strategie di sviluppo di modi d’essere e stili di pensiero.
Il lavoro filosofico è animato da un ethos politico e mette in secondo piano ogni episteme enciclopedica: l’amore per il sapere non può chiudersi nel recinto del logos ma deve piuttosto tradursi in una prassi che abbia rilevanza sugli affari della polis: “nell’operare di ogni grande pensatore non assistiamo che a variazioni metamorfiche dell’incedere socratico per le vie di Atene”.

Ph Kenro Izu.
Se seguiamo questa prospettiva riconosceremo l’impegno filosofico nella scelta di subordinare “l’indagine sulle diverse modalità epistemiche del divenir-vero di un concetto” all’interrogazione dei modi in cui il pensiero interviene nel reale producendo effetti di verità. “Interrogarsi sulle pratiche produttive di verità è evidentemente diverso dal chiedersi come il pensiero si adegui al reale. […] Benché risulti faticoso per noi pensarlo, in tale prospettiva il vero non si risolve in un gioco interno al logos, che lo contrappone al falso e rimanda a un piano di corrispondenze empiriche, ma si trasferisce sul piano dell’azione e della produzione di conseguenze veridiche, che significa in primo luogo conseguenze pragmatiche non vane”.
La valenza principale dell’esercizio filosofico non è dunque di “ordine gnoseologico”, ma “etico-pragmatico”.
L’amore per il sapere non si traduce né in una contemplazione astratta delle idee né in un’adeguazione del pensiero alle cose del mondo, ma si esprime semmai nell’interrogare e trasformare tutte quelle pratiche discorsive che operando sul “reale” cercano di renderlo sempre più “vero”. Il fare filosofia si svolge nella polis e trova il suo perno principale nell’interpellare gli altri nell’azione del produrre il vero, nell’intreccio di prassi quotidiane e posture etiche che danno corpo al sapere producendo effetti di verità. La pratica filosofica consiste nel dissodare quel terreno fatto di saperi, discorsi e assolute verità da cui ogni sapere trae la propria sicurezza e legittimità tanto da apparire istintivo. “Verità che non si producono dunque come risultati di processi logici e inferenziali, ma come pratiche in atto, indissolubilmente legate alle abitudini più inveterate che frequentiamo”. Ecco perché l’esercizio filosofico – sulla scia di Wittgenstein – si presenta innanzitutto come una battaglia “contro l’incantamento del nostro intelletto per mezzo del nostro linguaggio”. La dimensione pragmatica diventerà così l’ambito privilegiato su cui potremo esercitare la ragione flessibile cercando di cogliere “un nuovo aspetto fecondo” che ci permetterà di transitare al di là delle nostre credenze. La pratica interpretativa della filosofia è destinata non solo a comprendere ma innanzitutto a prendere posizione. Comprendere per prendere posizione perché la posta in gioco della filosofia non è la fedeltà a una teoria, ma “un modo di frequentare la vita e, anzitutto, la vita della conoscenza”.
L’esortazione del lavoro filosofico si esplica in una trasformazione dei propri punti di approdo correndo il rischio di uno smembramento e di una disintegrazione soggettiva. Il rischio reale della filosofia si traduce così nella possibilità di trasformare “ciò che è accaduto, con la sua sorda e greve necessità, in qualcosa di fortemente voluto e alfine conquistato”. Si tratta di un percorso di soggettivazione che può realizzarsi solo assaporando la forza erotica del sapere filosofico. Per Rossella Fabbrichesi e per gli autori che ha chiamato a simposio, “ogni significato e ogni credenza devono essere interpretati nell’ambito dei principi guida dell’inferenza, ma tale disposizione dovrà non solo rispondere a un meccanismo logico-analitico, ma rivelarsi una potenza del gusto”. Affinché l’amore per il sapere non si risolva in una sterile trattazione disciplinare deve risvegliare la passione desiderante di ciascun soggetto. È questo il fondamento etico (erotico e sociale) di ogni esercizio logico che miri alla trasformazione soggettiva. Su questa strada però si incontrerà una roccia, un aspetto impermeabile a ogni ragione che tuttavia fonda ogni credenza. È il punto da cui prende le mosse e su cui si stringe ogni pratica filosofica.
La ricerca filosofica si accosta in primo luogo non ai logoi ma ai pragmata, ai fatti della vita che danno sostanza a un modo d’agire infondato. “Il dubbio interviene, a ben vedere, sempre dopo la credenza, e questa credenza fondante e, insieme, infondata non si instaura in virtù di una decisione razionale, non si reperisce in seguito a un atto di introspezione psicologica. Essa sfugge al circolo delle argomentazioni: non è né razionale, né irrazionale, né vera, né falsa. Semplicemente, nota Wittgenstein, comportando una serie di azioni pratiche, si identifica con la forma quotidiana in cui la vita trova espressione, con il suo carico di gesti immediati e di sicurezze tranquille”.
La nostra esperienza quotidiana è quindi intessuta di una rete di azioni molteplici e disposizioni ad agire che tracciano rigidamente il solco delle nostre convinzioni. Evidenze e certezze infondate sul piano logico ma che trovano ancoraggio nel flusso immediato della vita. Ecco la dimensione operativa e vissuta da cui traggono spunto molte riflessioni e categorie concettuali che in alcuni casi difendiamo strenuamente. Ne osserviamo rigidamente i dettami senza avere a volte il coraggio di interrogarne il fondamento logicamente infondato. Sono però le nostre certezze di base, fedeli compagne di viaggio e stabili punti di approdo: “verità che emergono dalle prassi e che il sapere fatica a conquistare e piegare al proprio metodo epistemico”. In questo corpo a corpo con le nostre credenze infondate si gioca la sfida racchiusa nel motto “diventa ciò che sei”, una sfida dove vita e conoscenza sono inestricabili e al contempo correlativamente opposte. È il nucleo rigido e granitico che ogni attività simbolica sogna di rendere flessibile.
Ecco sinteticamente l’approccio conoscitivo che la pratica filosofica consegna a ogni attività che non può fare a meno della ragione flessibile. L’esercizio filosofico può infatti ricordare a tante pratiche terapeutiche costruite attorno alla funzione della parola che il gesto decisivo per sostenere la trasformazione soggettiva non è assorbire le credenze infondate che si insinuano come crepe nel nostro sapere e nella nostra esistenza, l’obiettivo di una terapia non è stuccare con la conoscenza ciò che si presenta come frattura insensata e punto di inciampo di ogni conoscenza. Se aspiriamo alla flessibilità potremo semmai prenderci cura delle nostre crepe senza più considerarle come ferite inferte alla rigidità delle nostre conoscenze, perché esse non sono lo strappo del tessuto con cui ci proteggiamo ma il punto privilegiato da cui poter accedere a quella luce o quelle tenebre che ci avevano spinto a costruire il nostro ombrello. Forse è per questa via (filosofica) che possiamo intendere quello che lo psicoanalista Aldo Carotenuto in Una lettera ad un apprendista stregone indicava come il fine di una cura psicoanalitica: trasformare le proprie ferite in feritoie.