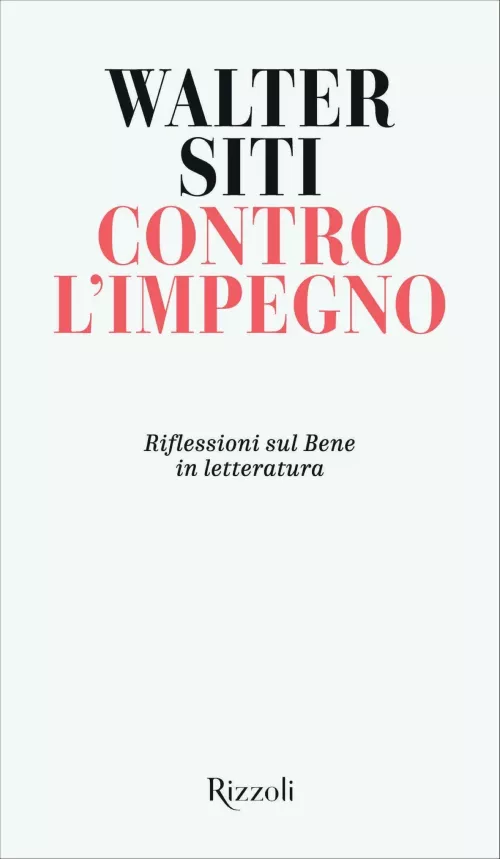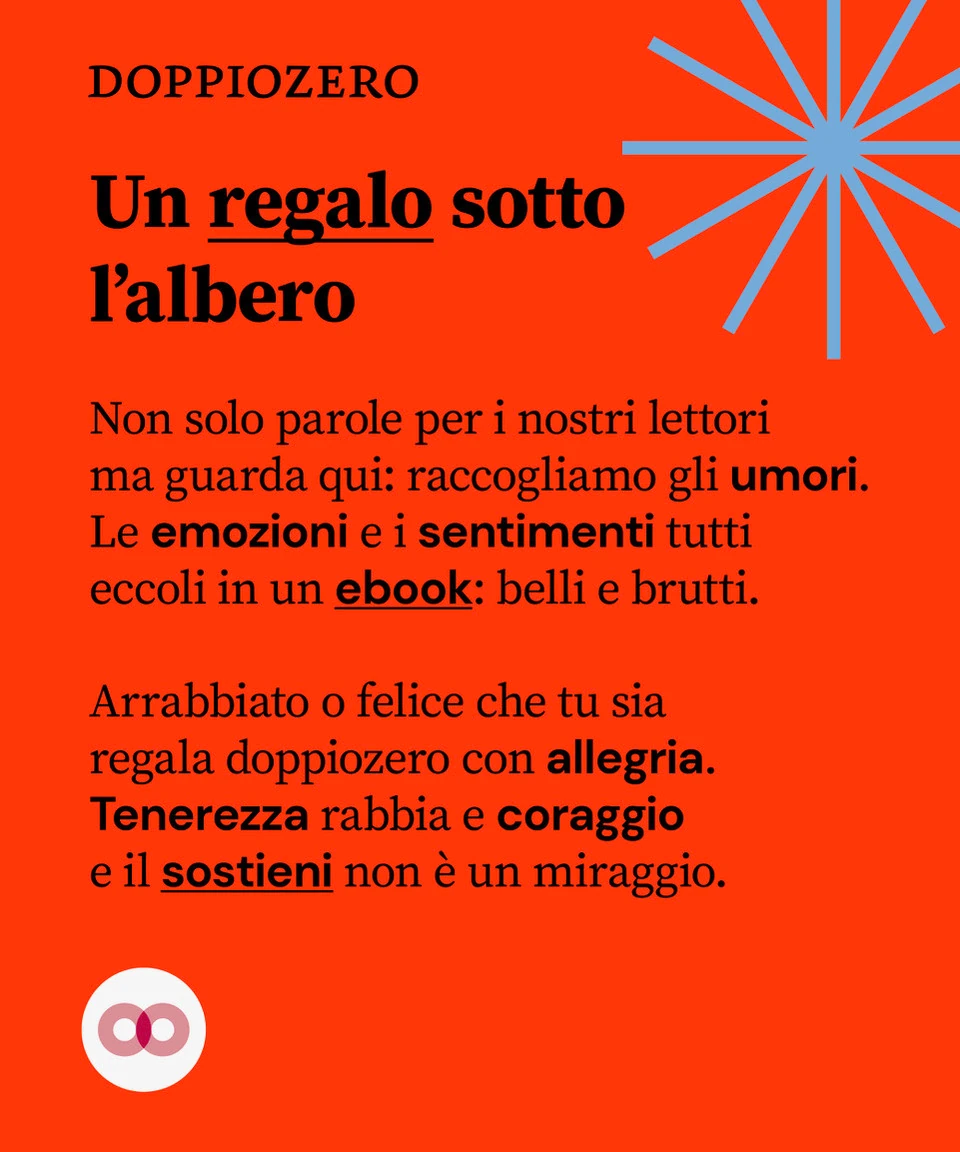Contro l'impegno / Walter Siti, il Bene in letteratura
L’ultimo libro di Walter Siti, di cui Paolo Landi ha già parlato su queste pagine, ha avuto un notevole riscontro, come del resto lasciava presagire la provocatoria titolazione Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura (Rizzoli). Benché composto da una serie di articoli già editi, l’insieme ha la coerenza di un intervento organico: un pamphlet che ha come bersaglio la concezione «riparativa» della letteratura, la letteratura intesa come rimedio o farmaco contro i mali della società, che di questi tempi sembra conoscere una certa fortuna. Molti scrittori si comportano come se il fine del loro scrivere fosse la diffusione di buoni principî, la denuncia delle ingiustizie, la promozione dei diritti dei deboli e degli oppressi, il Bene, appunto; e il valore letterario, di conseguenza, verrebbe ad essere misurato dall’efficacia pratica, terapeutica, dei libri. Tale, secondo Siti, il «neo-impegno» che circola in questi anni. Ma la letteratura è un’altra cosa.
Difficile dargli torto. E vale la pena di notare il modo in cui Siti argomenta: se l’impianto del discorso è programmaticamente polemico, si tratta però di una polemica rispettosa, in cui non si ravvisa ombra di presunzione o malanimo. Ad esempio, le riserve sollevate su Roberto Saviano sono piene di garbo, anche se la diagnosi critica fonde l’accuratezza dell’analisi con una lucidità spietata. A suo tempo David Grossman aveva suggerito all’autore di Gomorra, costretto a vivere sotto protezione, che, se si sentiva prigioniero, era di quello che avrebbe dovuto scrivere (consiglio, con ogni evidenza, disatteso). Siti aggiunge che al fondo dell’opera di Saviano c’è un’inconscia attrazione verso la camorra. Ora, un grande scrittore cercherebbe di fare i conti in primis con questo risvolto oscuro, con questo abisso della propria sensibilità. Ma Saviano ha scelto di essere altro: un intellettuale democratico che si batte per giuste cause – cosa di cui tutti, sia chiaro, e Siti per primo, gli siamo grati.
Nota è l’orgogliosa protesta di Vittorini, ai tempi del «Politecnico» e della polemica con Alicata e Togliatti: il compito della letteratura non è suonare il piffero per la rivoluzione. Quel che vale per la rivoluzione vale per ogni obiettivo ideale. Non sta alla letteratura suonare il piffero. Siti, insomma, ha ragione di contestare un engagement «sostanzialmente dimidiato e perfino controproducente».
Pure, qualche precisazione va fatta. Innanzi tutto Siti insiste sul valore dell’ambiguità – in particolare, dell’ambiguità fra bene e male – in cui consisterebbe gran parte del valore conoscitivo della letteratura. Quello di ambiguità è un concetto importante, anche sul piano teorico; ma, inevitabilmente, scivoloso la sua parte. Se una proprietà decisiva delle opere letterarie è la capacità di significare più cose, anche contraddicendosi, ciò non è dovuto soltanto, e nemmeno necessariamente, alla complessità o problematicità intrinseca del testo, quanto alla circostanza che il testo viene letto sullo sfondo di presupposti storici, culturali ed esistenziali oltremodo differenziati.
La polisemia, la non-univocità, la plasticità semantica che noi siamo usi riconoscere alla letteratura sono in larga misura la conseguenza del fatto che i testi letterari hanno la capacità di funzionare in contesti molto distanti fra loro, di «parlare» a lettori diversi. In altri termini, il fattore determinante non è la sorgente, il dato di partenza – lo stesso Siti insiste sui significati che sfuggono all’intenzione dell’autore – ma quello di arrivo. Proprietà distintiva dei testi letterari è di essere ritenuti meritevoli di durare nel tempo e di viaggiare nello spazio, cioè di non essere legati a un ambito singolo, a referenti determinati una volta per tutte. Di essere, in una parola, memorabili: cioè degni di essere diffusi, condivisi, tramandati, proposti a schiere sempre nuove di destinatari. Donde, a maggior ragione, significati plurimi, indefinitamente aperti.
E a questo proposito potremmo benissimo parlare di «efficacia». Quello che conta, della letteratura, è davvero la capacità di suscitare delle reazioni nei lettori; il problema è guardarsi da ogni tentazione di predeterminarne la natura, ovvero di cristallizzarla, ipotizzando nessi obbligati con il valore dell’opera. Sembra una sfumatura, ma non lo è. Non altra è infatti la ragione per la quale possiamo – dobbiamo – ribadire la centralità del testo. Tempo fa, rispondendo a una domanda sul possibile valore pedagogico della letteratura, mi è capitato di scrivere che la letteratura può bensì svolgere una funzione pedagogica, ma solo a condizione che non si proponga di farlo.
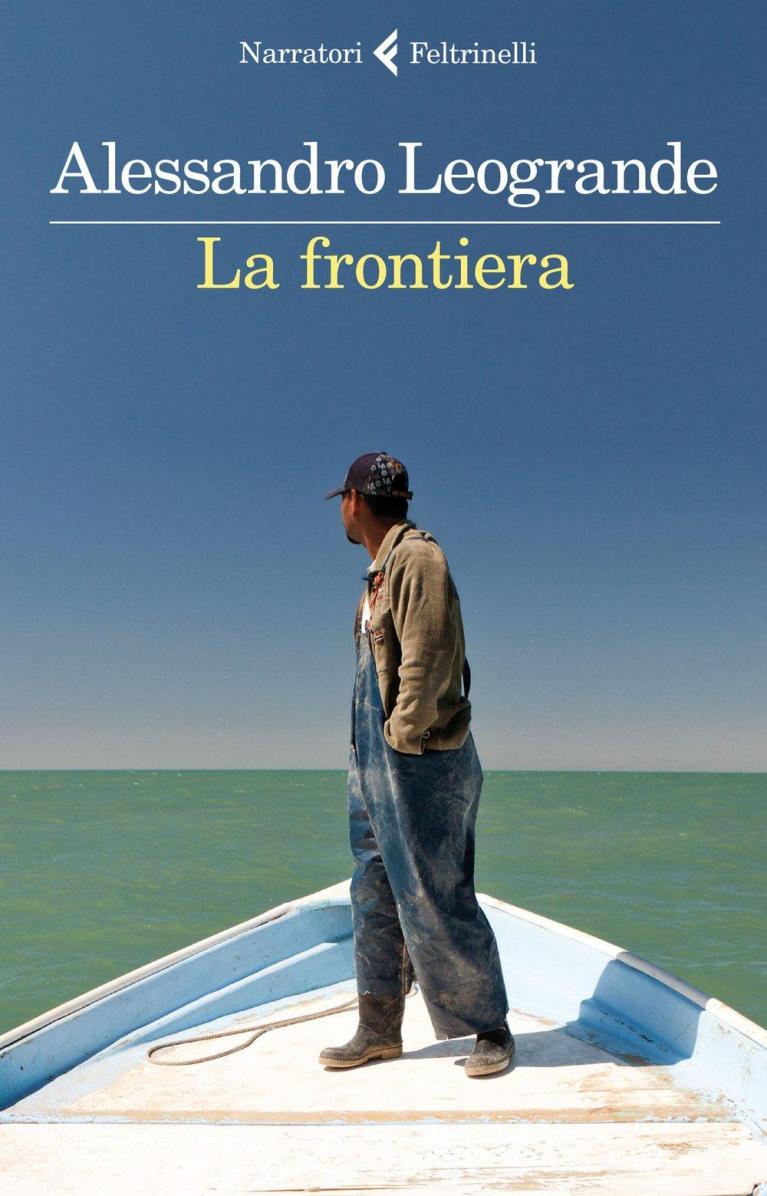
Perché il proprium del testo letterario non è dire delle cose piuttosto che altre, ma dire quello che dice in un modo singolare, etimologicamente «inaudito» e «straordinario», ossia fuori dal consueto e dal già noto, e quindi suscettibile di non annegare nel profluvio di discorsi che la società umana senza posa produce, inducendo quindi i destinatari a farlo proprio. Nulla di nuovo, beninteso: perché un testo diventi opera letteraria è necessario che a imporsi siano i suoi valori formali. Da ciò non discende – ovvio – che i contenuti siano indifferenti. Del resto, l’aveva detto benissimo Adorno, che Siti molto opportunamente cita: le forme sono «contenuti sedimentati».
In secondo luogo, quello che vale per il Bene vale anche per il Male, come ha sottolineato Jonathan Bazzi in un bell’intervento su «Domani» (Pro o contro l’impegno: la letteratura va dove vuole, 7 maggio). Siano pure stucchevoli le celebrazioni dei valori positivi e gli encomi delle vittime: ma anche la fascinazione per il negativo è a sua volta esposta al rischio della banalità e della stereotipia. Parlare del male, di per sé, non garantisce il raggiungimento dello spessore, della pregnanza di significato a cui la letteratura dovrebbe aspirare. Di nuovo, quello che conta è la cura dello stile: l’energia prodotta da quello che si può ben definire (riprendendo un’espressione di Siti) «il misterioso aggregarsi delle parole».
Inoltre, mi pare che da molte pagine di Contro l’impegno emerga il rischio di sopravvalutare l’aspetto conoscitivo della letteratura. È vero che la letteratura consente anche di scoprire cose nuove, alcune delle quali inaccessibili ad altre forme di espressione del pensiero e di elaborazione dell’esperienza. Ma la letteratura non è scienza, né filosofia, benché intrattenga con entrambe, così come con tanti rami del sapere, relazioni importanti: l’estensione delle conoscenze non è suo diretto e primario obiettivo. Vero è peraltro che, in ultima analisi (clausola da tenere sempre ben presente) la funzione della letteratura è accrescere la nostra intelligenza del mondo, e di noi stessi rispetto al mondo: e quindi, in particolare, la nostra capacità di intendere le dinamiche delle relazioni umane. Da questo discende una conseguenza rilevante: la letteratura esiste perché (in ultima analisi!) è utile.
Perché porta dei vantaggi. Fornisce strumenti per orientarsi, lenti per osservare, mappe per muoversi e calcolare distanze. Certo, una migliore comprensione del mondo può poi essere usata con intenti umanamente commendevoli ovvero a fini egoistici e prevaricatorî (non è un caso che la tradizione letteraria abbondi di villains colti). Da questo punto di vista, la pur vieta metafora della letteratura come cassetta di attrezzi mi pare irrinunciabile: un martello serve sia a costruire case, sia a innalzare forche, e tuttavia è meglio avere attrezzi che non averne. Per questo, nell’insieme, è lecito affermare che la letteratura aiuta a vivere meglio, con sé stessi e con gli altri. Come ho sostenuto in un recente libro (Poetici primati. Saggio su letteratura e evoluzione, Quodlibet 2020), la ragion d’essere della letteratura largamente intesa è incrementare, corroborare, affinare le nostre capacità di interazione con i nostri simili, in termini di acume, sensibilità, prontezza e sottigliezza di interpretazione.
La posizione di cui Siti si fa interprete parrebbe l’esatto contrario. La funzione della letteratura è di porre interrogativi scomodi, di insinuare dubbi; deve mettere in crisi, disorientare, scandalizzare. Di più: deve scuoterci, farci male. Meglio di tutti l’aveva detto Kafka: «Se il libro che stiamo leggendo non ci desta, come un pugno che ci martella il cranio, perché allora lo leggiamo?» Ma queste istanze sono commisurate a uno stato – a una congiuntura storico-culturale, a una condizione emotiva e psicologica – ben determinato. Rendersi conto di verità sgradevoli o dolorose, aprire gli occhi sulle proprie colpe e responsabilità, prendere atto di illusioni omissioni mancanze, è un passo necessario per poter prendere delle contromisure. Non diversamente, il dolore fisico ci avverte che il nostro organismo sta correndo dei rischi. Ricadiamo così nella posizione che Siti critica, cioè nella concezione «terapeutica» della letteratura? Io credo proprio di no, e non solo perché occorre distinguere le visuali in cui ci si colloca (altro è misurarsi con fenomeni attuali e contingenti, altro è prendere in considerazione una prospettiva di lungo o lunghissimo periodo). Il nocciolo della questione è che la letteratura ha il suo punto di forza, come sopra si diceva, in un quid di memorabilità che dipende dalla sua precisa configurazione formale. Le buone cause e gli intenti lodevoli non solo non bastano, ma di per sé valgono poco più di qualunque altro tema. Poi il tempo decide.
Per intenderci: quanto a contenuti, La frontiera del compianto Alessandro Leogrande (Feltrinelli 2015) – un libro dedicato a storie di migranti africani diretti in Italia che tutti i lettori italiani dovrebbero conoscere e meditare – ha un’importanza storica e un’urgenza drammatica che nulla hanno da invidiare al libro d’esordio di Primo Levi. Se La frontiera non arriverà a rivestire nella nostra cultura letteraria un ruolo simile a quello Se questo è un uomo, sarà essenzialmente per un diverso grado di tenuta stilistica.
Quanto il «neo-impegno» minacci il futuro della letteratura, non è facile a dirsi: pur giustificati e ragionevoli, i timori di Siti sono forse eccessivi, e trovano alimento soprattutto in una poetica personale aliena da ogni forma di engagement (opzione, inutile precisarlo, assolutamente legittima). Piuttosto, io avverto un pericolo differente, legato a un altro fenomeno tipico della realtà contemporanea: il dilagante successo della narrativa seriale. Intendiamoci: le serie sono sempre esistite, le ramificazioni e propaggini di una storia di successo, così come le dinamiche di sequel e prequel, sono ben documentate fin dalla fortuna dei romanzi cavallereschi; inoltre, la creazione di personaggi – aspetto cruciale di ogni progetto di cicli narrativi o TV series – è uno dei fattori centrali della creatività letteraria.
Ma quasi altrettanto importante, a mio modo di vedere, è il senso della fine (così suona, non a caso, il titolo di uno storico studio di Frank Kermode). Non è la stessa cosa decidere il destino di un protagonista o comunque delimitare una vicenda con il punto fermo dell’explicit, e lasciare l’una e l’altra cosa indefinitamente aperte a futuri possibili sviluppi. La rinuncia di principio a concludere depotenzia l’inventiva letteraria (e sia chiaro che qui parlo della conclusione fisica del testo, non della chiusura ideale dell’intreccio). Non nego, per carità, che esistano «serie» riuscite e meritevoli. Pure, assuefarsi alla indiscriminata proliferazione di storie a partire dalla stessa matrice (personaggi ambienti temi situazioni), significa deprimere, se non azzerare, il valore del tempo: è come eccedere nel consumo di zuccheri.
Peraltro, il pullulare della narrativa seriale, che satura i palinsesti gli scaffali e gli spazi di attenzione dei lettori, mi pare possa essere ricondotto al medesimo fenomeno che Siti ravvisa come causa profonda del «neo-impegno», tanto da scomodare un’espressione impegnativa, di sapore pasoliniano, come «mutazione genetica». Quello che sta cambiando è il rapporto con le parole: «non c’è più il silenzio necessario per essere parlati». Già. Da questo punto di vista, l’esperienza della pandemia ha messo a nudo un dato antropologico fondamentale: come tutto quello che facciamo, lo facciamo con tutto il corpo, così ogni impiego del tempo si correla a tutto quanto sta intorno e nei paraggi non solo immediati. Avere a portata di clic l’esecuzione impeccabile di una musica eccelsa non è detto sia preferibile allo spostamento fisico necessario per ascoltare dal vivo una composizione non più che dignitosa. Il telecomando che ci consente di assistere h 24 a capolavori della storia del cinema non vale la visione di un solo film di media caratura, preceduta da curiosa attesa e seguita da debita decantazione. Analogamente, parole e silenzio sono inseparabili: la letteratura è parte di un universo verbale oggi più che mai esposto al rischio della saturazione e dell’ingorgo. L’ostacolo maggiore che la letteratura deve affrontare non sono le troppo esibite buone intenzioni, né il compiaciuto indulgere alle cattive: è il rumore. Converrà pensarci, ora che le nostre strade, a lungo innaturalmente quiete, stanno tornando a risuonare e ad animarsi.