Fumiko Enchi: donne che invecchiano
Di questo libro colpisce anzitutto l’età avanzata della protagonista: settant’anni. Ci viene svelato sin dalle prime pagine ed è in parte già anticipato dal folgorante incipit «Era la mattina del 15 settembre, giorno della Festa degli anziani». Ci troviamo in Giappone, nell’ambita meta turistica di Karuizawa, nota località di villeggiatura estiva per le famiglie facoltose, ma da subito il tempo subisce uno scarto significativo: è autunno, il freddo è penetrante, il luogo appare quasi disabitato. L’atmosfera si preannuncia surreale, come fuori sincrono: chi mai andrebbe in vacanza in un periodo simile?
La protagonista, la scrittrice Tsutsumi Sano, cammina alle prime luci dell’alba in un viale invaso dall’odore delle foglie umide e si abbandona ai ricordi. Il paesaggio circostante ben presto sembra farsi specchio riflesso dell’anima della voce narrante che ragiona sugli avvenimenti accaduti in Giappone negli ultimi quarant’anni e all’improvviso percepisce «un certo disagio per la velocità con cui il passato e la realtà presente si intrecciavano, liberi come uno stormo di uccelli in volo». Il vento, gli alberi spogli e le foglie morte sembrano tradurre una decadenza fisica «pensava al proprio corpo come un involucro in rovina, rivestito di elementi presi in prestito».
D’un tratto la donna scorge la propria immagine nell’acqua del fiume e la osserva trattenendo a stento «un sorriso amaro», è la prima volta in cui viene rivelata ai lettori la sua età che appare in netta opposizione con il sentire interiore «Una ragazzina di settant’anni?» si domanda beffarda prima di tornare a sé stessa: «Pensava che una donna, indipendentemente dall’età, avesse un suo preciso ruolo». Il dissidio è già manifesto: il disordine del desiderio piegato al rigore morale.
Siamo soltanto all’inizio ed ecco illustrato in poche battute profetiche il tema principale di Saimu. I colori della nebbia ((Safarà Editore, 2025)) della scrittrice giapponese Fumiko Enchi: la percezione dell’invecchiamento femminile. La «nebbia» del titolo può essere accostata in egual modo al progressivo appannarsi della vista della protagonista, quanto al deteriorarsi della salute e del fisico a causa dell’avanzare dell’età. L’autrice, negli anni Settanta, rompe un tabù ancora oggi molto forte: raramente viene raccontata la vecchiaia, specialmente la vecchiaia delle donne e ancor più di rado viene affrontato il desiderio femminile in età senile. Servendosi dell’elemento magico e del tema della possessione – tipico della letteratura giapponese – Fumiko Enchi nel lontano 1975 riusciva a dire l’indicibile costruendo una narrazione avvincente attorno a un tema che, tuttora, viene percepito come un nervo scoperto.
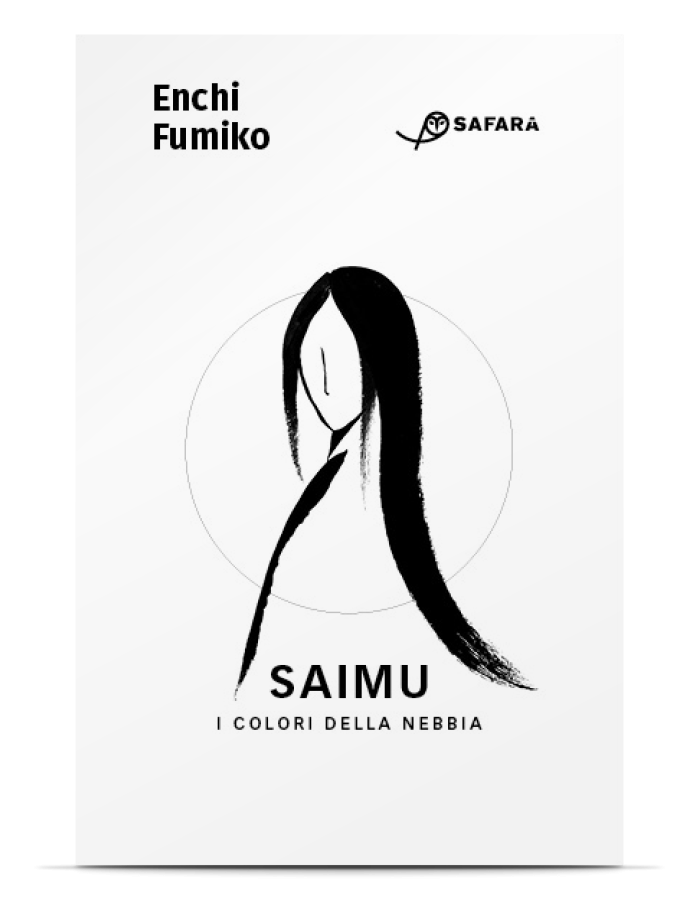
L’anziana protagonista entra in possesso di un’antica pergamena dipinta che esercita su di lei una sorta di sortilegio facendola ringiovanire e sviluppando il suo potenziale erotico. La metamorfosi effettiva di Sano in realtà occupa uno spazio esiguo nella narrazione che per buona parte si focalizza invece sulla storia della sacerdotessa di Kamo, sullo strano enigma legato al ritrovamento dell’emakimono e sulla sua precedente proprietaria, la signora Kawahara; il tutto sullo sfondo dei cambiamenti sociali ed economici avvenuti in Giappone dopo la Seconda guerra mondiale.
Nelle ultime pagine del libro, che si leggono d’un fiato perché vi è racchiuso il vero punto di svolta, l’autrice si permette di inserire una breve nota polemica che appare come un appunto morale «e se negli uomini viene accettata senza difficoltà l’attrazione per le donne anche in tarda età, forse è perché l’uomo nella società ha un ruolo più attivo».
A sostegno della propria tesi Enchi riporta quindi l’esempio di Goethe – che a ottantadue anni si innamorò di una ragazza – e di Tolstoj che più o meno alla stessa età lasciò la moglie Sofja, dopo quasi cinquant’anni di matrimonio, e abbandonò il tetto coniugale rifugiandosi in una stazione. Nessuno si permetterebbe mai di condannare i due giganti della letteratura o di gridare allo scandalo, osserva l’autrice: «E tuttavia questi fatti non vengono giudicati severamente, anche se sono giudicati eccessivi. Al contrario, vengono messi da parte per esaltare l’energia vitale dei protagonisti». Non è dichiarato in modo esplicito, ma tra le righe appare chiaro che se quella stessa azione fosse stata compiuta da una donna, la reazione sarebbe stata ben diversa. Fumiko Enchi, che già nel suo romanzo più celebre Onnazaka. Il sentiero nell’ombra (1956) ribaltava la visione patriarcale per mostrare l’oppressione invisibile delle donne, si limita a racchiudere la spinosa questione in un arguto commento, prima di riprendere il filo della trama. La riflessione suggerita è interessante, ma non deve distoglierci dal vero protagonista segreto di I colori della nebbia, che è il tempo.
Curiosamente la conclusione ad anello della storia riporterà la protagonista nello stesso luogo, ovvero la località turistica di Karuizawa, ma da una prospettiva ribaltata in cui la primavera cede il posto all’estate e la forza della natura sembra esplodere in una «violenta energia», la stessa – osserva l’autrice – custodita negli esseri umani. Non è certo la prima volta che in letteratura lo sbocciare dei fiori viene utilizzato metaforicamente per alludere al piacere, all’amore e alla fecondità e, anche in questo caso, l’atmosfera circostante si fa presagio di quanto sta per accadere. Il ciclo delle stagioni accompagna la trasformazione di Sano e si fa specchio della sua rinascita. La stessa concezione dell’elemento temporale viene alterata «dieci o venti anni, sembrava fosse volato via in un istante», ma a questo punto il tempo non conta più perché è la percezione interiore ad annullarlo: ora di fronte al nipote Yasuo lei torna a essere la donna che è stata, libera dalla prigionia di un corpo in decadenza «e Sano poteva avvertire senza alcuna esitazione che lui era sempre lui, e lei era sempre lei». In poche righe viene annullato qualsiasi preconcetto relativo all’età e ai limiti che essa impone con un linguaggio immediato e persino poetico, è sufficiente l’uso reiterato dell’avverbio «sempre» a indicare la durata ininterrotta, la frequenza costante, qualcosa che intimamente dura e persiste mentre tutto il resto muta.
Nulla, nella narrazione fluviale di Fumiko Enchi definita dall’American Reader «tolstojana», è lasciato al caso: la località turistica di Karuizawa che apre e chiude la storia appare come un singolare cronotopo, sul modello di Bachtin, teso a intensificare un legame peculiare tra lo spazio e il movimento del tempo il quale, proprio grazie alla concretezza data all’elemento spaziale, diventa visibile.
Saimu. I colori della nebbia viene pubblicato per la prima volta in Italia da Safarà Editore nella traduzione di Maria Teresa Orsi, con la curatela di Cristina Pascotto e la postfazione di Daniela Moro, permettendo così ai lettori di riscoprire il fascino narrativo di una delle maggiori scrittrici giapponesi del Novecento, paragonata sovente alla nostra Elsa Morante.

Il romanzo, il cui titolo originario era proprio Karuizawa in omaggio al luogo, fu pubblicato a puntate su rivista tra il 1975 e il 1976 e, di fatto, conserva la struttura narrativa del moderno feuilleton o romanzo d’appendice in cui il colpo di scena appare funzionale all’andamento della storia. L’intera vicenda ruota attorno a un emakimono, antica pergamena illustrata giapponese, che sembra esercitare una peculiare capacità di possessione in chi ne entra in contatto: il rotolo viene donato a Sano da una vecchia conoscente, la signora Kawahara, donna dal passato enigmatico, che in punto di morte decide di liberarsene. A partire da qui si dipana una trama quasi investigativa in cui Sano, con l’aiuto della sua assistente ed esperta filologa Katsuko, cerca di indagare il mistero della pergamena e ricostruire il destino di chi nel corso degli anni è entrato in contatto con il suo occulto potere. Si scopre così la storia della Grande Sacerdotessa di Kamo e dell’uomo che redasse la pergamena firmandola col sangue perché «spinto da un amore troppo profondo».
Il libro è ricco di suggestioni e riferimenti alla cultura nipponica – accuratamente spiegati dalla curatrice nelle note a piè di pagina – che permettono al lettore di immergersi nella tradizione di un mondo in cui l’elemento spirituale pare sopravanzare la realtà effettiva e intrecciarsi ad essa sino a metterla in dubbio. Domina una forma di disincanto surreale, che tuttavia ha un legame stringente con il mondo tangibile. Non sfugge l’uso dell’elemento magico come metafora – frequente nella letteratura orientale – utile per mostrare il cambiamento interiore della protagonista: serve l’intervento dell’emakimono perché Sano prenda coscienza di sé stessa e dei propri desideri. Si tratta di uno stratagemma narrativo usato ad arte per mostrare l’indicibile, ovvero la sessualità repressa della protagonista, purtroppo comune a molte donne giapponesi dell’epoca costrette in matrimoni senza amore e a una totale sottomissione al marito. A un certo punto della storia, l’autrice fa riferimento al fatto che i rapporti tra Sano e il marito ormai defunto «non erano mai stati buoni» e che «se qualche volta aveva potuto sperimentare qualcosa che poteva sembrare amore, ogni volta si era risolto in fallimento». La visione famigliare è ben lontana dall’idillio domestico, persino i rapporti tra Sano e la figlia Nami appaiono tesi e la parola in cui meglio si riassume l’aderenza di Sano al suo destino di donna è «frustrazione», motivo per cui veste meglio i panni dell’intellettuale e della scrittrice. Con il sortilegio dell’emakimono tutto cambia e la donna entra in contatto con impulsi carnali ormai sopiti, sino a riconoscere l’attrazione per il nipote Yasuo. Non è la prima volta che Fumiko Enchi fa un uso metaforico della possessione, era già presente nel suo romanzo più celebre Onnazaka, vincitore del prestigioso Premio Noma, il maggiore riconoscimento letterario giapponese. Enchi nel 1957 fu la prima donna a vincerlo.
In quel libro, ormai considerato un classico, l’autrice poneva una lente sul disagio femminile in una società di discendenza patrilineare: il titolo stesso Onnazaka era un riferimento al sentiero secondario, più difficile e impervio, cui erano costrette le donne per l’ascesa al tempio. Oggi gli scritti di Fumiko Enchi sono riletti in chiave femminista e divenuti popolari anche per la loro capacità di sdoganare alcune tematiche ancora coperte da una forma velata, forse ipocrita, di censura.
Se in Onnazaka il focus principale era sulle sofferenze patite dalle donne in una famiglia patriarcale e sul dissidio che si veniva spesso a creare tra mogli, concubine e amanti, ecco che in I colori della nebbia l’autrice compie un passo ulteriore ritraendo una condizione comune – la percezione dell’invecchiamento femminile – capace di svincolarsi dal contesto culturale della società nipponica. A parlare in questo libro non è semplicemente una «donna giapponese», ma una «donna anziana» che fa i conti con un corpo che la tradisce, con una pelle non più elastica e problemi di vista e, tuttavia, si scopre suo malgrado a desiderare e a provare amore. Raramente nella letteratura occidentale troviamo una protagonista anziana e, quando accade, il più delle volte si tratta di un pretesto per iniziare un lungo flashback che riconduce agli avvenimenti occorsi nella giovinezza: è come se il tempo della vecchiaia non fosse contemplato dalla narrativa perché ritenuto vuoto o privo di scopo, naturalmente a torto. Forse la nostra stessa letteratura appare come un riflesso di una società in cui domina incontrastato il culto dell’eterna giovinezza, oggi in parte accentuato dal mito della rappresentazione di sé. Fumiko Enchi invece ammette subito l’età della sua protagonista – settant’anni – e non la rinnega, anzi, fino all’ultimo ne fa il baluardo della propria rivoluzione:

«A qualunque età gli esseri umani hanno il diritto di amare e non c’è nulla di strano nel metterlo in pratica. Sano, pur vagamente convinta di ciò, si chiedeva perché mai dovesse preoccuparsi tanto di chi le stava intorno e giustificarsi».
Nelle ultime pagine assistiamo a una climax ascendente che legittima il desiderio della protagonista. Eccolo il messaggio innovativo dell’opera di Fumiko Enchi, ancor più straordinario se pensiamo che il libro fu scritto nel 1975. Senz’altro questa visione era figlia di una precisa cultura: nel Giappone del tempo si ha una concezione diversa, non lineare e più fluida, inoltre alla vecchiaia viene da sempre dedicata un’attenzione maggiore.
Nell’Ise Monogatari, uno dei testi fondativi della letteratura giapponese, si narra di una donna che, pur essendo anziana, non rinuncia ai piaceri dell’amore e soffre per l’abbandono del suo ultimo amante. E ancora nel dramma nō, forma teatrale del XIV secolo, si racconta dell’anziana poetessa Komachi che ricorda di essere stata un tempo una donna bellissima e si lancia in una danza sfrenata. Tsutsumi Sano, la protagonista de I colori della nebbia, si inscrive nel filone di questa lunga tradizione dedicata alle «opere di anziane» detta rōjomono; ma certo è interessante notare la singolare comunanza tra l’età anagrafica di Sano e quella dell’autrice. Quando scrisse questo libro anche Fumiko Enchi aveva settant’anni e, proprio come la sua protagonista, era una scrittrice affermata e molto conosciuta in patria anche per il suo lavoro filologico – era la traduttrice del Genij Monogatari, una delle principali opere classiche della letteratura giapponese scritta nel XI secolo dalla poetessa Murasaki Shikibu.
Proprio come la sua protagonista, inoltre, Enchi era reduce da un matrimonio infelice, tema che diventerà un vero e proprio leitmotiv nella sua produzione. Si avverte l’impulso biografico che attraversa la scrittura, nonostante il testo acquisisca ben presto una piega immaginifica: lo stesso nome dell’autrice, Fumiko, del resto era un’opera creativa e di immaginazione, letteralmente significa «Signora delle lettere» e lei lo appose come sigillo al proprio primo libro, nel 1928, per sostituire il suo nome originario, Ueda Fumi.
Sebbene l’elemento soprannaturale sia preponderante nelle opere della scrittrice giapponese è interessante notare che, in fondo, si tratta solo di uno strumento per veicolare un messaggio ben più importante. La funzione dell’emakimono in Saimu. I colori della nebbia è solo un pretesto per poter parlare liberamente del desiderio femminile in età senile e della percezione della vecchiaia, argomento di cui Fumiko Enchi fu una pioniera. A tal proposito è interessante analizzare il destino dell’emakimono, che ha diviso la critica. Infine Sano decide di bruciare la pergamena appartenuta alla sacerdotessa di Kamo. Non viene spiegato il motivo che la induce a quel gesto, apparentemente non c’è premeditazione, tutto si esaurisce nello spazio di poche battute lasciando il finale all’interpretazione del lettore. È la prova che l’antica pergamena non era che un artificio e che, nel liberare Sano da timori e pregiudizi, aveva quindi esaurito la sua funzione. Nel momento in cui la donna accoglie il desiderio l’emakimono non le serve più. Non poteva esserci conclusione più esatta per un libro dedicato all’invecchiamento femminile. L’eroina di Fumiko Enchi non insegue il fantasma di un’eterna giovinezza, anzi, se ne libera: sceglie di essere semplicemente sé stessa ed ecco che la vediamo come «una ragazzina dai capelli imbiancati».
In copertina fotografia di © Sirui Ma.







