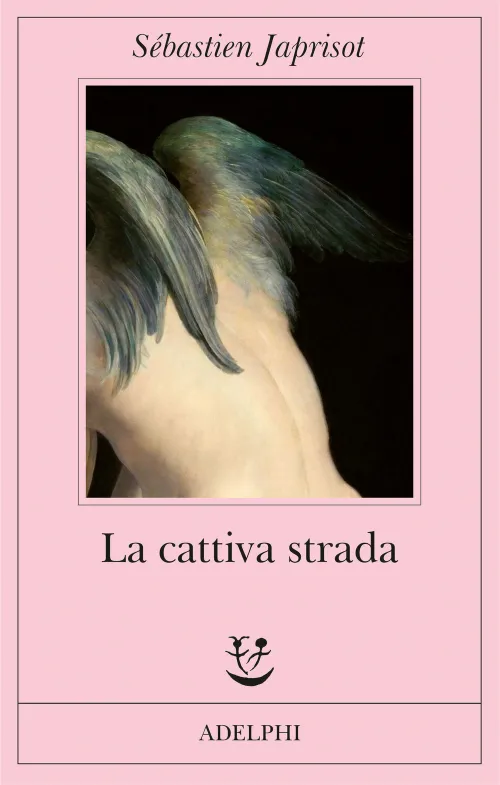Sébastien Japrisot oltre la morale
La cattiva strada è la via della ribellione. E la via della ribellione è quella giusta, ce lo insegna Fabrizio De André che, sempre in direzione ostinata e contraria, in una sua celebre canzone faceva della cattiva strada la parabola profetica dell’anti-eroe, ovvero il nuovo Messia, colui che si ribella alla tirannia del pensiero dominante e indica un percorso al di fuori dei confini già tracciati. Oltre il pregiudizio, oltre la morale.
La capacità di andare oltre la morale comune («signori benpensanti, spero non vi dispiaccia», un’altra citazione di Faber); ecco cosa in fondo accomuna la canzone di De André all’omonimo libro scandalo di Sébastien Japrisot. Non poteva esserci titolo più appropriato per la nuova edizione italiana del romanzo, Les mal partis, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1950. Adelphi lo ripropone nella traduzione di Simona Mambrini: La cattiva strada, appunto.
Quando lo scrisse, l’autore, marsigliese figlio di immigrati italiani, aveva appena diciassette anni, ma una scrittura già matura. Jean-Baptiste Rossi, questo il vero nome di cui Sébastien Japrisot sarebbe stato l’anagramma, redasse la prima stesura interamente a mano e poi dovette batterla a macchina per poterla inviare agli editori. Per compiere l’impresa chiese aiuto a una giovane dattilografa, Germaine Huart – cui il romanzo è dedicato, oltre che all’amico Pierre Sempe e a sé stesso – e costei, “galeotto fu il libro e chi lo scrisse”, sarebbe diventata sua moglie.
La storia editoriale di Les mal partis è funambolica e senz’altro degna di nota. Alla sua prima edizione il testo non ebbe fortuna, vendette appena un centinaio di copie e fu ritenuto un mezzo fallimento; tanto che Japrisot, dopo una breve incursione nella carriera pubblicitaria, si affermò come giallista e autore di sceneggiature per il cinema.
Nel 1966, oltre una decina d’anni dopo la pubblicazione, il romanzo fu insignito del Prix dell’Unanimité e ricevette il plauso della giuria di intellettuali, di cui faceva parte Sartre. In seguito al clamore suscitato dal premio il libro ottenne maggior successo, soprattutto negli Stati Uniti, mentre in patria ricevette un’accoglienza tiepida riscattata solo di recente anche per merito dell’interesse di Emmanuel Carrère che considerava Japrisot, di cui fu amico, «un grande scrittore, a ogni modo uno dei più originali della sua epoca».
In È propizio avere ove recarsi Carrère dedica diverse pagine alla memoria di Japrisot ricordando anche altri suoi libri celebri, tra cui il noir Trappola per Cenerentola «una fiaba dolce e crudele che per quanto mi riguarda rileggo ogni quattro o ogni cinque anni con affascinato disagio», ma soprattutto l’attitudine e il temperamento dell’amico scrittore: «Ad ogni modo per Japrisot cominciare e finire era la stessa cosa. Procedeva rapidamente, molto rapidamente. Altrimenti scrivere gli pesava…».
Fu con furia che Japrisot scrisse infatti il suo primo romanzo, guidato da un’ispirazione spontanea e dalla pura voglia di raccontare: «voglio fare il cantastorie» ripeteva fin da quando era bambino. La cattiva strada è la storia di un amore impossibile, ispirata in parte alle atmosfere illecite e appassionate di Il diavolo in corpo di Radriguet; ma è soprattutto una storia di ideali.
Oggi, grazie alla nuova edizione Adelphi, lo riscopriamo con un’attenzione rinnovata e avvertiamo tutta l’intensità, il vivido entusiasmo, il trasporto, l’impulso sovversivo che dovette animare quell’impavido diciassettenne mentre scriveva di getto la sua opera prima imbrattando pagine e pagine di inchiostro. La scrittura scorre come l’acqua ed è caratterizzata da una narrazione contemporanea, quasi cinematografica nelle descrizioni – non a caso l’autore si sarebbe poi affermato come sceneggiatore nel mondo del cinema.
Nella Francia del dopoguerra il romanzo di Japrisot – che però all’epoca fu pubblicato con il nome vero dell’autore, ovvero Jean-Baptiste Rossi – appariva fuori sincrono: nell’epoca del neorealismo, dell’impegno politico, della narrazione patriottica, il giovane marsigliese si affacciava sulla scena letteraria con una storia scomoda, volutamente scandalosa, dal sottotesto anticlericale, che oltretutto – ecco il vero oltraggio – lasciava la guerra sullo sfondo, mostrando un apparente disimpegno morale. Les mal partis narrava di un amore scomodo, un amore sbagliato, un amore che non sarebbe dovuto esistere.
Nell’introdurre la trama ci viene in aiuto il primo titolo italiano del romanzo, pubblicato da Milano Libri nel 1979, il didascalico Storia d’amore di una suora, che dava ingiustamente all’opera di Japrisot la coloritura a tinte fosche di un romanzetto d’appendice e ne sviliva, in parte, il contenuto. La storia d’amore proibita tra Suor Clotilde e il liceale Denis è infatti il fulcro della vicenda; ma non ne rappresenta il vero scandalo che, di contro, è dato semmai dalla società bigotta e ipocrita che mette alla gogna i due protagonisti. Japrisot, nell’innocenza dei suoi diciassette anni, fu abile a scombinare le carte in tavola portando il lettore dalla parte degli amanti ostacolati e spingendolo a parteggiare per loro.

Tentativo riuscito dal momento che, a distanza di oltre settant’anni, ci si ritrova ancora a leggere le pagine d’un fiato e a sperare nell’impossibile lieto fine. Agli occhi più smaliziati dei contemporanei forse la componente scandalosa del romanzo, che fece indignare e inarcare il sopracciglio alla Francia cattolica, viene meno.
Più che d’un amore immorale infatti La cattiva strada ci parla di una dolorosa ricerca identitaria. Entrambi i personaggi principali, il quattordicenne Denis e Suor Clotilde, appaiono prigionieri di un mondo nel quale non si riconoscono, relegati in ruoli che non hanno scelto. Lui è uno studente liceale indisciplinato, bollato ogni anno come quello da “tenere d’occhio” e inserito nella lista nera dal sorvegliante di turno dell’istituto gesuita dove studia; mentre lei è una giovane donna costretta a prendere i voti dalle esigenze della sua famiglia, cui si è piegata con docile sottomissione e senso del dovere.
I due si incontrano in un ospedale dove lui si reca ogni giovedì per fare volontariato scolastico. Un incontro e tutto cambia; entrano l’uno nei pensieri dell’altra. Da quel momento Denis non riesce a pensare ad altro che al giovedì per rivedere Suor Clotilde, l’attesa è tutta un palpito.
A questo punto la narrazione si sdoppia mostrandoci il punto di vista di entrambi i protagonisti, dando voce al loro personale tormento e anche alle loro domande. L’amore irrompe nelle loro vite con audacia scombinandole totalmente, entrambi infatti sono totalmente impreparati a comprendere quanto sta accadendo: Denis per la sua giovane età, Suor Clotilde per l’inesperienza. «È accaduto qualcosa. È arrivato Denis. Lo amo» pensa lei in preda allo sconvolgimento «Lo amo. Non sono più in grado di dire come, né perché, né quanto lo amo». Il presunto scandalo della relazione viene sovvertito dall’intensità di un amore assoluto, che forse solo un diciassettenne poteva rendere con tale efficacia e innocenza. La cattiva strada è un romanzo puro, non torbido né sconveniente, a dispetto dell’argomento trattato.
L’ambientazione non viene mai nominata: appare onirica, surreale, a tratti evanescente, potrebbe essere Marsiglia – città natale di Japrisot – ma la sua realtà emerge solo nelle pagine finali quando la guerra irrompe con il fragore dei bombardamenti e quindi con la distruzione. Il romanzo alla sua uscita fu criticato per il disimpegno politico, eppure, a una lettura più attenta, si può notare che La cattiva strada è un libro fortemente politico perché dà voce ai disertori. C’è un episodio preciso, a questo proposito, degno di nota: durante il soggiorno in campagna, in fuga dalla guerra, Suor Clotilde e Denis vengono fermati da un gruppo di soldati tedeschi che, però, vengono in pace e chiedono loro degli abiti civili per essere facilitati nella fuga. Sono dei disertori, vogliono abbandonare le armi e tornare a casa in Germania. Si crea una complicità istantanea tra gli amanti clandestini e i soldati disertori, Suor Clotilde si spoglia e accetta di scambiare il proprio vestito con l’uniforme tedesca, imponendo al più reticente Denis di fare lo stesso. Non lo fa per paura, ma per convinzione: «Le era sembrato di avere qualcosa in comune con quei soldati in fuga: anche loro, per rassicurarsi, si erano messi dei vestiti che non gli appartenevano», il gesto anticipa la sua successiva presa di consapevolezza di lei, la decisione di sciogliere i voti. Non è vero che la guerra è assente dal romanzo. La volontà dei soldati di abbandonare le armi entra in profonda risonanza con la sovversiva esclamazione di Denis, che assume dunque una valenza provocatoria: «Ma perché questa stupida guerra deve finire?», il ragazzo desidera che la guerra duri più a lungo per continuare a vivere impunito il proprio amore clandestino nel rifugio in campagna. La legge dell’amore si scontra con la dura legge della guerra e, in qualche maniera, la contraddice: dove c’è amore non ci può essere guerra. «Ho incontrato dei soldati tedeschi quest’estate» dice Denis al padre con sfida «Non saprei spiegarti, ma davanti alle vostre regole faccio esattamente come loro: mi tolgo giacca e mostrine e abbandono il campo di battaglia!».
La cattiva strada di Japrisot è intessuta di sottotrame e ciascuna incarna la ribellione. Tutti i personaggi di questa storia sono dei disertori, perché si oppongono alla morale comune: lo sono Denis e Suor Clotilde con il loro legame; lo sono il compagno Debaucourt e l’effeminato Prieffin che praticano atti sconvenienti in un collegio di gesuiti; lo sono i soldati tedeschi che si spogliano delle uniformi e indossano gli abiti di una suora e di uno studente. La volontà dei singoli rappresenta la rivolta contro una società oppressiva.
In questa cornice la religione cattolica, con i suoi precetti e i suoi dogmi, appare come uno strumento inventato dagli uomini per asservire, addomesticare, plagiare.
Rintanatosi in chiesa a pregare Denis, d’un tratto, guarda la Madonna e vede soltanto una statua di gesso, capisce che non è lei a minacciare, a ammonire, a giudicare. Capisce che l’amore non è una colpa. Il presunto discorso anticlericale di cui il romanzo è intessuto in realtà rappresenta un elogio all’umano: «Dio è morto? Esiste qualcun altro oltre a noi? A noi due insieme? Dio è morto. Esistiamo solo noi». A questa affermazione fa eco la presa di consapevolezza di Suor Clotilde che all’esclamazione inorridita della madre superiora: «Che Dio la perdoni!» risponde limpida: «Mi ha già perdonato», come chi non ha nulla di cui vergognarsi.
Sébastien Japrisot, proprio come Fabrizio De André, diffidava delle convinzioni assolute e lasciava aperta la strada del dubbio. Le domande poste dai suoi protagonisti non hanno risposte e sono eterne come l’uomo, perché non c’è vita che non sia stata toccata dalla confusione, dallo smarrimento, dall’incertezza. Ed è questo ciò merita di essere raccontato: il dubbio. Non esiste giusto o sbagliato in letteratura.
La cattiva strada è, in definitiva, un romanzo sulla libertà dell’individuo. Forse per questo motivo piacque tanto a Jean-Paul Sartre, grande filosofo della libertà individuale, che in un’opera teatrale forse poco nota Il diavolo e il buon Dio (Le Diable et Le Bon Dieu), datata 1951 e quasi contemporanea al romanzo, si interrogava sugli stessi temi: l’inesistenza di Dio e la responsabilità individuale. Riprendendo la domanda cardine di Dostoevskij in I demoni: «Allora, se Dio non esiste, tutto è permesso?», Sartre affermava l’esistenza di un’etica individuale, indipendente da ogni divinità e legge metafisica. Lo stesso cerca di fare Sébastien Japrisot nell’ambito della finzione romanzesca facendo dire ai suoi protagonisti: «Fosse anche la cattiva strada l’abbiamo presa insieme», rendendoli artefici del loro destino. Sia Denis che Suor Clotilde solo nell’amore riescono a essere liberi «siamo stati insieme in una casa, eravamo felici (…) ci è successo qualcosa di bellissimo, e di buono»; ecco la verità che sradica, con la forza sovversiva di un vento impetuoso, ogni ipocrisia.
Nella strofa finale della sua canzone, dal ritmo malinconico di una ballata, Fabrizio De André diceva: «Ma c’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada, sulla cattiva strada».
Le verità assolute non appartengono all’amore, perché ogni relazione con l’altro ci impone di reinventare le verità su noi stessi e aprirci al confronto, quindi al dubbio. De André concludeva facendo riferimento al “processo per amore” che ritorna, curiosamente, in vari suoi testi anche se in forme diverse: l’amore è il sentimento libero, prorompente, per eccellenza, che non conosce regole, neppure quelle degli amanti, dunque naturale che la società cerchi di imbrigliarlo, di controllarlo.
La precedente traduzione italiana del romanzo di Sébastien Japrisot difettava di un errore di interpretazione, Storia d’amore di una suora, inchiodava la trama al pregiudizio, facendo prevalere la visione sociale su quella individuale. Invece la morale del “libro immorale” scritto dal diciassettenne di Marsiglia era un’altra: insegnava che dove c’è amore c’è libertà, ecco perché La cattiva strada, con la sua intrinseca promessa di ribellione, è il titolo giusto.