Dimore, stanze, oggetti. Dove abitano i ricordi
Non ricordo con precisione chi disse che della memoria si può parlare solo per metafore, forse il filologo Harald Weinrich, ad ogni modo è vero, e infatti fin dall’antichità più remota se ne usarono soprattutto due, quella del magazzino e quella della tavoletta di cera, che rinviavano una all’idea di archiviazione e disponibilità, e l’altra a quella del ricordo come impronta o traccia. Quindi in sostanza un luogo e un oggetto, come sostiene nel suo bel saggio antologico Antonella Tarpino (Il libro della memoria. Dimore, stanze, oggetti. Dove abitano i ricordi, Il Saggiatore, 320 pagg, 24 euro), quando scrive che sempre più spesso la memoria rinarra il tempo attraverso lo spazio, investendo di sé edifici e oggetti.
Le case sono contenitori di storie, ospitano la nostra memoria più duratura e preziosa, forse anche per questo si chiamano stabili gli edifici che le ospitano. D’altronde la lingua lo ribadisce con forza: lo stato d’animo consistente nel rimpiangere ciò che è trascorso è la nostalgia, e quanto questa abbia a che fare con la casa lo rivelano sia l’inglese, che la chiama Homesickness, cioè la malattia della casa, che il tedesco, che la chiama Heimweh, cioè il dolore per la casa.
La casa come luogo per eccellenza della memoria quindi, di quel tipo di memoria compassionevole capace di nutrirsi dei riverberi delle emozioni che si sprigionano dai luoghi cari del passato, diventa così lo strumento per far sì che il passato si ri-presenti, abbia luogo di nuovo, rivelandone in questo senso il suo carattere attivo e inconcluso. Perché è vero che il nastro non si può riavvolgere, né far sì che ciò che è accaduto non lo sia, ma il senso di ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte, richiede continuamente di essere ripensato, compreso, ossia preso in carico da un’interpretazione che provi a farne emergere il significato, magari rileggendolo alla luce delle nuove esperienze.
Nelle sue pagine antologiche, Antonella Tarpino ricorre alla grande letteratura, quella di Kafka, di Henry James, di DeLillo, di Sebald, perché “la letteratura è la vera protagonista di quel collage mnestico”, ma anche l’arte contemporanea e il cinema si interrogano da tempo su quanto e come la memoria si ancori al nostro abitare.
Penso alle delocazioni di Claudio Parmiggiani, quelle impronte di oggetti domestici, come quadri o librerie asportate, che ricordano i traslochi o le mani delle grotte preistoriche, ottenute appunto in levare, non imprimendo il colore, come a testimoniare il calco di un’assenza.
In questo genere di prova si è cimentata pure l’attrice Dakota Fanning, che ha debuttato dietro la macchina da presa con un cortometraggio in cui un appartamento è testimone di gioie, dolori, speranze e delusioni di una giovane donna di nome Ava interpretata da Eve Hewson. In Hello Apartment, presentato alle Giornate degli autori di Venezia 2018, la regista ha cercato di catturare il modo in cui i nostri ricordi sono collegati allo spazio in cui viviamo.
Al centro del racconto un loft luminoso di Brooklyn, il suo primo appartamento, e un’idea di base molto semplice, come dichiarato dall’autrice Liz Hannah: “rivivere il proprio passato mentre si passa in rassegna ciò che sta accadendo nel presente, tutto in unico spazio.” Così vediamo la giovane Ava entrare per la prima volta nel loft completamente vuoto e appena ritinteggiato ma dall’aria vissuta, guardandosi intorno nella luce che entra dalle grandi finestre inondando il pavimento in legno con i segni dell’usura degli inquilini precedenti.
La volontà è quella di ricordarci che lasciamo sempre un’impronta nell’ambiente in cui viviamo: in quel punto della casa vedrà con un’amica un film che la commuoverà, in quell’angolo del soggiorno verrà versato del vino a una festa, quello spigolo scheggiato della camera da letto è dove tirerà un posacenere durante un litigio col suo uomo, che culminerà nella decisione di separarsi.
Come avvertiva Emanuele Coccia nella sua Filosofia della casa, lo spazio domestico non ha una natura euclidea, “le cose che abitano i nostri appartamenti non sono estensioni, sono magneti, attrattori che li trasformano in un campo di forze costantemente instabili […] Rimanere a casa significa resistere a tutte le forze che esercitano su di noi. La vita a casa è resistenza, in senso elettrico e non meccanico: siamo un filamento di tungsteno attraversato dalla forza delle cose, ci accendiamo o spegniamo grazie a loro.
Ogni volta che attraversiamo la soglia della nostra abitazione, le cose si animano perché acquisiscono una parte di noi.” Dunque, le cose oggettivizzano il ricordo incorporando e proiettando significati, ma a sua volta il ricordo si reifica come una sorta di reliquia secolarizzata.
Il fascino delle case museo nasce dal desiderio di ripristinare una relazione più intima con le opere, nonché dalla promessa di avere accesso all’universo privato di un individuo animato da una grande passione, oltre che da grandi capitali.
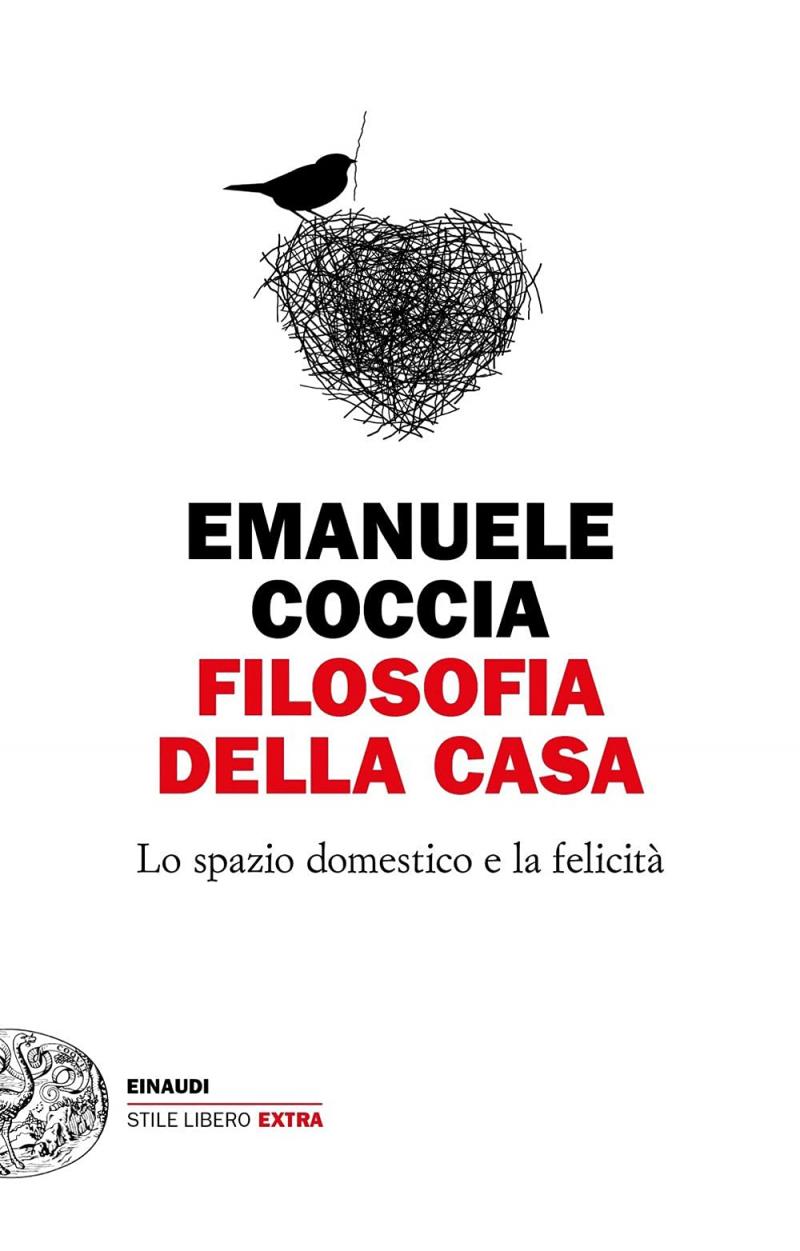
Per primo fu Orhan Pamuk, con Il museo dell’innocenza, a sostenere che “il futuro dei musei è nelle nostre case”. Lo scrittore turco si riferiva in particolare alle spettacolari Wunderkammer del Poldi Pezzoli e del Bagatti Valsecchi di Milano, o della Frick Collection e della Morgan Library di New York, ma pure al Museo di Gustave Moreau a Parigi, alla casa di Mario Praz a Roma e soprattutto alla casa di Anne Frank ad Amsterdam, luoghi capaci di farci battere il cuore con l’emozione profonda di una storia personale, ma la verità è che siamo già andati molto più in là di così.
Oggi il turismo più avveduto ricerca le tracce della Storia e della memoria collettiva in posti meno canonici e battuti, meno “separati” dalla vita quotidiana. Anche da questa spinta nasce la grande diffusione di un’iniziativa benemerita come quella delle c.d. pietre d’inciampo dell'artista tedesco Gunter Demnig, che inserisce nel tessuto urbanistico delle città europee la memoria diffusa di persone comuni deportate nei campi di sterminio nazisti.
Basta vedere il successo della camera 214 dell’hotel Century di Praga, in cui si può soggiornare, prenotando con mesi di anticipo, per provare l’ebbrezza di stare fra le stesse mura che ospitarono Kafka per quattordici anni, dato che quello era il suo ufficio all’Istituto di Assicurazioni. D’altronde, tutta Praga è ormai una città in forma di biografia. Neanche un secolo dopo la morte dello scrittore, in ogni angolo della capitale ceca riecheggia il suo nome e campeggia il suo volto malinconico, icona della bellezza e della purezza dell’insuccesso, a partire dalla sua casa natale, che oggi ospita il caffè Kafka, col suo ritratto come insegna.
Uno scrittore la cui fama in vita varcò a stento i confini boemi, ora è diventato un’attrazione turistica internazionale e un pilastro del canone occidentale. Ma il colmo è la libreria Kafka a Palazzo Kynski, dove un tempo c’era la merceria del padre. Hermann, l’omone che badava solo agli affari, che direbbe adesso nel vedere che tutto il mondo celebra l’opera del suo primogenito, quello che lui considerava un buono a nulla? Sembra una domanda retorica, eppure la risposta non è così scontata. La fama imperitura, anche se per procura, è un fardello ingombrante, lo dimostra il fatto che i c.d. cugini americani, i figli dello zio Philipp, fra i pochi sopravvissuti dell’intera famiglia ai lager nazisti, rinnegarono ogni legame con l’illustre parente, con una renitenza degna di Bocca degli Abati (il personaggio della Divina Commedia reso immortale nel suo desiderio di oblio).
Stesso discorso per la stanza 346 dell’hotel Roma a Torino, rimasta uguale a quel tragico 27 agosto 1950 (e sorvoliamo sui dettagli per rispettare le volontà dell’illustre defunto); o per la suite 203 dell’Hôtel des Saints-Pères, situato nell’omonima strada della rive gauche, dove nell’ottobre 1971 si tolse la vita George Dyer alla vigilia della consacrazione del suo amante Francis Bacon, protagonista di una grande mostra che si stava allestendo al Grand Palais, un onore fino ad allora riservato a solo due artisti viventi: Picasso e lui. Sulle ragioni di quel suicidio si fecero parecchi pettegolezzi, come temeva Cesare Pavese, e oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, uscendo dall’albergo in una delle strade parigine più affollate di targhe commemorative, ci si accorge che non esiste alcuna traccia di quel tragico evento, come se la vergogna e il senso di colpa di Francis Bacon gli fossero sopravvissuti.
Nel frattempo, le case-museo proliferano. L’ultima tappa del turismo colto, casa Bellonci ai Parioli, è stata annunciata mesi fa con un tweet entusiasta del ministro Dario Franceschini, che ne sottolineava l’importanza perché lì dentro “abitano grandi storie della letteratura e la memoria del Premio Strega”, per poi aggiungere: “In Italia c’è bisogno di valorizzare gli itinerari letterari, che passano anche attraverso le case dei grandi scrittori”.
Come evidenzia la Tarpino, “la storia della vita della casa è legata alla storia della vita del corpo che la abita, finendo per costituirsi come il tramite simbolico per eccellenza della possibilità stessa del ricordare”. Non a caso Primo Levi scriveva (nell’Altrui mestiere), a proposito del suo appartamento torinese da cui non si allontanò mai volontariamente, “abito la mia casa come abito l’interno della mia pelle”, specificando che secondo la leggenda familiare il luogo preciso della sua venuta al mondo era lo stesso in cui era posizionata la scrivania sulla quale scriveva.
La memoria si rifugia sempre più fra le pareti domestiche, e raccontare è fare del mondo una casa, mettere ordine ai propri pensieri, fissarli una volta per tutte, o magari un modo elegante per sbarazzarsene, una forma di letotecnica come quella del sinologo Kien di Auto da fé, (la scrittura al servizio dell’oblio, ancilla oblivionis)? Sia come sia, il nostro amore per le cose trascurabili che sospettiamo piene di senso, e insieme l'idea, solenne e puerile, che l'universo sia colmo di frammenti di significato che solo un occhio esercitato e sensibile sa ricostruire e salvare sulla base di esilissimi indizi, può trovare soddisfazione solo con la fedele trascrizione di queste perle segrete sul classico taccuino nero d’ordinanza, che ricorda tanto il cahier noir del giovane corazziere Louis-Ferdinand Destouches; o i trentaquattro quaderni neri di Emil Cioran, che confluirono nell’omonimo libro postumo curato dalla sua compagna Simone Boué; o i taccuini neri con i quali girava sempre Walter Benjamin negli anni 30, nei quali era custodita la sua collezione di mirabilia (ergo non solo Chatwin).
Ma tutto questo ha a che fare più col principio di Edmond Locard, il padre della criminologia francese, per il quale non si può entrare o uscire da un posto senza lasciare qualcosa di sé, che non col genius loci. E che ci sia qualcosa di poco pacifico, nella natura di questi pellegrinaggi alle case dei grandi artisti, lo si intuisce dalla speranza (non priva di malizia) di “trovare” lo scrittore nel suo più prosaico e indifeso succedaneo: la casa in cui ha vissuto. Armati delle migliori intenzioni, per carità, e tuttavia armati, anche se solo di un taccuino (non a caso “d’ordinanza”, in quanto strumento poliziesco, e “sfoderato” in quanto strumento d’offesa). Operazione non innocente, dunque, ma non vi è letteratura, né tanto meno memoria, ove si dia innocenza.







