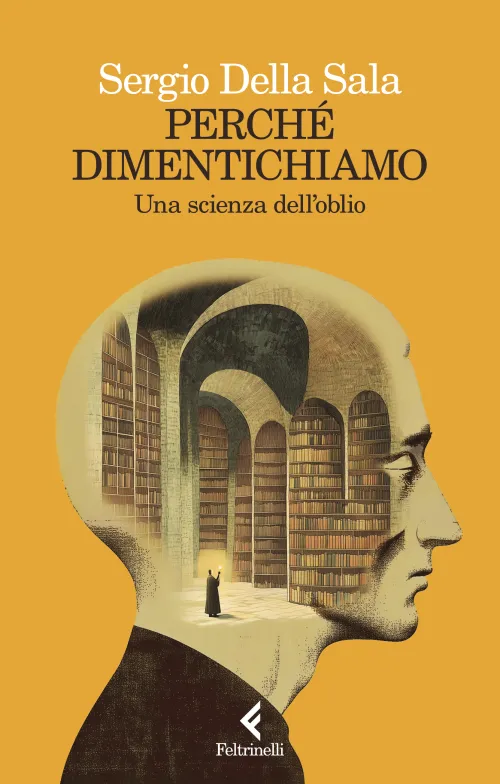Elogio dell’oblio
Si consolino tutti coloro che ambirebbero avere una memoria perfetta e infallibile. Non solo non è augurabile, ma non è neppure sano, come ci insegna attraverso una moltitudine di esempi tratti dalla vita quotidiana, riferimenti a ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, ma pure della cultura generale, filosofica e persino di romanzi, canzoni, vignette e fumetti, Perché dimentichiamo. Una scienza dell’oblio (Feltrinelli) di Sergio Della Sala, professore di Neuroscienze cognitive e umane all’Università di Edimburgo. Se me lo trovassi di nuovo di fronte, e in passato mi è capitato, gli direi: “Professore, dopo avere letto il suo saggio, devo farle una confessione. Ho peccato. Pure io ho accarezzato per molto tempo la pia illusione di potenziare la mia memoria”. E, proseguendo qui il mio outing, l’ho fatto al punto di seguire il corso di un mnemonista o ipermnesico che dir si voglia, cioè un soggetto con una memoria superiore a quella ordinaria. Il metodo che appresi funzionava, ma richiedeva un allenamento costante e quotidiano. Si trattava delle cosiddette mnemotecniche già note nel remoto passato, quando, non essendo diffusi libri né tantomeno i supporti digitali odierni, mandare a memoria era vitale per certe professioni intellettuali e accademiche. Ma alla fine, nel mio caso, mi chiesi: per farne cosa? Fare dei campionati di memoria? Partecipare a un telequiz? Farne sfoggio e vantarmene con parenti, amici e conoscenti? Diventare come i grandi memorizzatori del passato, rimasti giustappunto nella memoria storica, che so, Simonide di Ceo, Cicerone, Pico della Mirandola, Giordano Bruno?
Sempre attratto e alla ricerca di questo tipo di soggetti dalle capacità mnemoniche eccezionali, ero ancora un giovane studente universitario quando mi capitò di trovarmi a pranzo a Bologna con Massimo Inardi, un medico del lavoro che fu prima campione e in seguito supercampione, vincendo anche la “superfinale” di un memorabile telequiz dell’epoca, anni settanta: “Rischiatutto” condotto da Mike Bongiorno. Ogni concorrente si presentava in trasmissione con una propria materia di base: Inardi si presentò per la musica classica. Poi c’erano le domande del tabellone, su vari argomenti, anche a “sorpresa”: dalla cronaca allo spettacolo, dallo sport alla cultura generale. Inardi chiuse la prima tornata della gara sbagliando la domanda sulla sua materia di base, ma a pranzo, dopo avermi mostrato un gettone d’oro del premio che aveva conservato e fatto montare a mo’ di portachiavi, mi confessò che quella risposta la conosceva da quando era ancora un bambino. Alla mia replica, sul perché avesse sbagliato di proposito, mi rispose, testuale, che quella trasmissione era diventata come uno “schiacciasassi” per la sua vita professionale di medico e pure per quella privata. Raggiunta la cifra che gli interessava, considerevole per l’epoca, per l’acquisto di una abitazione, decise deliberatamente di tornare alla sua vita di tutti i giorni. Mi fece capire, insomma, che pur essendo dotato di capacità di memorizzazione e di velocità di recupero delle informazioni memorizzate non comuni (tanto che ad un certo punto si pensò, dati anche i suoi interessi nel mondo del paranormale, che fosse in grado di leggere le risposte nella mente di Mike Bongiorno per telepatia) che comunque tutto ciò gli costava fatica e stress. Lungi dall’essere il cervello come un magazzino in cui riporre le informazioni da recuperare alla bisogna, il carico cognitivo del mandare a memoria sempre nuove materie, come in trasmissioni a quiz quali “Rischiatutto”, richiede impegno, tempo ed energie psicofsiche non indifferenti. Inoltre, un ipermnesico come Inardi è come un campione sportivo: ambisce vincere, ma lo stress del gareggiare per la vittoria alla lunga logora e non ti concede tregua. Inardi mi disse che passava le giornate a imparare le nuove materie del tabellone, pure quelle di cui non gli importava un fico secco, senza riuscire a fare molto altro. Alla fine, un incubo da cui liberarsi.
Nel dispiegare il suo discorso sull’importanza dell’oblio, della salutare funzione del dimenticare, Della Sala non può contemporaneamente esimersi dallo spiegarci, in base alla attuali conoscenze sul cervello, cos’è e come funziona la memoria. E tra i molti miti ridimensionati o sconfessati nelle pagine del suo testo, riprendendo il discorso di soggetti con supermemoria come Inardi, c’è ad esempio il falso mito della “memoria fotografica”. Ogni volta che la mia strada ha incrociato quella di soggetti ipermnesici, c’è sempre stato qualcuno che ha tentato di spiegarmi queste straordinarie facoltà mentali di acquisire e recuperare informazioni immagazzinate nei meandri del cervello con l’ipotesi che questi individui potessero “fotografare” con l’occhio della mente un testo dopo averlo visto una sola volta.
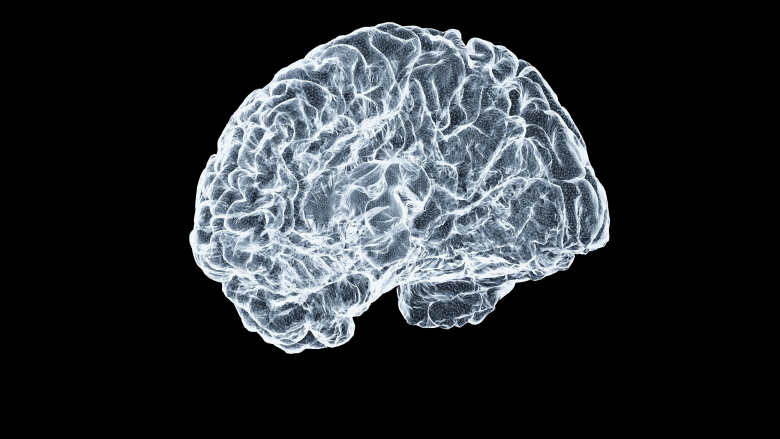
In realtà, come ci spiega Della Sala, la memoria fotografica, per quanto affascinante come idea, non esiste. Una facoltà, quella della memoria fotografica, spesso invocata in narrazioni o in film come Rain Man, in cui il protagonista con autismo, interpretato da Dustin Hoffman (ispirato a un personaggio reale, Kim Peek), tra le varie prodezze mostrate riesce a contare con una sola occhiata i 246 fiammiferi caduti per terra. Ma anche nei resoconti neurologici di Oliver Sacks, ad esempio quando descrive la vicenda di Franco Magnani, un pittore dilettante affetto da problemi mentali, in grado di dipingere a memoria, secondo il celebre neurologo-scrittore, il suo paesino natale (Pontito in provincia di Pistoia), dopo essere emigrato a San Francisco trent’anni prima. Secondo Sacks, Magnani, motivato dalla nostalgia per le sue origini e grazie alle sue straordinarie capacità di “memoria fotografica”, era in grado di rappresentare graficamente il paesino d’origine nei minimi dettagli. Ma Sergio della Sala ridimensiona Sacks, commentando che la rievocazione nostalgica (le emozioni sono un induttore potente per i ricordi) non ha nulla a che vedere con una presunta memoria “eidetica”. Oliver Sacks fu uno scrittore di straordinario successo, aggiunge Della Sala, ma i suoi sono racconti a sfondo clinico più che resoconti scientifici.
«È una credenza diffusa, ma errata», scrive Della Sala, «che la nostra memoria funzioni come una videocamera, immagazzinando informazioni nel cervello come in un archivio permanente. In realtà non conserviamo istantanee oggettive, indipendenti dai nostri giudizi o dalle esperienze passate: tratteniamo il significato, il senso, le emozioni che quelle esperienze ci hanno trasmesso. La memoria è un processo ricostruttivo, che ricrea attivamente eventi ed esperienze, basandosi in parte sulle nostre intenzioni e sulla conoscenza che abbiamo del mondo. Proprio per questo può essere imprecisa: le persone possono ricordare eventi mai accaduti, o collocare fatti reali in contesti sbagliati. La memoria è, in fondo, una ri-presentazione».
Questo è un passaggio cardine nel volume sulla scienza dell’oblio di Sergio Della Sala, in cui viene sintetizzata tutta la filosofia che ne ispira la trattazione. Procedendo per metafore, anche se la nostra mente non è né un magazzino né un luogo fisico in cui riporre le memorie e le informazioni, tuttavia potremmo metaforicamente sostenere, con Della Sala, che per fare spazio a nuove informazioni è necessario, in qualche modo, sbarazzarsi di quelle vecchie, in particolare quelle superflue o addirittura inutili. E leggendo Della Sala in questi passaggi mi sono venuti in mente i soggetti affetti da accumulo seriale o compulsivo (“disposofobia” è il nome del disturbo mentale in termini clinici): a furia di accumulare, anche oggetti e cose non necessari, gli spazi in cui si trovano a vivere diventano infrequentabili e invivibili. Alla fine non rimane più spazio per cose nuove.
Qualcosa avviene anche per la nostra mente “affetta” da una memoria che non dispone del necessario equilibrio “igienico” rappresentato dall’oblio, dalla scopa della dimenticanza. E qui Della Sala elenca esempi clinici passati alla storia della neuropsicologia come quello del giornalista che non prendeva mai appunti ma ricordava tutto nei dettagli anche a distanza di anni, sventura sua: Solomon Šereševskij, la cui storia è stata raccontata da Aleksandr Lurija, uno dei padri della neuropsicologia, in un libro di anni fa, più volte ristampato anche in tempi recenti, intitolato Una memoria prodigiosa.
Ma qualcosa di simile, la iattura di disporre di una memoria che accumula e trattiene tutto, anche i ricordi deleteri, fu anticipato da uno scrittore che letto e riletto riesce sempre a trascinare in mondi fantastici e labirintici: Jorge Luis Borges. In un suo racconto contenuto nella raccolta Finzioni narra le vicende, anche qui disgraziate sul piano delle afflizioni mentali, di Ireneo Funes. A seguito di un trauma, una caduta da cavallo, Funes manifesta una memoria spaventosa (in tutti i sensi, tali da ostacolare la sua vita normale). È come se Borges ci facesse capire che una memoria del genere, lungi dall’essere auspicabile, è frutto di un trauma cranico e, come tale, è contro natura.
«L’abilità di Funes è un limite estremo», commenta Della Sala, «ma rende chiara la necessità dell’oblio per la mente umana: dimenticare ci consente di comprendere, di generalizzare, di imparare dal passato. L’incapacità di dimenticare rende la vita di Funes impossibile da vivere, soffocata dai dettagli, dai ricordi che non sfumano mai».
Al termine di questo libro di Sergio Della Sala, movimentato anche da notazioni autobiografiche, passaggi ironici e autoironici (tipo quello conclusivo sul fatto che, dato l’argomento, noi lettori dimenticheremo in fretta il contenuto e quindi l’autore ci aiuta con un elenco finale delle “nozioni utili” da ricordare), sorgono spontanee alcune riflessioni. Una su tutte: probabilmente noi umani ci siamo inventati memorie esterne come libri, giornali, filmati, computer, programmi informatici e intelligenze artificiali via via che le informazioni e il mondo si sono fatti sempre più estesi, intricati e complessi. Il fatto di delegare ad altri, ai supporti artificiali e alle AI, preserveranno la nostra mente e le nostre memorie naturali dallo scivolare nella follia dell’accumulo incontrollato. O forse no.