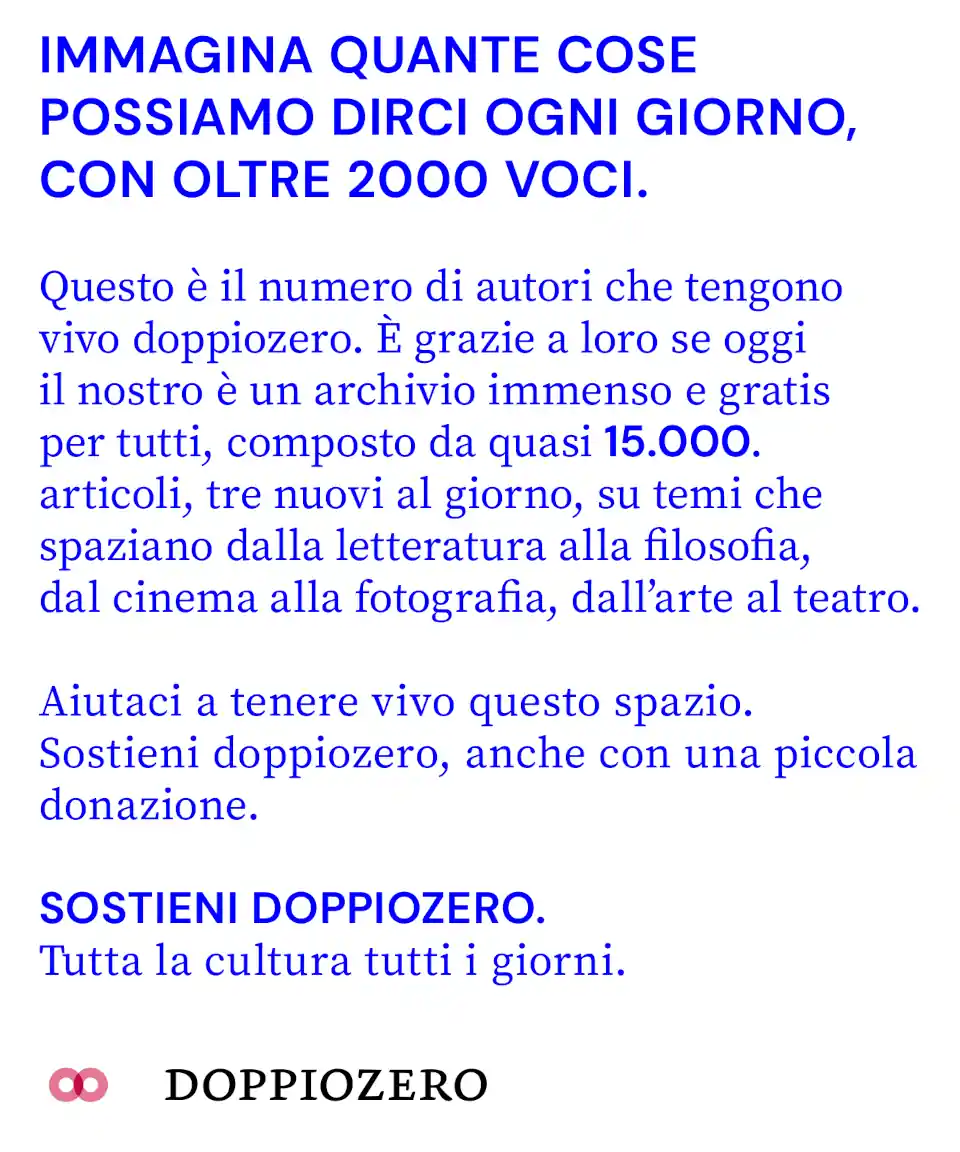Speciale
Coquina 14. Meat sounding
Mai come adesso la cucina è faccenda politica. Lo è sempre stata, si sa, ma con l’inasprirsi del dibattito pubblico (eufemismo) anche l’enogastronomia prende posizione. E in tanti, governanti e governati in testa, prendono posizione su di essa. Considerandola questione identitaria, se non patriottica, il nostro Governo attuale, e con minor vigore anche quelli precedenti, ha deciso di occuparsene regolarmente, e ha portato avanti varie azioni più o meno bipartisan per sostenere la cucina italiana, non ultima la candidatura Unesco che la propone come patrimonio immateriale dell’umanità. Anche la Comunità europea è in fermento, e pubblica leggine e disposizioni varie per regolamentare a suo modo produzioni agricole e allevamenti, viticoltura & co., a tutela, dicono, del consumatore. L’uomo è ciò che mangia, si sa anche questo, e se mangia con attenzione e garbo, c’è da sperare che divenga migliore. Da cui la relazione fra fornelli e cosa pubblica, pance ed elezioni.
Nel giugno del 2017 una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i prodotti di origine vegetale non possono essere commercializzati con le denominazioni tipiche di quelli lattiero-caseari come latte, latticello, siero di latte, crema di latte, panna, burro, formaggio, yogurt e simili. Mondo vegetale e mondo animale non possono essere confusi, ci dice insomma, teologicamente, la legge. Si salvano espressioni ormai fisse come latte di mandorla, quello di cocco e il burro di cacao, perché, leggiamo, designano qualità intrinseche del prodotto. Intrinseche? Ma il latte di soja, per dirne una, non va, e perciò deve avere un altro nome. Per non parlare della vegan mozzarella o delle sottilette anch’esse di soja. Il marketing lessicologico è ricorso allora a spericolate operazioni semantiche per ribattezzare tanta roba da ordinario supermercato. Ed ecco arrivare la bevanda di soja o le più semplici fette. Qualcuno, memore di Magritte, ha scritto nella confezione, papale palale, “Sssh. Questo non è latte classico”. Aggiungendo in piccolo “gusto latte, 100% vegetale”. Altri hanno scritto Soja italiana, Senza zuccheri soja, Classico soja. Insomma, sembra che la soja non se la passi benissimo, a meno di non cancellarne le dubbie origini esotiche… Ma sono arrivati anche squaglino (per lo squacquerone) e stracciabella (per la stracciatella).
Certo, supposto che il consumatore si lasci regolarmente abbindolare dalle parole, fatta la legge si trova comunque un inganno: sparendo la terminologia lattiero-casearia, resta il packaging a fare da traino. Quando troviamo sullo scaffale un parallelepipedo in tetrapak stretto e lungo, spesso di colore bianco, la parola latte potrà pure non esserci, ma che si tratti di latte o quel che è lo inferiamo lo stesso. Le parole, con buona pace della Crusca (che lo sa), non sono tutto, nel bene come nel male. E poi, siamo certi che il consumatore sia un ingenuo, per non dire un cretino? (Siamo certi, per passare ad altra spesa, che non compro più sigarette perché sul mio pacchetto c’è la fotografia di un disgraziato che sta morendo di chissacché?).
Per i nostri legislatori sembra di sì, a leggere adesso una nuova disposizione europea che replica le cose per quel che riguarda il meat sounding in molti prodotti vegetariani e vegani. È di un paio di settimane fa la notizia che l’Europarlamento ha approvato l’emendamento di una legge sull’organizzazione comune dei mercati agricoli per impedire – sempre a tutela dei consumatori – l’uso di denominazioni legate al mondo animale per prodotti che lo rifiutano. Presto non si potranno più usare espressioni come veggie burger, salsiccia di tofu, affettato gusto speck, burger (o spezzatino, o bistecca) di soja, cotolette vegetariane, veganer bio burger, ragù di seitan, muscolo di grano, spezzatino di tofu e simili. Parole come bistecca, scaloppina, spezzatino, salsiccia, hamburger sono, viene detto, d’origine animale, e in quel regno della natura devono restare. Le proteste non sono mancate, e c’è stato chi ha parlato di risposta sbagliata a un problema inesistente – la quale, fra l’altro, imporrà a produttori, designer, grafici e markettari di reinventare da zero la promozione di un settore del mercato alimentare di enormi dimensioni. Andando a modificare, volenti o nolenti, anche le destinazioni d’uso (una bistecca che si chiama, poniamo, rondellone posso ancora metterla sul barbecue?).
C’è ciccia per linguisti e semiologi. Con i miei studenti di Comunicazione per l’enogastronomia ci abbiamo pensato su, e un gruppetto di ragazzi s’è anche lanciato a proporre atletiche soluzioni. Riprendendo qualche denominazione già esistente come veggie stick (per i salamini), medaglioni o margherite (per gli hamburger) sono venute fuori espressioni come soy-ciccia, ke-babbo e, più semplicemente, per polpettine e affini, perle, sferette, poligonotti, piattelle etc. Sembra ci sia ben poco spazio d’azione per l’invenzione lessicale.

Da che cosa deriva questa difficoltà? Dalla cattiva impostazione del problema. Lo aveva chiaro il già citato René Magritte, che nella celeberrima serie sulla “Trahison des images” si è fatto maestro di freudiana denegazione: la pipa disegnata non è una pipa ma la sua immagine, certo; ma se è così anche il termine pipa non è una pipa ma la sua designazione verbale. La linguistica e la semantica strutturali ce lo hanno spiegato da tempo: la lingua non è una nomenclatura ma un sistema di segni, di modo che la relazione fra le parole e le cose è mediata dai significati di quelle parole che, molto semplicemente, circolano nella cultura, vengono generati e trasformati entro l’arena sociale, a uso e consumo dei parlanti, dei loro interessi e valori, e non certo delle cose. Le quali, dal canto loro, hanno anch’esse la propria significazione. La pipa, anche senza la parola che la esprime e l’immagine che la rappresenta, significa di per sé un sacco di cose, di situazioni, di atteggiamenti, di personaggi…
In tal modo, non c’è un’origine unica e precisa dei significati delle parole, ma un loro continuo cambiamento. E nessuna sfera dell’esperienza – come per esempio quella alimentare – può rivendicare una qualche proprietà originaria dei segni. Altrimenti dovremmo spiegare al solito popolo bue dei consumatori (ma basta!) che la colomba pasquale non è un uccello, gli agnolotti non sono animaletti carini e il formato di pasta chiamato vermicelli non è costituito da orridi esseri striscianti. E che ne sarà della colla di pesce, del salame di cioccolato…? A essere referenzialisti, c’è da perdere l’appetito. E il suono della carne – che forse per questo è aborrito a Bruxelles – diviene la campana a morto della gastronomia. Da quelle parti, comunque, lo spezzatino si chiama carbonnade, e tutti lo mangiano senza tema di intossicazione carbonifera e, soprattutto, senza camminare sui carboni ardenti. Una metafora, si dirà. Appunto, una metafora, una metonimia, una sineddoche, ma soprattutto tante, tantissime forme di catacresi (la quale non è brutta malattia ma, come ci hanno spiegato a scuola, una figura retorica che presta parole alle cose che non ce l’hanno come le gambe dei tavoli e i colli delle bottiglie – o, diremo meglio, un significante che assume, se serve, nuovi significati).
La lezioncina potrebbe continuare, chiarendo come la lingua sbadigli dinnanzi alle supposte proprietà intrinseche delle cose, e pensando semmai ai suoi complessi intrecci interni fra iponimi e iperonimi, ai contesti entro cui le parole, bontà loro, inevitabilmente si trovano a funzionare, alle situazioni che le generano e le tradiscono… Viene la lacrimuccia ripensando alle ottanta pagine del Trattato di Eco che cercano di spiegare come mai un termine come bachelor possa significare al tempo stesso uno scapolo, un diplomato in un college americano e uno scudiero: che avranno in comune questi qua per esser racchiusi in un solo significante? La lingua, esattamente come la cucina, è un organismo vivo: mica può occuparsi di restare fedele a se stessa, e meno che mai ai nostri stomaci impauriti dai prodotti industriali che li assediano quotidianamente.
Possiamo augurarci, ancora una volta, che i nostri legislatori si circondino, quando decidono sulle sorti della comunicazione, di competenti in materia, così come fanno (lo fanno?) per la medicina o la finanza. Nel frattempo, pazienti, accompagneremo il nostro spezzatino meat sounding con arancine senza arance, ossa di morto, teste di moro, dita di apostolo, lingue di gatto e un buon affogato. Il tutto innaffiato da tanto, ma tanto, vino dealcolato. Vino?
Leggi anche:
Gianfranco Marrone | Santi bagnati, bevitori asciutti
Gianfranco Marrone | Tra gli scaffali del supermercato
Gianfranco Marrone | Tre stelle a McDonald's
Gianfranco Marrone | Il panino: attenti a quei due!
Gianfranco Marrone | Dal tagliere alla città
Gianfranco Marrone | Cucina a vista e passioni tristi
Gianfranco Marrone | La pasta, questa conosciuta
Gianfranco Marrone | La rivoluzione wok
Gianfranco Marrone | Il gusto della geografia
Gianfranco Marrone | La grande bouffe e il digiuno
Gianfranco Marrone | Mangiare con le mani
Gianfranco Marrone | Fenomenologia del menu
Gianfranco Marrone | A tavola con Montalbano
Gianfranco Marrone | Giorgia e la cotoletta diplomatica