Henri Michaux: essere visionari
«La mescalina moltiplica, affina, accelera, intensifica le prese interiori, delle quali si coglie, purificatrice, senza poterla comprendere, la straordinaria ondata di piena. Ad occhi chiusi, si è in presenza di un mondo immenso. Nulla ci aveva preparato a questo. Non lo si riconosce […] Si giurerebbe che si tratta di un vero mondo, un mondo autonomo, extragalattico forse, raggiunto per miracolo: il rovescio, o piuttosto il diritto, di questo», scrive Henri Michaux in un testo dal titolo “Occorre davvero una dichiarazione?” (apparso nel catalogo Encres, gouaches, dessins, 1959; trad. it. di D. Suraci in HM, p. 43). Con la pubblicazione di Miserable miracle. La mescaline (Miserabile miracolo. La mescalina, tradotto da Claudio Rugafiori con postfazione di Carlo Mazza Galanti, Quodlibet, 2025, MM), Michaux esprime con incisiva chiarezza il suo pensiero, o per meglio dire la sua “immagine-pensiero”, ma già in “Occorre davvero una dichiarazione?” confermava queste affermazioni: «Chi ha visto in modo visionario, in un’affascinante condizione di passività, non può più dimenticare… La mescalina, però, non è indispensabile. Anche senza di essa io posso, ho potuto molte volte vedere in modo visionario» (HM, p. 43).
Si può avere visioni con o senza mescalina, suggerisce l’autore. Ma Michaux, da scienziato-poeta delle percezioni, vuole sperimentare in prima persona la droga e misurare la sua esperienza dell’abisso attraverso questo libro-diario, “un libro fiero che descrive con misura ciò che è smisurato” (Blanchot). Descrivere l’indicibile con l’ironia di un esploratore immune dalle emozioni caratterizza l’affilato e sarcastico Michaux, immerso in un “altrove” da cui non vorrebbe mai fuggire. L’esperienza della mescalina non frantuma l’io dell’artista: lo moltiplica in stenogrammi, lampi di frasi, frammenti, semipitture, trasfondendo il genere del diario in notebook d’artista. Leggere Michaux mette il lettore alla prova, non lo concilia ma lo irrita, lo provoca: solo chi desidera essere libero da ogni canone, in scrittura o pittura, ed è insofferente alle regole dei generi artistici, sceglie di leggere i suoi libri, sceglie una via dei segni dove raramente l’uomo Michaux prende la parola per dire di sé ma sempre lo fa per evocare altro/altri da sé – mondi, creature, popolazioni immaginarie, ectoplasmi. In questo senso la mescalina, come un enzima scatenante, è l’esperienza aliena che traversa il suo corpo e che, soltanto dopo, quando sarà evaporata e fuggita via, l’autore farà oggetto di parole. Segno e parola, nel suo diario-non diario, si alleano in grafismi acuminati, appunti vertiginosi, intuizioni estetiche che trasfigurano le leggi del creato così come è, inventando prospettive “extragalattiche”. «Tornato a casa, è molto agitato. E non è che noti un gran che di cambiato, quando, improvvisamente, si mette a ridere. Di che cosa? Cosa c’è? Nessun visibile oggetto di riso. Vorrebbe piuttosto visioni ma – ancora non sa – per questo bisognerà che aspetti delle ore. E di nuovo ride... Io, per tornare al solo testimone che possa seguire, io, ero interiormente all’erta per via di quel riso, di quel riso senza oggetto» (MM, p. 114).
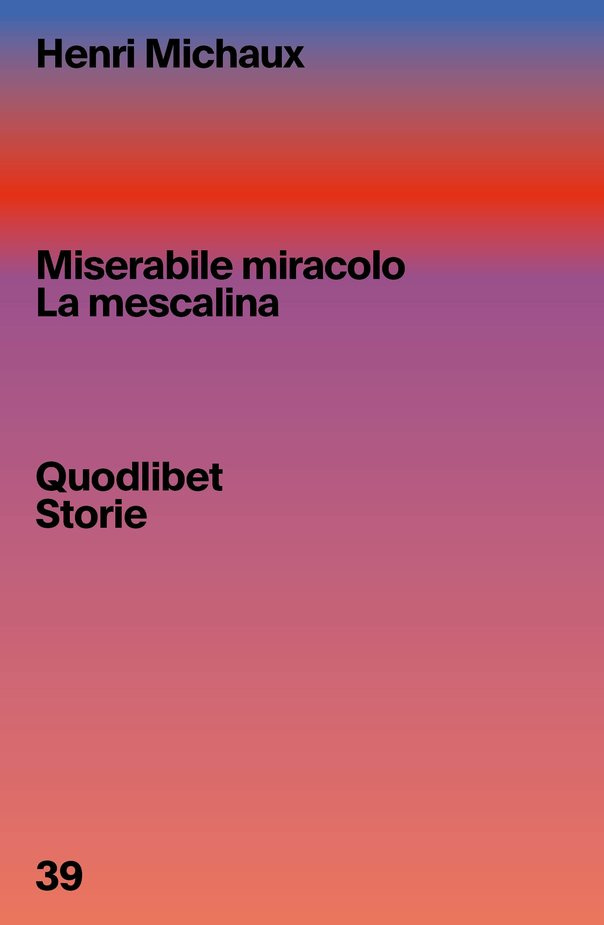
Ecco, il Michaux scosso da quel riso irrefrenabile e indecifrabile diventa simbolo di ciò che diventa la creatura umana posseduta dalla mescalina, pervasa da una droga che toglie spazio anche alla logica dell’assurdo di cui è maestro. Qui ogni logica e ogni ragione deflagrano. E l’artista si mette in ascolto di questo se stesso “nuovo” come di un terremoto che gli svelerà nuove vibrazioni. «Volontariamente o involontariamente, tramite il libro, la parola è la sua sola presenza. Michaux colpisce e paralizza. Non dico che abbia in sé qualcosa del cobra (reale), ma il modo con cui attacca, affascina e impressiona, non è privo di analogie con quanto si racconta di quel serpente, e noi gli siamo riconoscenti (io lo sono) di questa sorta di aura emozionale di cui si circonda», scrive André-Pieyre de Mandiargues (HM, p. 47). de Mandiargues la chiama “aura emozionale” ed ha ragione, se però si considera l’emozione non nella sua accezione psicologica o psicodinamica ma come quel turbine di sensazioni che l’autore, con e senza mescalina, suggerisce al lettore: “ero interiormente all’erta” scrive Michaux e in questo “essere all’erta” si concentra la sua persona, disincantata, sprezzante, illuminata, mai estranea a ogni intuizione “altra” (accentuata dalla droga come no) che possa accrescere la sua “conoscenza dell’abisso”, lievemente remota dall’umano. «Come un Luciano il cui mondo grottesco e smagliante si è disseccato, come per tutti i grandi utopisti con le loro luminose e improbabili città, isole e continenti ridotti in polvere, o come un Gulliver che dopo aver rovesciato in tutti i modi il suo cannocchiale non crede più a nulla – neppure al piacere stesso di narrare le proprie fantasie, ma solo al dovere interiore di testimoniarne comunque il mistero – Michaux percorre sia un universo microcellulare, sia una sorta di paesaggio minerale, non è chiaro se prima della creazione o dopo un’apocalisse nucleare. Una cosa però è certa: in questo habitat, interiore o fantastico che sia, l’uomo non c’è. E la sua assenza sembra essere una conquista, un sollievo per l’autore stesso (Lucetta Frisa, in SVS, pp. 79-80).
Cosa preme davvero a Michaux, a questo “naturalista dell’inverosimile” (Alfredo Giuliani)? Esserci, sempre, come un folle che a occhi aperti scruta, osserva, descrive la sua temporanea follia, ad esempio l’allucinazione di sprofondare nell’inferno della linea. «Le linee si susseguono quasi senza tregua. Vi si insinuano volti, schemi di volti (più spesso di profili) si impigliano nel tracciato mobile, vi si stiracchiano, vi si torcono, simili a quelle teste d’aviatore sottoposte a una pressione eccessiva che malmena le loro guance, la fronte, come si farebbe col caucciù...» (MM, p. 138); «...l’orrore stava soprattutto nel fatto di essere soltanto una linea. Nella vita normale, si è una sfera che discopre panorami. Ci si trova in un castello da un momento all’altro, si passa senza tregua di castello in castello, tale è la vita dell’uomo, anche del più povero, la vita di un uomo sano di mente... Qui, una linea soltanto. Una linea che si spezza in mille aberrazioni. La fune della frusta di un carrettiere inferocito sarebbe stata, per me, il riposo. Né compassione, neppure compassione. L’accelerato lineare, che ormai ero diventato, non indietreggiava, faceva fronte a ogni sbranatura, stava per riformarsi, riusciva quasi a riformarsi, quando la forza su di lui, più rapida di un bolide… Era atroce, perché resistevo...» (MM, p. 150).
La semplice frase “era atroce, perché resistevo” ci illumina sul magistero di Michaux: è, la sua, una scrittura spinta fino al limite estremo, che diventerà poi segno e pittura senza subire le convenzioni né dell’una né dell’altra, ma restando immune, lucida, autodeterminata. La “resistenza” al dolore si trasfigura in fermezza di stile. Scrive Cioran di lui: «Lo ammiravo per la sua chiaroveggenza aggressiva, per i suoi rifiuti e le sue fobie, per l’insieme delle sue avversioni. Quella notte, nella stradina dove stavo discutendo da ore, mi disse, con una punta di emozione del tutto inattesa, che l’idea della sparizione dell’uomo gli faceva un certo effetto… Lo lasciai subito dopo, persuaso che mai gli avrei perdonato quell’intenerimento e quella debolezza. Se estraggo da un quaderno senza data questo appunto, ingenuo quanto possibile, è per far vedere che a quel tempo apprezzavo in lui soprattutto l’aspetto incisivo, spasmodico, “inumano”, le sue esplosioni e i suoi ghigni, il suo humour da scorticato, la sua vocazione di convulsionario e di gentleman. In verità mi pareva secondario che fosse poeta. Un giorno, ricordo, mi confessò che si chiedeva se lo era. Lo è, evidentemente, ma si può concepire che avrebbe potuto non esserlo (EA. pp. 156-157).
Essere o non essere poeta: quesito non fondamentale per lo scrittore Michaux, destinato a esplorare i disincanti dell’invisibile non senza prima diventarne oggetto reale, sentinella fisica e psichica. Gli ultramondi: ecco la sola materia capace di eccitare l’enigmatico scrittore. «Il nervoso e ritmico Michaux spinge “appena” la sua scrittura e la sua pittura a quel “leggero vacillare” che è la sua concezione dell’uomo: un uomo che ha deposto qualsiasi certezza per preservare il proprio inattingibile espace du dedans dal generale dissolvimento e dall’aggressione del mondo. E lo fa attingendo energie da due universi estremi, solo apparentemente separati: quello favoloso e astratto – il “fuori di sé” che con le parole ha tentato di descrivere – e quello reale e arcaico – il “dentro di sé”, che i segni hanno portato alla luce» (SVS, p. 88).

Michaux, sempre lontano dalla terra che abita, ci offre in modo spudorato il suo stesso cielo, un cielo in cui si chiede “dove posare la testa?”
«Ostruito, adesso, sbarrato, ricolmo di macerie;
un cielo a causa dell’emicrania della terra
spoglia di cielo
cielo perché non c’è più un luogo dove posare la testa
Traversato, ristretto, rientrato, tarpato, a tratti sfatto,
nelle esplosioni e nei fumi irrespirabile
buono a nulla
un cielo irritrovabile ormai» (HM, p. 38)
Leggendo questi versi si scopre, con il poeta, la necessità di varcare ogni limite inventandone di nuovi, non sospesi in vaghezze poetiche. La penna-pennello di Michaux è anche oggi il giusto bisturi per rendere l’uomo consapevole di quanto, con l’arte, potrebbe sfidare ancora le insidie e le miserie del mondo. L’acuminata fermezza dello stile dimostra che non esiste arte che non sia arte irriducibile e violenta, capace di estrarre la creatura umana dall’inerzia.
Dalla sua perlustrazione dell’universo mescalinico Michaux ricava riflessioni perturbanti sulla natura dell’arte e della sragione: «Dello spettacolo mutato di quanto ci circonda e ancora più delle visioni ci si può beare. Inebriarsene e per ore intere studiarle. Seguire il passaggio dall’immagine al pensiero. Osservare le irregolarità, le connessioni errate del pensiero, gli errori dello strumento pensante, ora sbalestrato, le illusioni dell’uomo che possiede questo fragile strumento pensante. Scoprire le spinte improvvise e violente verso l’alienazione, verso gli atti assurdi, pericolosi, mortali. Si coglie in qualche modo la composizione dell’universo della follia, soprattutto la sua struttura» (MM, pp. 192-193).
Michaux, sedotto dalle illusioni che distorcono un reale per lui indefinibile, attratto dall’universo della follia come da quella voce necessaria che occorre sempre udire, sottopone la mediocre condizione umana alla prova dell’infinito, come ci ricorda Carlo Mazza Galanti nella postfazione. Ma paga il prezzo della sua audacia, nel voler sapere ai confini del non-sapere, con i soprassalti di una percezione annientante. Non si arrende all’esperienza della mescalina ma la vuole provare per descriverne l’ineffabilità. Così costringe la sua scrittura, già lanciata verso regni fantastici nei libri precedenti, a un velocissimo tour de force che, in Miserabile miracolo, comprende note a margine, enumerazioni, trattini, grafismi, neologismi, scarabocchi, scritture asemiche, scatenandosi in una stenografia arcaica e preverbale che intercetta gli effetti mescalinici. Michaux, pervaso da lirici stati di grazia e da stati di turbolenza, fa esplodere i meccanismi del suo stesso linguaggio: la sua scrittura lascerà presto le frontiere della parola munita di senso per diventare gesto pittorico elettrico, convulso, sovversivo, tache irriducibile al senso. Ma, per realizzare questo, non può che immergersi, prima, nel personale disordine psicosomatico dell’esperienza mescalinica, senza altra difesa che il proprio vertiginoso “io-penna”, senza nulla di sacrale che non sia il laico misticismo di un esploratore dell’ignoto “soma-mente”.
Libri consultati
HM – in Henri Michaux. L’infinito plausibile. Arca 5, 2000, Graphos, a cura di L. Frisa
MM - Miserabile miracolo. La mescalina, tradotto da Claudio Rugafiori con postfazione di Carlo Mazza Galanti, Quodlibet, Macerata 2025.
SVS - L. Frisa, Movimenti di penna. In Henri Michaux, Sulla via dei segni, Graphos, Genova 1998, p. 79-80.
EA - E. Cioran, Esercizi di ammirazione, trad. di L. Zilli, Adelphi, Milano 1986.
In copertina, opera di Stephen Eichhorn.







