La bellezza dell’ombra
All’origine della filosofia vediamo le ombre proiettate sul muro della caverna di Platone e all’origine della pittura incontriamo la figlia del vasaio Butades che disegna il contorno dell’ombra dell’amante: il primo a cercare una correlazione tra il mito di Platone e quello Plinio è stato lo storico dell’arte Victor Stoichita che, nella sua Breve storia dell’ombra (apparsa già nel 1997 in inglese e nel 2000 e nel 2023 in italiano) ha percorso le tappe di questa proiezione in negativo che ogni giorno accompagna fedelmente i nostri passi e della quale quasi non ci accorgiamo. Simbolo dell’evanescenza nel regno delle ombre degli antichi e nell’aldilà di Dante, ma nello stesso tempo «ombra della carne» che rende la consistenza materiale dei corpi con il chiaroscuro, l’ombra nello studio di Stoichita è oggetto di approfondimento filosofico e storico-artistico. Questo doppio approccio aveva permesso a Stoichita di individuare un percorso coerente nella storia dell’ombra e di illustrarne alcuni momenti particolari, come ad esempio l’uso delle silhouette da parte dello studioso di fisiognomica Johann Caspar Lavater o le incisioni che illustrano la storia di Perter Schlemihl di Adalbert von Chamisso nelle quali il diavolo arrotola l’ombra a partire dalla testa oppure dai piedi, o ancora la passione di Andy Warhol per le ombre metafisiche di Giorgio De Chirico. Sono solo alcuni esempi di come l’ombra possa costituire il filo di una riflessione sull’io, sulla sua identità e insieme sull’estraneità perturbante accennata da Nietzsche nel breve racconto che apre la seconda parte di Umano, troppo umano e che ha per titolo Il viandante e la sua ombra. Il viandante sente una voce: «Una voce: – dove? e chi? Mi pare quasi di udir parlare me stesso, solo con voce ancor più debole che la mia».
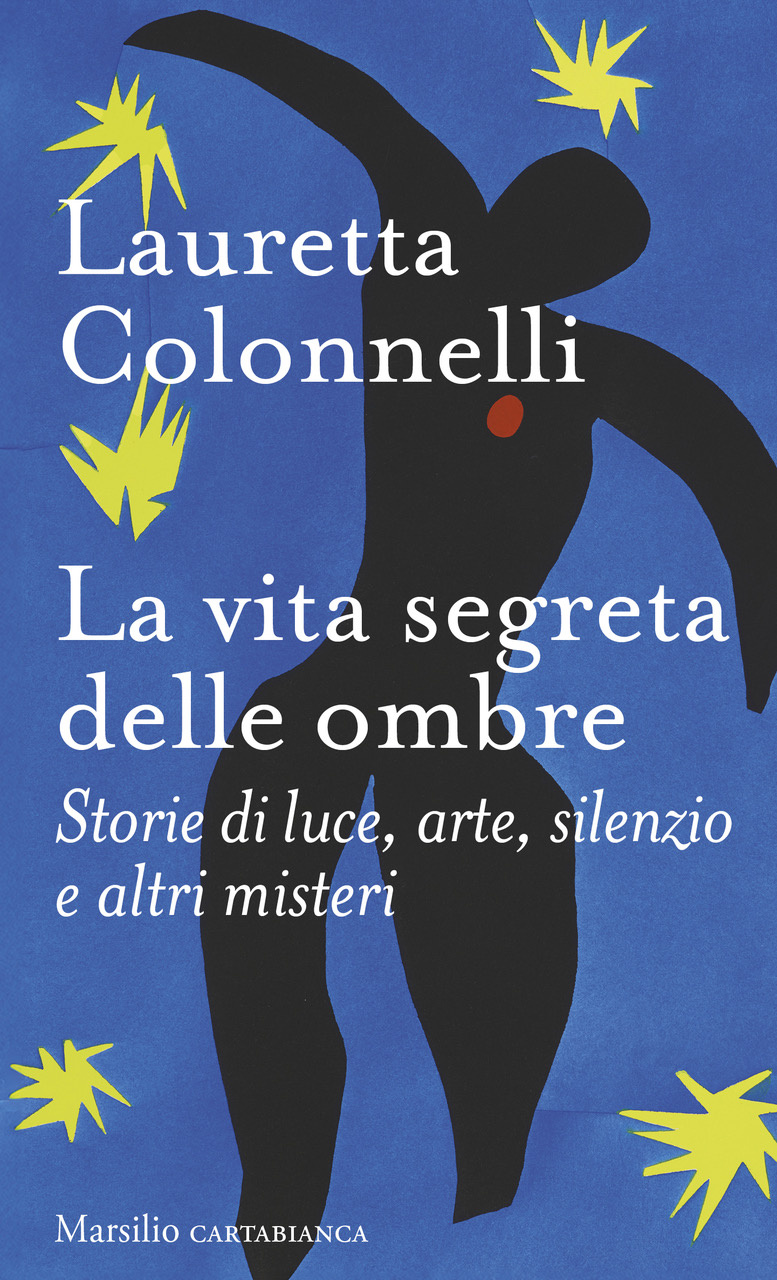
Il tema dell’ombra ricompare in due libri appena pubblicati. Il primo, della giornalista e critica d’arte Lauretta Colonnelli, La vita segreta delle ombre. Storie di luce, arte, silenzio e altri misteri (Marsilio, Venezia 2025), costituisce una sorta di continuazione o completamento dell’altro suo testo, La vita segreta dei colori. Storie di passione, arte, desiderio e altre sfumature (Marsilio, Venezia 2023; cfr. qui la recensione). È una raccolta di centinaia di aneddoti, spunti di riflessione, indicazioni di lettura, brevi analisi di racconti e romanzi, rendiconti di ricerche scientifiche in astronomia, botanica e geologia. Talvolta il tema si allarga ad argomenti vicini, come il buio o l’oscurità, il nero della notte, delle macchie, dei buchi, dei tatuaggi, delle cene nere e delle città ipogee, oppure all’uso della parola come metafora che ne dilata la trattazione in una narrazione leggera, talora allusiva, spesso profonda.
Scegliendo in modo arbitrario qualche argomento posso ricordare il carattere delle ombre proiettate dai diversi alberi nella delicata trattazione di Plinio: l’ombra opprimente del noce e del pino, gli sgocciolamenti del pino, della quercia, del leccio, l’ombra leggera dei fichi e quella dolce e gradevole dell’olmo, ma anche del platano e infine quella del pioppo che non ha ombra per il continuo danzare delle foglie. Possiamo poi divertirci nel leggere i Consigli inutili di Malerba che contemplano l’idea di fabbricare ombre, grandi ombre, difficili da realizzare, di monumenti e grattacieli oppure ombre leggere come merletti e, di nuovo, ombre di diversi alberi: «la più malinconica – scrive Malerba – è quella di salice piangente soprattutto se si specchia nell’acqua di un lago», poi ombre notturne e lunari, ombre di animali e – alla fine e più facili – ombre umane, tra cui scegliamo senz’altro l’ombra di signora con il cagnolino al guinzaglio… Oppure possiamo anche accontentarci della nostra ombra, senza sperare però di poterci rifugiare all’ombra di noi stessi… La citazione di Malerba è occasione per Colonnelli di ricordare la proposta del muralista americano di salvare, dopo la sua distruzione, almeno l’ombra del Singer Building di New York ricreandola con una vernice nera.
Un’altra indicazione importante è Il libro d’ombra di Tanizaki Jun’ichirō (1933) che ci rivela un modo completamente diverso di considerare le ombre nell’abbigliamento femminile, nell’arredamento delle case, nei cibi e negli oggetti della cucina e della tavola, perfino nelle toilette degli antichi monasteri, alla scoperta della «bellezza dell’ombra». Bellezza che diventa da noi malinconica come nei versi seguenti, citati dall’Elogio dell’ombra di Jorge Luis Borges: «Vivo tra forme luminose vaghe / che ancora non sono tenebra. / […] Questa penombra è lenta e non fa male; / scorre per un mite pendio / e somiglia all’eterno».
Ma esiste un potere positivo delle ombre anche nella tradizione occidentale come nel loro uso come strumento di satira. Lo racconta Ernst Gombrich in Ombre (1995), qui citato da Colonnelli: nel 1830 Jean-Ignace-Isidore Gérard, detto Grandville, aveva disegnato i ministri francesi e le loro ombre con le sembianze di un pedone della scacchiera, di un diavolo, di un maiale e di un tacchino.
In tutt’altro contesto il potere positivo dell’ombra si rivela nella Bibbia e si riflette nella pittura occidentale: compare nell’affresco di Masaccio nella chiesa del Carmine di Firenze che raffigura Pietro che risana gli infermi con la sua ombra, ma assume un significato teologico ancora più importante nel Vangelo di Luca indicando la capacità di fecondare la Vergine da parte dello Spirito Santo, concetto che viene ripreso nella Legenda aurea di Iacopo da Varazze.
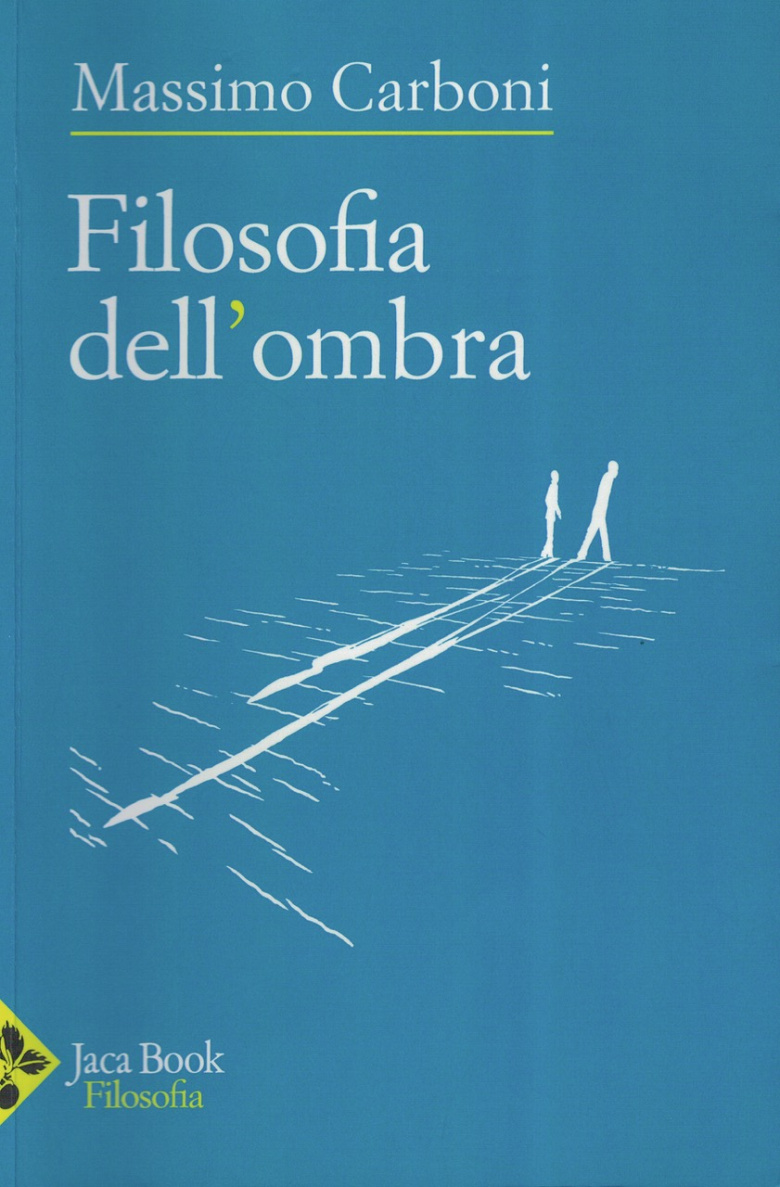
Quest’ultima citazione ritorna nel secondo libro di cui voglio parlare, Filosofia dell’ombra di Massimo Carboni (Jaca Book, Milano 2025): nel capitolo finale di questo testo l’autore riprende l’analisi dell’espressione obumbrabit, usata da Luca per indicare l’atto dell’Altissimo che «coprirà con la sua ombra» la Vergine: non potremmo allora forse chiederci – scrive Carboni – come è fatta l’ombra di Dio? Aggiunge però che le traduzioni dall’ebraico shakan con il greco episkiazō, già nella versione dei Settanta, e con il latino obumbrare, introducono un elemento iconico non presente nella parola ebraica che significa ‘abitare’, ‘dimorare’.
È questa la conclusione di un lungo e impegnativo percorso che parte dalla riflessione sul rapporto tra l’ombra e la luce, opposizione che viene analizzata e confrontata con quella tra invisibile e visibile, assenza e presenza, e viene perseguita con un linguaggio che si compiace degli accostamenti dialettici prendendo a modello la filosofia della decostruzione di Jacques Derrida. Particolare importanza assumono in questo contesto alcuni riferimenti al De umbris idearum di Giordano Bruno, libro complicato e (credo) illeggibile, intriso di astrologia e di magia, derivata dai testi religiosi degli antichi egizi, dal quale Carboni cita l’ossimoro dell’«umbra lucis». Ancora più difficile mi è parsa la lettura del tema dell’ombra nella teoria estetica di Heidegger, secondo cui l’opera d’arte è «un canto della Terra che si dispiega aperto alla Luce che illumina l’Ombra svelandola come la propria trattenuta, custodita, intima risorsa» (p. 49). Più chiaro mi sembra il riferimento a Maurice Blanchot e alla sua analisi del mito di Orfeo e Euridice sempre in relazione al significato dell’opera d’arte che può realizzarsi solo perdendo sé stessa, come Orfeo perde sé stesso volgendosi verso l’ombra di Euridice.
Dopo un excursus sulla scienza fisica relativistica e quantistica che conferma secondo l’autore l’impossibilità di raffigurare e verbalizzare il mondo, l’autore torna alla filosofia. Esamina dapprima la teoria della percezione di Edmund Husserl secondo la quale noi percepiamo la cosa attraverso successivi ‘adombramenti’ e passa poi ad analizzare la funzione essenziale della metafora nel linguaggio secondo Henri Bergson e conclude con una battuta: se il linguaggio getta una lunga ombra sulla cosa che vogliamo conoscere, non si può davvero saltare oltre la propria ombra…
Accanto ai richiami filosofici Carboni accenna anche all’uso delle ombre nel cinema espressionista nel quale esse si rivelano come presenze minacciose, si allungano sulla scena, si profilano sulle pareti, «annullano ogni apparenza quotidiana per trasfigurandola in una fonte di mistero inesplicabile indicandone da lontano l’insospettata e perturbante alterità» (p. 38).
Grandville, Le ombre (1830)







