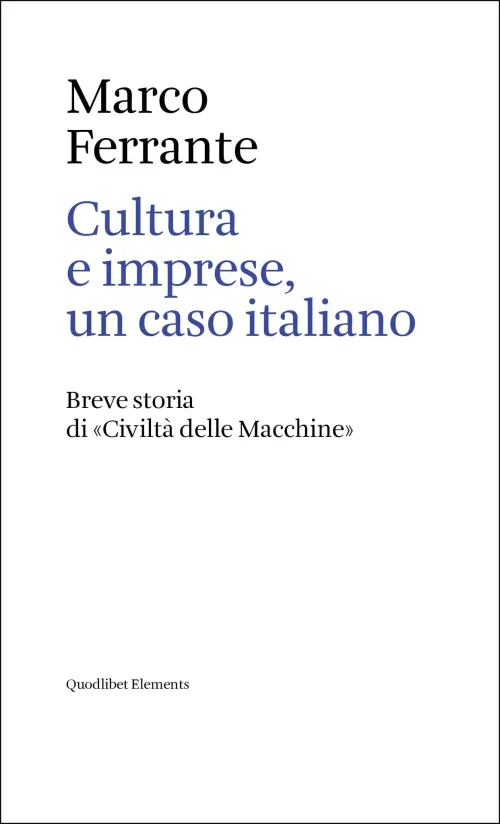La vera storia della Civiltà delle macchine
Negli anni Cinquanta l’Italia cominciava a modificare la propria identità, da nazione contadina andava rapidamente trasformandosi in potenza industriale e, mentre le città crescevano a vista d’occhio e le campagne si spopolavano, le fabbriche diventavano le nuove cattedrali della modernità. A questo cambiamento epocale, però, non sempre corrispondeva un’adeguata risposta culturale. I linguaggi della tecnica e della scienza restavano ai margini del pensiero intellettuale dominante, saldamente ancorato a una tradizione umanistica che guardava alla modernità (non solo a quella industriale) con diffidenza, se non addirittura con esplicita ostilità per le ragioni più disparate e forse incomprensibili. Prende avvio da qui il discorso di una malintesa interpretazione del moderno ed è proprio in questo scenario che si colloca l’esperienza editoriale di «Civiltà delle Macchine», la rivista della Finmeccanica tenuta a battesimo da due figure-chiave nell’ambito del dialogo tra le “due culture”: un manager-umanista. Giuseppe Eugenio Luraghi (scrittore, poeta, editore, dirigente di Pirelli e futuro presidente dell’Alfa Romeo) e un poeta-ingegnere, Leonardo Sinisgalli, a cui fu affidata la direzione per i primi cinque anni, vale a dire fino al 1958. Fondata nel 1953 su iniziativa della Finmeccanica, la rivista non si limita a essere soltanto uno strumento di comunicazione interna o di promozione industriale, in linea con tutti gli altri house organ. Sotto la guida dell’ingegnere-poeta diventa qualcosa di molto più ambizioso: un laboratorio intellettuale, un ponte tra la cultura umanistica e quella tecnico-scientifica, un luogo di dialogo tra arte, industria, etica e scienza. Il fenomeno appartiene anche a molte altre simili testate del secondo dopoguerra – per esempio «Rivista Pirelli» del 1948, «Notizie Olivetti» del 1952, «Il Gatto Selvatico» del 1955, «Rivista Italsider» del 1961, «Il Quadrifoglio» del 1967 – che tentarono la strada di un possibile incontro tra i mondi della cultura, da cui spesso attingevano uomini e idee, e della tecnica, dove esisteva la cultura del lavoro, a cui si dava un’interpretazione dimessa, come semplice realizzazione di oggetti o applicazione di determinati risultati tecnici.
Il dato interessante di queste iniziative legate alle maggiori realtà del panorama industriale (Pirelli, Eni, Olivetti, Alfa Romeo, Finmeccanica, Italsider) è che quasi sempre furono affidate a scrittori o ad artisti. A parte il caso di Sinisgalli che fu direttore di «Rivista Italsider», «Civiltà delle Macchine» e «Il Quadrifoglio», ricordiamo «Notizie Olivetti» affidata a Libero Bigiaretti, «Il Gatto Selvatico» ad Attilio Bertolucci, «Rivista Italsider» a Eugenio Carmi. E questo conferma che in Italia è esistito per davvero il tentativo di declinare una forma originale di capitalismo che, oltre agli obiettivi a breve termine – l’incontro tra la cultura d’impresa, la visione sociale, l’innovazione grafica ed editoriale – cercava di modificare l’immagine dell’industria da motore economico in mecenatismo, da realtà produttiva in strumento di promozione umana e sociale. Ed è questo, in ultima analisi, l’aspetto peculiare che fa di «Civiltà delle Macchine» qualcosa di molto originale perché, nonostante fosse un house organ aziendale – scrive Marco Ferrante in un recente suo libro – «interpreta il ruolo come fiancheggiatore dell’industrialismo e come pensatoio di una modernità in cui conta la funzionalità dei mezzi di produzione, il ruolo dell’essere umano e l’estetica novecentista del progresso» (Cultura e imprese, un caso italiano. Breve storia di «Civiltà delle Macchine», Quodlibet, p. 147, euro 15).
Uno strumento editoriale fatto per pensare, dunque: un’immagine assai convincente di ciò che i fascicoli vollero raggiungere per quanto attiene alla densità simbolica, alla carica visionaria, all’ambizione intellettuale, elementi caratterizzanti che potrebbero trovare il punto d’incontro in una domanda radicale: può una rivista industriale diventare una rivista di cultura? Sinisgalli rispose a questa domanda con un’operazione editorial-culturale concreta, costruita numero dopo numero, articolo dopo articolo, in cui le macchine non erano solo oggetti d’uso, ma simboli, archetipi, metafore del mondo moderno. Certo Sinisgalli non lo si può definire un manager, né un giornalista d’impresa, piuttosto un intellettuale atipico nel panorama, con una laurea in ingegneria e un cuore da poeta, cresciuto tra la Basilicata e i cenacoli culturali romani e milanesi, eppure con il cannocchiale puntato nella stessa direzione: conferire dignità etica, filosofica e perfino estetica all’universo della tecnica, introdurre nell’immaginario di una nazione ancora troppo condizionata dalla filosofia crociana, che differenziava i gradi della cultura, i cardini di un sapere che varcasse la corrosiva distinzione tra poesia e non poesia.
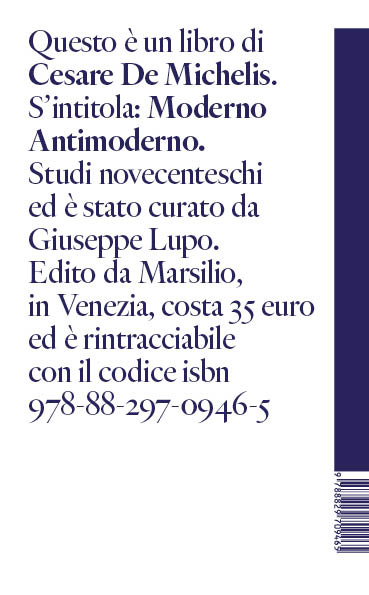
Non a caso la rivista ospitava riflessioni sull’ingegneria, sull’architettura, sulla scienza, tra le sue pagine si trovavano articoli su Leonardo da Vinci, sulla bellezza dei ponti, sull’eleganza delle turbine, sul ritmo delle catene di montaggio. Il vero protagonista era sempre la macchina, considerata non come un semplice oggetto, ma come presenza simbolica, quasi mitica, archetipo di una trasformazione capace di raccontare l’evoluzione dell’uomo moderno. Scrisse Sinisgalli nel 1965: «Nel 1953, quando misi a punto il progetto di “Civiltà delle Macchine”, la cultura dell’Occidente era ancora incredibilmente arretrata e scettica nei confronti della tecnica. Io volevo sfondare le porte dei laboratori, delle specole, delle celle». La rivista nacque dunque per scardinare il ritardo dei letterati, per spingere gli intellettuali a considerare le fabbriche non solo come luoghi di alienazione, ma anche come spazi di intelligenza, innovazione, creatività. Su questo tema Ferrante fa un’annotazione che merita di essere citata: «rivista di derivazione bauhausiana» che «si proietta in un futuro in cui uomo e macchina cercano di confrontarsi su un piano poetico, il suo obiettivo è propagandistico/pubblicitario, non ideologico».
Di fronte a un’epoca che ha fatto del rapporto con la modernità (e con la modernità industriale nello specifico) il banco di prova per testare la radicalità ideologica, «Civiltà delle Macchine» esclude ogni forma di approccio pregiudiziale e, sfruttando il format di una struttura polifonica, in cui coesistono articoli firmati da tecnici, artisti, scrittori, ingegneri, filosofi, fa di ogni numero un viaggio tra epoche e forme espressive diverse. Il passato dialogava con il futuro, l’arte con la scienza, la tradizione con l’innovazione. L’obiettivo era chiaro: superare la frattura tra le “due culture”, quella scientifica e quella umanistica, in un Paese che, come disse lo stesso Sinisgalli, preferisce il pastore al tecnico, la Musa alla macchina. Che ci fosse un pericolo d’arcadia nell’atteggiamento degli intellettuali è un tema scontato. Arcadia nel senso di contrapposizione al moderno, diciamo anche antimodernità secondo il paradigma che Cesare De Michelis ha stabilità in suo ampio saggio, Moderno Antimoderno, uscito nel 2021. Perciò «Civiltà delle Macchine» non aveva nulla per diventare il manifesto di un’altra ideologia. Non celebrava in modo acritico il progresso. Non inseguiva mode né proponeva un’adesione ingenua alla modernità. Anzi poneva domande scomode: fino a che punto le macchine possono avere un valore etico?
Possono sostituire la fatica umana senza cancellarne la dignità? Esiste una grammatica della tecnica che possiamo leggere poeticamente? Ciò attribuisce ai numeri di cui Sinisgalli fu direttore un valore non solo storico, ma etico. In un’epoca dominata dalla tecnologia – dalle piattaforme, dagli algoritmi, dalle intelligenze artificiali – torna urgente interrogarsi sul rapporto tra uomo e macchina, tra cultura e innovazione, tra sapere tecnico e visione etica. Resta tuttora aperto il quesito finale con cui Ferrante congeda il lettore: «Il titolo alludeva alla civiltà costruita sulle macchine? O al tasso di umanesimo che le macchine possono contemplare? Oppure ancora alla cultura dell’uomo al tempo delle macchine?». Forse la risposta sta proprio nella tensione tra questi poli. Ed è in quella tensione che «Civiltà delle Macchine» continua a risultare un esperimento abbastanza isolato nella storia editoriale italiana: un house organ che divenne opera d’arte, strumento critico, frontiera intellettuale. Una sfida ancora oggi irrisolta. Nel pieno dell’era digitale essa ci ricorda che non c’è tecnica senza pensiero, non c’è progresso senza visione. E ci suggerisce anche quanto sia necessario un nuovo umanesimo capace di dialogare con l’ingegneria, un’estetica che non escluda il dato scientifico, una politica che sappia orientare lo sviluppo tecnologico verso il bene collettivo. E se le macchine del presente non sono più bulloni e turbine ma algoritmi e reti neurali, il bisogno di raccontarle e capirle è più vivo che mai.