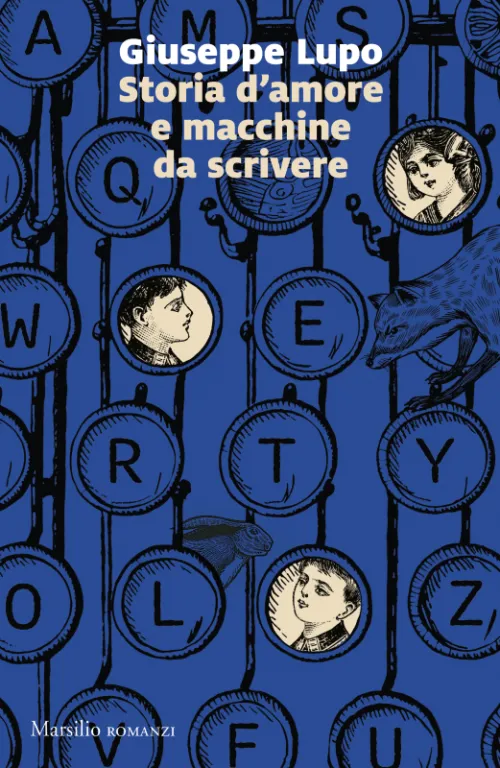Lo scrittore con la Lettera 22
Il 21 giugno 2025, a Skagen, nella penisola danese dello Jutland, dove i turisti accorrono per ammirare la linea che si forma sull’acqua, suggestivo e instabile confine fra due mondi, nel punto in cui il Mare del Nord e il Mar Baltico si toccano senza mescolarsi, l’inviato del Modern Times Salante Fossi insegue il grande scienziato Sandór Molnár, il Vecchio Cibernetico, durante la festa per il suo novantacinquesimo compleanno, per intervistarlo a proposito della straordinaria invenzione che gli ha valso una candidatura al Nobel: Qwerty si chiama il congegno misterioso a cui Molnár sta lavorando da tempo e che porta il nome delle prime sei lettere delle tastiere ancora oggi largamente in uso, una sequenza derivata dalla leggendaria macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, oggetto feticcio che all’inizio degli Anni Cinquanta ha rivoluzionato il sistema di scrittura meccanica.
Nella confusione dei festeggiamenti, l’intervista si rivela più complicata del previsto, fra false partenze, interruzioni improvvise e momentanee eclissi: il Vecchio Cibernetico, un signore con baffi spioventi che lo fanno somigliare a Walter Benjamin, cappello da marinaio, camicia a righe colorate e ciabatte, elude le domande, divaga, si ingozza di torta, si addormenta. Al segreto dell’invenzione rivoluzionaria che non viene svelato si aggiunge un altro mistero: l’inspiegabile assenza di Ann Lee, la moglie di Molnár, figura così enigmatica e sfuggente da far dubitare della sua reale esistenza.
Il racconto si mette in moto grazie alla presenza di un oggetto d’affezione: il Vecchio Cibernetico tiene sempre con sé la custodia in pelle della sua Olivetti Lettera 22, uno scrigno di ricordi dal quale estrae fotografie, lettere, mappe, ritagli di giornale, fogli di appunti. Con quei materiali e i frammenti di racconto carpiti al suo interlocutore il giornalista si vede costretto a ricostruire la storia del Vecchio Cibernetico giocando una singolare partita a scacchi. Dal baule della memoria affiora una stradina del centro di Budapest, Bástya utca, dove al numero 18 abitava la famiglia di Sandór, il padre ombrellaio, la madre figlia di commercianti di granaglie, entrambi di origini ebraiche, le due sorelle, Ezster, la più grande, e la piccola Margit, intravista per l’ultima volta mentre gioca per strada, a sei anni, con un vestitino rosa, il giorno in cui il giovane e brillante ingegnere che ha da poco discusso una tesi sui rapporti fra la luce e l’immaginazione deve lasciare la sua città all’improvviso, poco prima dell’arrivo dei carrarmati russi, il 4 novembre del 1956.
I luoghi da cui Molnár è costretto a separarsi si affacciano dalle pagine del romanzo con straordinaria vividezza e intensità: i colori bruniti delle grandi finestre, gli odori della bottega dell’erbivendolo, le voci, i rumori delle tante attività che si affacciano sulla via. Qui la scrittura di Lupo, in continuità con le sue precedenti prove a vocazione corale, tocca i punti più alti e ci fa vivere nell’animazione di un quartiere che di lì a poco verrà lacerato dai tank.
La Lettera 22, il talismano da cui Molnár non si separa mai, apre un varco fra mondo immaginato e realtà storica: la macchina da scrivere è un dono ricevuto dal grande fisico Dénes Gábor, premio Nobel nel 1971 per aver inventato l’ologramma. La tastiera, che può diventare labirinto, pianoforte, mappa, è metafora che irradia ogni aspetto del racconto di Molnár: il flusso dei ricordi sembra infatti accordarsi al ritmo sincopato delle dita che battono sui tasti, il ticchettio del «concerto di martelletti» che diventerà il sottofondo delle sue giornate quando, dopo aver attraversato l’Europa in clandestinità, aiutato da Katalin, incontrata nell’antico cimitero ebraico di Praga e divenuta poi sua moglie dopo aver cambiato il suo nome in Ann Lee, l’ingegnere approda a Ivrea, nello stabilimento ideato da Adriano Olivetti, al cui destino la vita di Sandór Molnár, anche lui come Ann Lee consegnato a una nuova identità con il nome di Franz Löw, poi di Balthazar Hirschmann, si lega a doppio filo.

La seconda parte del racconto si apre dopo che il Vecchio Cibernetico accompagnato da Salante che ha fretta di mandare il suo pezzo al giornale e dalla signora De Pineiro, domestica e assistente del Vecchio Cibernetico, si spostano in Portogallo, a Cabo da Roca, luogo che ha molte affinità con Skagen per il suo carattere di finis terrae. Con lo stesso rapido andirivieni nel tempo, dalla casa affacciata sull’oceano da cui si intravede l’ultimo lembo d’Europa, Molnár ritorna ai viaggi con la moglie nella fuga verso Ovest. Qui il ritmo del racconto è scandito dal battere dei tacchi di Ann Lee che impara i passi del flamenco una volta giunta in Europa, dopo aver cambiato oltre al nome anche il colore dei capelli per nascondere le sue origini praghesi, e da uno splendido pezzo di John Coltrane, My favorite things, che molto ha a che fare con l’orchestrazione insieme mobile e “tenuta” di una narrazione che alterna tonalità maggiori e minori con grande agilità. Le città d’Europa si avvicendano finché la coppia approda a Borgonuovo, piccola località alle porte di Milano, dove il destino di Adriano Olivetti, la cui storia è di per sé romanzesca, si intreccia a quella di Mario Tchou, l’ingegnere che ha progettato per lui la Elea 9003, primo elaboratore elettronico a transistor, ispirato da un’idea di Enrico Fermi, gioiello di progettazione e di design che valse a Ettore Sottsass il compasso d’oro nel 1959.
Saranno le circostanze della morte prematura di Olivetti, in treno per un improvviso malore nel 1960, e Tchou, in un incidente d’auto nel 1961, a rivelare un legame nascosto nelle vite di Molnár e di Salante Fossi, un singolare intreccio di costellazioni che convince il Vecchio Cibernetico a rivelare al giornalista il segreto della sua macchina futuristica, nata anch’essa dall’incrocio di due universi che si toccano senza compenetrarsi. La sua invenzione – dice Molnár nel discorso di Skagen –, nasce dalla somma di mari e scritture, ecco perché ha scelto lo Jutland per festeggiare il compleanno, nel giorno del solstizio d’estate, che a sua volta è l’immagine di un confine assai più mutevole e poetico di quello che ha diviso l’Europa prima del crollo del muro di Berlino.
L’intervista si mostra allora come ricapitolazione di una vita e come compendio di una civiltà: il sogno del giovane ingegnere fuggito suo malgrado dall’Ungheria è la creazione di una lingua poetica che non nasca da una geografia fatta di confini invalicabili, una sorta di esperanto che si accorda ai sogni dei visionari che fra Ivrea e Borgonuovo hanno battuto sul tempo i colossi americani, inventando per primi il calcolatore del futuro.
La macchina misteriosa progettata da Molnár, di cui non sveleremo nulla per non rovinare la sorpresa che arriva solo nelle ultime pagine, sembra appartenere tuttavia più a un futuro distopico che a una visione felice. Il sogno del fisico che studiava la creatività e la luce sul tavolo ingombro di cavi e computer di ogni epoca del Vecchio Cibernetico è diventato qualcosa d’altro. E anche l’intervista alla fine avrà una forma che Salante Fossi mai si sarebbe aspettato. Non tutto si può raccontare, ci sono misteri in una vita destinati a rimanere tali.
Il romanzo, fitto di microracconti di memoria, che si affacciano, si eclissano e poi ritornano con nuovi particolari in una costruzione virtuosistica che attraversa un settantennio di storia del nostro tempo, altro non è – si comprende nell’epilogo – che un poema del silenzio, dello spazio vuoto fra i tasti della Lettera 22, dei pensieri che non hanno parole. «Quale storia laggiù attende la fine?», potremmo chiederci rievocando il finale di Se una notte d’inverno un viaggiatore, complessa costruzione narrativa a cornice che con questo romanzo ha non poche tangenze. Proprio qui, sull’orlo dell’indicibile, in quella vacanza del linguaggio dove le macchine non possono arrivare – ci dice Giuseppe Lupo con il suo intenso e avvincente romanzo sospeso fra storia e invenzione – sta l’essenza del nostro essere persone umane.