Premio Nobel / Louise Glück, la durezza della poesia
Io non ero presente, e il piccolo aneddoto mi è stato raccontato da un poeta italiano. Il luogo è Yale University, all’incirca nel 1992, quando Louise Glück, ora Premio Nobel per la letteratura 2020, ha appena pubblicato The Wild Iris, un libro in cui, come scrisse un critico allora, pare che l’autrice abbia solo due preoccupazioni: i fiori, e suo marito. Dal marito avrebbe divorziato. Dai fiori, mai, perché una parte consistente della poesia di Louise Glück consiste appunto nel dar voce ai fiori. In quell’occasione, Louise Glück partecipava a una tavola rotonda sulla poesia, e qualcuno le fece l’inevitabile domanda: a quale poeta, uomo o donna, si ispirava? A quale linea della letteratura americana? Chi l’aveva influenzata? (Domanda cruciale in quegli anni a Yale, sia per chi seguiva le teorie dell’influenza poetica di Harold Bloom, sia per chi le rifiutava abbracciando il postmodernismo e la decostruzione.) Louise Glück rispose: “La prossima domanda, per favore”. Chi mi raccontò l’episodio mi fece notare che se la domanda fosse stata rivolta a un italiano, i presenti sarebbero stati sepolti da una valanga di riferimenti: nella mia formazione c’è stato questo, e quest’altro, e il mio maestro è stato, e le mie prime letturesono state ecc. ecc. Non so se sarebbe così per tutti, a dire il vero. Conosco vari poeti italiani per i quali il mondo è cominciato con loro – o, come Saba, prima di loro riconoscono solo Dante. Ma Louise Glück, da brava americana, aveva tagliato il cordone ombelicale: state parlando con me, non con Emily Dickinson o Robert Lowell. C’è un generale tono scorbutico nelle sue poesie, soprattutto nelle prime. Non ha mai avuto reticenze a parlare di sé, ma non aspettatevi da lei il pathos del poeta confessionale che vi fa piangere e/o vi rende forti con le sue miserie. Non è Anne Sexton, non è Sylvia Plath. Se leggete Louise Glück, state leggendo un poeta duro. Non che Sexton e Plath non lo siano – lo sono soprattutto con loro stesse – ma Glück è dura soprattutto con i suoi lettori. Non trovo esempio migliore di questo, dalla raccolta Descending Figure, del 1980:
The Drowned Children
You see, they have no judgment.
So it is natural that they should drown,
first the ice taking them in
and then, all winter, their wool scarves
floating behind them as they sink
until at last they are quiet.
And the pond lifts them in its manifold dark arms.
But death must come to them differently,
so close to the beginning.
As though they had always been
blind and weightless. Therefore
the rest is dreamed, the lamp,
the good white cloth that covered the table,
their bodies.
And yet they hear the names they used
like lures slipping over the pond:
What are you waiting for
come home, come home, lost
in the waters, blue and permanent.
I bambini annegati
Lo vedi, non hanno giudizio.
Per forza poi annegano,
prima il ghiaccio che li porta sotto
e poi, per tutto l’inverno, le sciarpe di lana
che gli ondeggiano dietro mentre affondano
finché infine se ne stanno quieti.
E lo stagno li solleva nelle sue molte, nere braccia.
Ma la morte gli arriva in un altro modo,
molto prossima al principio.
Come se fossero sempre stati
ciechi e senza peso. Perciò
il resto è sognato, la lampada,
la tela bianca, quella buona, che copriva il tavolo,
i loro corpi.
Eppure sentono i nomi che si usavano
come richiami scivolanti sullo stagno:
che cosa aspettate,
tornate a casa, tornate a casa, perduti
nelle acque, azzurre e permanenti.
Non ci sono compromessi. La poesia di Glück è irta, spinosa, fatta per mettere il lettore, e la lettrice, di fronte a uno specchio che tutto riflette tranne le sue brame (le brame di chiunque, incluse quelle dell’autrice). Basterà quest’altro esempio, da The Triumph of Achilles, del 1985:
Mock Orange
It is not the moon, I tell you.
It is these flowers
lighting the yard.
I hate them.
I hate them as I hate sex,
the man’s mouth
sealing my mouth, the man’s
paralyzing body—
and the cry that always escapes,
the low, humiliating
premise of union—
In my mind tonight
I hear the question and pursuing answer
fused in one sound
that mounts and mounts and then
is split into the old selves,
the tired antagonisms. Do you see?
We were made fools of.
And the scent of mock orange
drifts through the window.
How can I rest?
How can I be content
when there is still
that odor in the world?
Filadelfo
Te lo dico, non è la luna.
Sono questi fiori
che illuminano il giardino.
Li odio.
Li odio come odio il sesso,
la bocca dell’uomo
che sigilla la mia bocca, il corpo
dell’uomo che mi paralizza –
e il grido che esce sempre,
l’infima, umiliante
premessa dell’unione –
Stanotte, tra me e me
ascolto la domanda e cerco la risposta
fusa in un suono
che sale e sale e poi
si spacca nei vecchi sé,
gli stanchi antagonismi. Vedi?
Ci hanno preso in giro.
E il profumo del filadelfo
entra dalla finestra.
Come faccio a riposare?
Come posso sentirmi soddisfatta
se nel mondo
c’è ancora quell’odore?
Se ieri mi avessero chiesto chi tra le più importanti poetesse americane sarebbe stata in lizza per il Nobel, avrei dovuto scegliere tra Anne Carson (canadese), Rita Dove (afroamericana), Louise Glück e Jorie Graham, e avrei scommesso su Anne Carson, la più “monumentale” fra tutte, quella che fin dall’inizio è sembrata la più destinata al ruolo di modern classic. Louise Glück ha molto in comune con Carson, soprattutto l’interesse per la classicità greca, gli archetipi della mitologia, e lo sguardo assolutamente disincantato. Ma Louise Glück ci aggiunge il lavoro del risentimento, verso l’anoressia giovanile superata a fatica, l’elaborazione del profondo desiderio di stare per conto suo, con la sola compagnia della lingua e delle parole. Non c’è, da parte sua, né rifiuto del mondo né della comunicazione tra gli umani, ma solo la realizzazione che uomini e donne possono essere uniti solo dalla profonda consapevolezza di ciò che li separa. Ho citato qui le sue due poesie più antologizzate, ma come accade spesso ai poeti che poi temperano col mestiere la loro inevitabile insofferenza giovanile, le ultime raccolte di Louise Glück sono più distese, narrative. Apro A Village Life del 2009 e tra tutti quei perfetti raccontini in versi non so cosa scegliere. Prendo a caso la conclusione di Harvest (Raccolto):
And then the frost comes; there’s no more question of harvest.
The snow begins; the pretense of life ends.
The earth is white now; the fields shine when the moon rises.
I sit at the bedroom window, watching the snow fall.
The earth is like a mirror:
Calm meeting calm, detachment meeting detachment.
What lives, lives underground.
What dies, dies without struggle.
E poi viene il gelo; del raccolto è inutile parlare.
Comincia la neve; finisce la finzione della vita.
La terra adesso è bianca; i campi splendono al sorgere della luna.
Io siedo alla finestra accanto al letto, guardo la neve cadere.
La terra è come uno specchio:
calma su calma, distacco su distacco.
Ciò che vive, vive sottoterra.
Ciò che muore, muore senza lotta.
Louise Glück non è molto tradotta in Italia, ma raccomando le traduzioni di Elisa Biagini in Nuovi poeti americani (Einaudi 2006) e quelle di Massimo Bacigalupo, L’iris selvatico (Giano 2003) e Averno (Dante & Descartes, 2019). Spero che siano ancora in circolazione. Qualcuno ha detto, tempo fa, che il destino del poeta contemporaneo è di arrivare al Nobel senza essere passato per le librerie…
Averno di Louise Glück / È bastato un fiammifero. Ma al momento giusto
Una delle domande fondamentali, se non la domanda unica ed essenziale, posta alla base di Averno di Louise Glück (Liberia Dante Descartes e Editorial Parténope, 2020, traduzione di Massimo Bacigalupo) è sul cosa accadrà dopo la morte. Non il solo quesito sul dove si andrà (ammesso che si vada da qualche parte); Glück va oltre e si chiede cosa ci faccia l’anima nell’aldilà senza le cose più care. A che scopo dovrebbe esserci un’ipotetica vita dopo la morte se a questa mancheranno le cose terrene? Ecco il punto, la novità del contenuto di Averno. A tutto ciò va aggiunta la straordinaria capacità della poetessa americana di tenere il verso in pugno, di dominarlo, di far cantare le parole sul serio. Averno è luogo mitologico e affascinante, non molto distante da Napoli. Gli antichi romani credevano fosse l’accesso all’oltretomba, Glück passa attraverso la porta, e se ciò che si lascia è bello, è storico, è naturalmente potente, quasi magico, allora andare oltre sarà doloroso, nostalgico, duro. Questo distacco è raccontato poesia dopo poesia in questa raccolta che è magnifica.
“Questo è il momento in cui vedi di nuovo / le bacche rosse del sorbo selvatico / e nel cielo scuro / le migrazioni notturne degli uccelli. // Mi addolora pensare / che i morti non le vedranno […]”.
Averno è un libro centrale nella ricca produzione di Louise Glück – parliamo di più di 15 libri di poesia, tra cui L’iris selvatico, vincitore del Premio Pulitzer e pubblicato in Italia da Giano edizioni nel 2003 – una raccolta di cui gli appassionati aspettavano la traduzione in italiano da molti anni. Scrivo questo pezzo e ripenso al momento esatto in cui mi capitò tra le mani l’edizione originale, esposta in una libreria di Amsterdam, aprii una pagina a caso e fu amore a prima vista.
Il mito, dicevamo, la prima poesia che parla della migrazione notturna degli uccelli. Gli uccelli vanno e noi stiamo, soli, pronti per l’inferno, sull’uscio. Da lì comincia la discesa agli inferi, il precipitare che interessa all’autrice, che appartiene a tutti noi. Una delle poesie più belle è la seconda, siamo a ottobre, il mese d’inizio dei misteri eleusini, perciò compare Persefone che da qui in avanti tornerà in parecchi riferimenti del libro, alternando origine mitologico e pieno quotidiano. Il lettore oscilla dentro e fuori, tra vita e morte, tra mitologia e racconto ordinario.
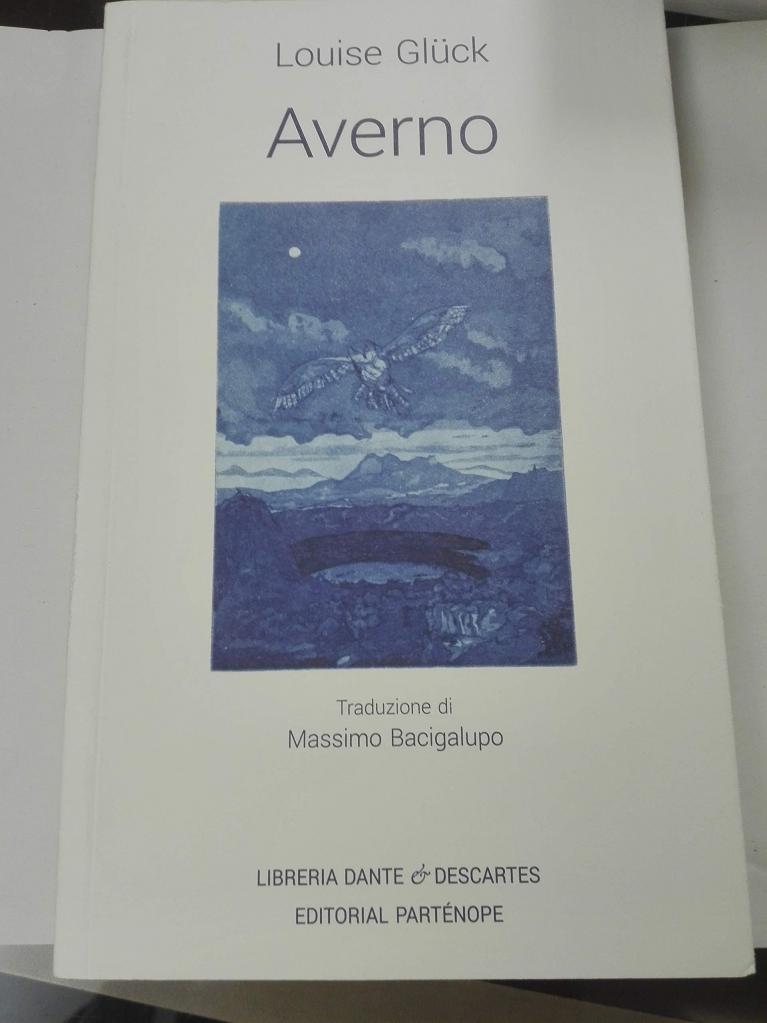
“La luce è cambiata; / ora il do centrale ha un suono più cupo. / E le canzoni del mattino suonano troppo studiate. // Questa è la luce dell’autunno, non la luce della primavera. / La luce dell’autunno: non sarai risparmiata […]”.
Il ricorso al classico – come nota anche José Vicente Quirante Rives nell’ottima postfazione – non è di maniera ma funzionale, è parte del controllo statico (e magmatico) che alza l’architettura di Louise Glück.
È un libro che nasce dal disagio, dalla frattura (e dove se non sul lago vulcanico si possono contare le fratture?), dall’insoddisfazione di sé. Averno è doloroso, aspetta il lettore, non lo va a cercare. L’autrice americana parla di ferite aperte, non le nasconde ma non le ostenta, ci conduce negli inferi che siamo noi stessi, le nostre case, le nostre fughe, i nostri ritorni mai compiuti.
Poesie fatte di sogni, di violenza e d’amore, di prove superate e da superare. Poesie sulle colpe e sullo stare bene. Poesie che annullano il confine tra bene e male, che lo ristabiliscono, che lo annullano di nuovo.
I versi sono infuocati, scorrono come la lava che scendeva dal Vesuvio. Persefone, l’Ade, ma noi soprattutto e le cose che lasciamo. Ti mancherà ciò che è con te per sempre recita un verso del poeta Franco Scarabicchi, Glück invece ci dice che tutto mancherà perché tutto resta altrove, non può seguirci se non nel ricordo, nel pianto, nel sentimento. Con noi nell’oltre non verrà niente e tutto starà nel meno, nel nulla, nella non appartenenza.
“Il compito assegnato era innamorarsi. / I dettagli dipendevano da te. / La seconda parte era / includere nella poesia certe parole, / parole tratte da un testo specifico / su un argomento affatto diverso”.
Il dolore è però filtrato dalla luce, quella dell’autunno che è diversa da quella dell’estate, non più debole solo malinconica, diversa. Qual è il nostro Averno, la soglia da attraversare o da non varcare? Il coraggio ce lo dà la poesia, la purezza e la musica di questo libro, il trovarsi contemporaneamente ai tempi di Ulisse e ai giorni nostri. La poetessa affonda a bassa voce, approfittando del silenzio del lago, dell’acqua che non va da nessuna parte ma che da qualche parte è giunta fino a chiudersi in un cerchio a pochi passi dal vulcano.
Glück meriterebbe la traduzione italiana dell’intera opera e speriamo che possa accadere presto.
“Dimmi che questo è il futuro, / non ti crederò. / Dimmi che sto vivendo, / non ti crederò”.
Un’estate dopo l’altra è finita, scrive e poi la violenza mi ha cambiato. Non le fa bene che questa fine sia come un balsamo e che le faccia bene ora. In un contrasto, un dubbio continuo, un’equivalenza difficile da raggiungere, stanno le poesie e noi. Siamo pronti a guardare gli uccelli migrare di notte e a non avere paura?
Leggi anche
Louise Glück, Tre poesie
Massimo Bacigalupo, Louise Glück al Golfo dei Poeti







