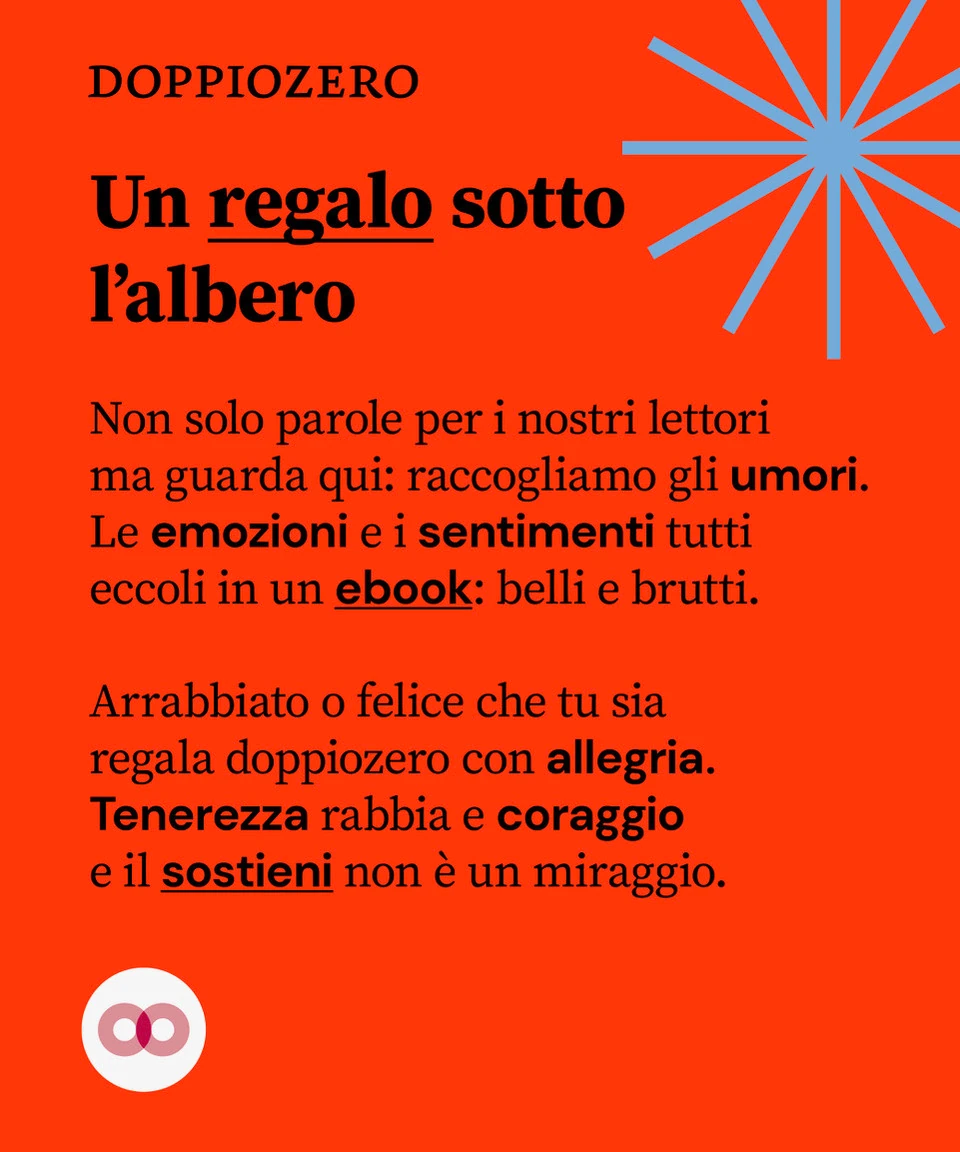Indicativo presente| Duecento giorni in classe / Le mani addosso
Questa mattina ricevo genitori. Come coordinatore di classe tocca a me il contatto con loro. Il padre e la madre di Widad sono miti e silenziosi. Temono l’Autorità. Maghrebini, qui lavorano sodo, e per loro la scuola è qualcosa di importante. Se sono qui, lo sanno, è perché la loro ragazza ha fatto qualcosa di grave. Li accompagno nell’ufficio del vicario, offro un caffè ma non lo vogliono, grazie. Comincio a raccontare i fatti. Nei giorni scorsi, in un’ora di una collega, erano in corso delle relazioni “flipped classroom”; gli allievi aveva preparato a casa delle ricerche che sviluppavano input dati in classe dalla professoressa. Quella mattina toccava a un gruppo di ragazze raccontare alla classe dei capolavori dell’arte contemporanea. Il gruppo dei ragazzi ridacchiava, parlava, non le rispettava con l’ascolto. Quando sono loro, tutti insieme, a fare così con noi docenti non si curano minimamente di cosa il loro atteggiamento generi in noi. Entriamo per “fare lezione”, ma con modalità che ormai contemplano il loro interloquire, le loro richieste di chiarimenti, le loro considerazioni personali. Ma entriamo e la classe è in preda a un intervallo perenne: si inseguono, urlano, si spingono, si burlano reciprocamente, oppure si raccontano senza fine i loro fatti pomeridiani e serali, perché nessuno di loro praticamente ha più amicizie o frequentazioni pomeridiane, e quando la mattina si rivedono hanno un sacco di cose da raccontarsi. Praticamente, le loro sei ore di vita mattutina a scuola sono tutto quello che loro resta di vita sociale: il resto è stare in casa, spesso soli, quasi sempre su uno smartphone, o in compagnia della madre, se la famiglia è di origini maghrebine o africane e economicamente povera.
Noi prof lottiamo dieci, quindici minuti ogni ora per smontare i capannelli, girare le schiene e rivederli in faccia, avere, più che il silenzio, una elementare considerazione per quello che dovrebbe restare il loro principale interlocutore: il docente.
Quando quella mattina Widad, Aurelia, Sabrin parlano al resto della classe si sentono derise: i compagni fanno domande cretine, per metterle in difficoltà, non le guardano. Come sempre il guru del sabotaggio è Mwaka: ha imparato a sibilare ai compagni del suo branco senza quasi leggibilità labiale: loro ripetono ad alta voce e sbottano a ridere. Lui gode del suo grande potere di cattivo influencer, e – come dice lui – della sua capacità di “fare il caos”; si gode una indubbia capacità di sabotare acquisita in quattro anni di scuola media (in prima media era stato bocciato perché ingestibile e senza risultati didattici). Quando suona l’intervallo Widad, che ha la media dell’otto, è coraggiosa e spesso canzonatoria con me, decide che non ne può più e innesca la sfida a Mwaka. Lui sta giocando a football in tre metri quadrati con i suoi sgherri, lei come una freccia gli prende la pallottola di carta e gli mette gli occhi negli occhi e gli intima: «Adesso mi dici perché ti comporti così». Mwaka ama provocare i conflitti ma non ama gestirli. Ha imparato a negare qualsiasi cosa lui abbia detto e fatto anche palesemente e platealmente un minuto prima. E in questo modo smonta il confronto, nega anche il diritto ad ogni chiarimento. Chiede alla collega di intimare a Widad di restituire la pallina. La collega sta segnando i voti sui diari, gli dà poco retta. Allora come un fulmine parte lui, va dalla prima assistente di Widad, Aurelia, e le sequestra il portapenne, e comincia a lanciare in giro il contenuto. Da quel momento esplode la rissa.
Le ragazze addosso a Mwaka per fargli restituire il portapenne; collega, bidella, altri compagni addosso a Mwaka per evitare che reagisca. A quel punto Widad alza il livello della sfida e compie il gesto fatale: sfila improvvisamente il capellino di lana dalla testa di Mwaka, e fugge per la classe; Mwaka la insegue; gli altri inseguono Mwaka. Mwaka tiene quel cappellino in testa 365 giorni all’anno. Quando gli ho chiesto la prima volta perché? con un sorriso sardonico mi ha detto «ho una malattia del cuoio capelluto e non posso toglierlo»; quando l’ho chiesto ai colleghi che lo avevano in classe nei primi tre anni mi hanno detto che suppongono che il padre – mai visto qui a scuola, Mwaka dice che fa l’autista di T.I.R. sempre in giro per il mondo (un po’ come via mare era per lei il papà di Pippi Calzelunghe) – quando rientra per punirlo delle sue malefatte gli rade a zero i capelli per umiliarlo. Quello è l’oggetto transizionale di Mwaka, la sua firma di capobranco, e Widad l’ha colpito a morte.

«Il consiglio di classe in seduta straordinaria presieduta dalla dirigente scolastica ha stabilito che Widad e Mwaka devono essere sanzionati perché lo scontro fisico è inaccettabile, pericoloso»: il padre annuisce, la madre è affranta e muta. «Ho voluto che non si procedesse a una semplice sospensione, ma si sperimentasse una nuova modalità di reazione ai comportamenti sbagliati dei ragazzi. Widad e Mwaka, separatamente, parleranno con un mediatore professionista di un Centro di Mediazione specializzato nella mediazione dei conflitti. Poi il mediatore cercherà di portare i due ragazzi a un dialogo; infine, ho chiesto io, i due dovranno restituire alla classe la loro elaborazione del perché sono arrivati allo scontro, e di come potranno in futuro evitarlo. Poi Widad farà un paio di giornate in cui assisterà nello studio ragazzini in grandi difficoltà sociali, presso una cooperativa di mediazione interculturale. Se voi genitori ci autorizzate a questo percorso di giustizia riparativa Widad eviterà un giorno di sospensione con obbligo di presenza». Ho letto la sentenza. Li invito a leggere i documenti prima di firmarli. E loro, con circospezione, iniziano a leggerli. Molto lentamente, tutti. Mi pare con diffidenza… no… con serietà e scrupolo. Passano interminabili minuti, e firmano. Li ringrazio, sorridono, offro di nuovo un caffè, lo rifiutano nuovamente con educazione, escono dalla scuola.
Il caffè buca budella della macchinetta della scuola lo bevo io. Ora dovrebbero arrivare i genitori di Mwaka. Se non il padre (la madre pare viva in Senegal), uno dei due fratelli maggiorenni: a uno telefonai tempo fa quando mancò a un altro appuntamento; al telefono mi disse «io ho altro da fare, cosa vuole che dica a Mwaka? Tanto fa sempre quello che gli pare, parli a suo padre!»; ma al telefono suo padre non risponde mai. Attendo un’ora, e non arriva nessuno. Mwaka aveva chiesto un colloquio con la dirigente «perché in questa scuola fanno tutti i furbi, e se mi sospendete vi denuncio perché avete lasciato che le femmine mi picchiassero». Mwaka ci ha preso per il culo. Quando l’ora successiva rientro in classe sono furibondo. Gli dico che suo fratello non si è presentato, lui risponde «i miei parenti vanno a lavorare, mica se ne stanno a letto a far niente»; e sorride in attesa della mia reazione. Mi avvicino al suo banco e gli chiedo di scrivermi il numero di telefono di suo padre; «non me lo ricordo»; gli dico di accendere il telefono e di darmelo dalla rubrica; scrolla la rubrica e mi fa «vede? Non ce l’ho!». Se domattina non avrai firmato i documenti che ora ti dò verrai sospeso due giorni, e tuo padre lo verrà a sapere in ogni caso, dico, e poi sbiello in invettiva: «Non sei credibile! Hai promesso e non hai mantenuto! Non ammetti ciò che dici e ciò che fai! Non sei disposto a un dialogo! Menti anche di fronte all’evidenza! Menti a me e ai tuoi compagni!». Lui dice che soltanto Allah può giudicarlo, sarà Lui a stabilire se lui si è comportato bene o male. Mwaka – concludo – credo che Allah abbia molte cose da fare, non possiamo aspettare che tu muoia per chiudere questa questione. Oggi è venerdì, hai tempo sino a lunedì mattina.
Il lunedì Widad è molto agitata, prima del colloquio con il mediatore. La invito a dirgli tutto ciò che pensa e le spiego che se la sua azione è stata di risarcimento per una offesa subita, molto spesso anche lei offende con le sue parole taglienti, e canzona, e che tutto sommato ha rischiato grosso giovedì scorso. «Lo so, l’ho detto a mia mamma che mi è andata bene: se Mwaka mi prendeva mi ammazzava». Dopo il colloquio sorride: «Come è andata? Ti sei sentita ascoltata?» lei dice di sì e aggiunge: «Ma anche prima mi sentivo ascoltata da Lei».
Mi consulto con il mediatore e decidiamo di procedere anche al dialogo con Mwaka. Le firme del fratello che ha portato sui moduli hanno la sua stessa grafia, ma lascio correre. Se non ha una famiglia con sé, in ogni caso ha deciso di dialogare. Alla fine del colloquio Mwaka è sorridente e calmo. A quattr’occhi con lui gli richiedo perché tiene sempre questo cappellino blu in testa: Dicono che è perché non vuoi far vedere che tuo padre ti rapa a zero per umiliarti; si mette a ridere imbarazzato: «Non è vero!». Allora perché non te lo togli in classe come tutti? «Perché è il mio stile». Allora adesso te lo posso togliere? «Sì». Lo sfilo e ha i capelli cortissimi. Stai benissimo! Sei un bel ragazzo anche senza: possiamo buttarlo? «No no! L’ho pagato!». Glielo restituisco, lo rimette in testa, ed entra in classe sorridente.
Accompagno alla fermata del bus il mediatore, che ha trovato Mwaka molto intelligente e in un totale deserto affettivo. Concordo. Per ora siamo contenti di questa prima volta di una giustizia riparativa in questa scuola. Il dado è tratto.
28 aprile 2019