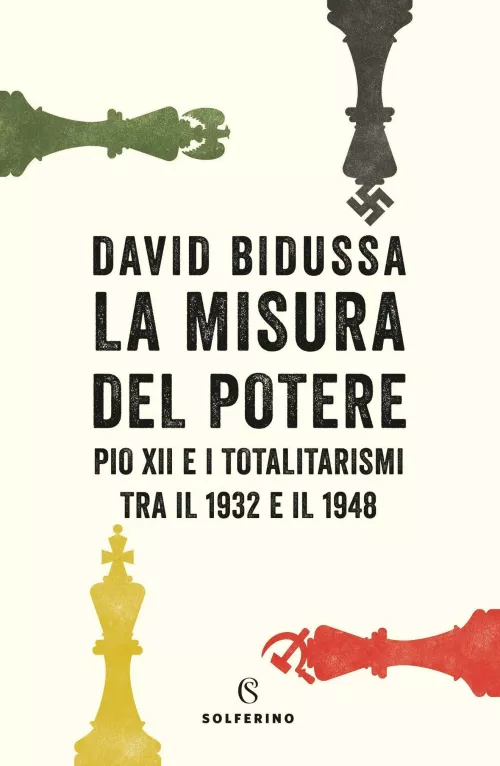Un libro di David Bidussa / Pio XII e gli ebrei
A che punto è la penombra? Ovvero, ha ancora un senso interrogarsi sulla condotta di Pio XII e, più in generale, sul Vaticano negli anni dello scontro tra i «totalitarismi», quello nazifascista e quello stalinista, cercando di identificare la sua specifica condotta rispetto ad una serie di questioni dirimenti, a partire dal rapporto con il mondo ebraico, sottoposto ad una torsione stritolante, culminata nello sterminio delle comunità presenti nei paesi occupati da Hitler? Non di meno, come ci si deve adoperare, qualora si torni su un tale ordine di problemi, per evitare di ripetere il già detto, spesso all’insegna di uno stanco sensazionalismo?
«Nel 1975-1976, alla mia richiesta se esistesse una direttiva scritta della Santa Sede, i religiosi da me interrogati rispondevano con ironia di fronte ad un giovane ricercatore in cerca di documenti probanti: “la vita allora era complicata e chi avrebbe fabbricato allora una prova scritta davanti ai tedeschi?”». Così lo storico Andrea Riccardi, tra i maggiori esponenti della Comunità di Sant’Egidio, nella sua ricerca dedicata all’occupazione tedesca di Roma nel 1943-44 e al rapporto con la Santa Sede rispetto al destino della popolazione ebraica.
David Bidussa lo riprende ad incipit di uno dei capitoli del suo ultimo lavoro, dedicato a La misura del potere. Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948 (Solferino, Milano 2020, pp. 266, euro 17). Si tratta di un volume che, oltre a fare il punto sulla ricerca storica e sulla stessa storiografia in materia, affronta di petto i parametri della riflessione sul papato pacelliano. Lo fa cercando di andare oltre il già detto, il “sempre visto”, l’inesorabile ripetizione di cliché e paradigmi interpretativi che si muovono sulla linea che collega due estremi, ovvero la «leggenda rosa» (Pio XII Defensor civitatis, non solo amico ma nume tutelare dell’ebraismo dinanzi alle politiche criminali dei nazisti) alla «leggenda nera» (il «Papa di Hitler», animato da implacabile indifferenza, se non sottile compiacimento, verso i tragici destini degli ebrei). Due estremità che si rispecchiano, a volte in modo imbarazzante, soprattutto quando entrano in gioco, a rinforzo di tesi precostituite ed acritiche, le opposte tifoserie, entrambe animate da un’esasperata affettazione che si fa quasi da subito rischio di mistificazione, in una concezione tribunalizia della storia, dove si assolve e quindi si beatifica oppure, alternativamente, si condanna senza pietà residua e grazia alcuna.
L’occasione per la genesi di questo libro, peraltro appena accennata a causa del blocco generato dalla quarantena per il Covid-19, è l’apertura, il 2 marzo di quest’anno, degli archivi riservati relativi al pontificato di Pio XII (durato quasi vent’anni, dal 1939 al 1958), subito dopo frettolosamente richiusi per le occorrenze generate dall’emergenza sanitaria nazionale. Il testo qualcosa “strappa” di questo nuovo, ipotetico orizzonte, ma procede comunque anche a prescindere dalle sole fonti archivistiche, per offrire semmai un ragionamento complessivo su alcuni aspetti dell’azione della Santa Sede nell’«età dei totalitarismi». Come tale, si concentra soprattutto – ma non esclusivamente – nei confronti del magistero di Eugenio Pacelli.
Il volume peraltro intreccia diversi elementi in una calcolata successione diacronica: il ruolo della Chiesa nel disfarsi degli equilibri dettati dalla pace di Versailles, durante gli anni Trenta; l’impatto, non solo militare ma soprattutto ideologico, della Seconda guerra mondiale, con la frantumazione di un orizzonte di prevedibilità e, con esse, di aspettative; la ricostruzione postbellica e il riposizionamento dei protagonisti, con assoluto riguardo per l’istituzione papale nelle sue distinte evoluzioni; l’identità di quest’ultima – per nulla coincidente in tutto e per tutto con le molteplici articolazioni della Chiesa cattolica in Europa e negli Stati Uniti – che visse gli anni Trenta e Quaranta come una prova, non più rinviabile, rispetto al dispiegarsi definitivo del «modernismo» (trasformatosi in fenomeno totalmente secolarizzante), con il quale doveva a quel punto negoziare la sua stessa continuità per il tempo a venire.
La cartina di tornasole o, se si preferisce, l’elemento di riscontro che attraversa il libro sono le posizioni (sia ufficiali che ufficiose), gli atteggiamenti, gli umori, le sensibilità (e le insensibilità) verso «la condizione dei mondi ebraici in Europa, spesso attori passivi di un percorso di lacerazione del continente» per parte della curia romana.
L’ispirazione interpretativa di fondo è peraltro posta in esergo, quando viene citato Claudio Pavone laddove, nella sua «Prima lezione di storia contemporanea» afferma testualmente che «la storia contemporanea un aiuto può fornirlo: quello di non proporre, anzi di contrastare, qualsiasi forma di reductio ad unum, che è la matrice di ogni fondamentalismo». Un fondamentalismo, in tal caso, destinato a non fare capire che il proscenio storico è al medesimo tempo animato sia da una pluralità di attori che da molte strategie di condotta, queste ultime destinate a mutare, di volta in volta, in base alle complesse trasformazioni di scenario. La lettura dei pontificati fa quindi ricondotta ad una tale cornice.
Anche per questa ragione, è francamente riduttivo cercare nel libro un mero giudizio su «Pio XII e gli ebrei», un binomio invece cristallizzato soprattutto sul piano pubblicistico. Semmai, per l’autore si tratta di dare corpo ad una più generale riflessione sulle modalità con le quali le Chiese (non solo quella cattolica) e quindi gli stessi culti maggioritari, ridefinirono la propria presenza dal momento che i totalitarismi, pur nella varietà conflittuale delle loro manifestazioni, trovavano una comune matrice nel rivendicare per se stessi la natura di religioni politiche. Ancor meglio, di religioni della politica, che riportano quest’ultima alle sue radici più arcaiche e, quindi, consolidate in un qualche subconscio di massa: rito, mito, partecipazione passiva, adesione fideistica, azzeramento di qualsivoglia elaborazione teoretica, ispirazione estetizzante e così via.

L’autore richiama ripetutamente l’accesa rilevanza del dettato anticomunista nei due papati presi in considerazione, per l’appunto quello di Pacelli e del suo predecessore Achille Ratti, trattandosi per più aspetti dell’ossatura di una dottrina sociale collaterale a quella offerta dalla Chiesa rispetto ai diversi temi della società moderna. Il rifiuto dell’«ateismo materialista», incarnato da Mosca, è il movente di non poche scelte della Santa Sede, tra gli anni Trenta e Quaranta. Anche all’interno di questa cornice si pone quindi una rilevante parte della tematizzazione ecclesiale della «questione ebraica», laddove è ancora intesa come radice del «disordine», delle animosità, dell’innaturalità che si sarebbero accompagnate ai più generali processi di modernizzazione dall’età dei Lumi in poi. L’ebraismo immaginato (ed immaginario), in questo caso, è il fantasma della definitiva rottura dei vecchi ordini, quelli che, facendo sì che invece si tenessero “tutte le cose al loro giusto posto” (una condizione di cui la Chiesa voleva continuare ad essere garante), erano anche il suggello di una gerarchia di ruoli e poteri immodificabili.
Perlopiù, tuttavia, il destino degli ebrei nell’Europa fascistizzata svolge la parte di un convitato di pietra tra le righe del discorso pubblico della Chiesa in quegli anni. Non costituisce infatti il punto centrale delle agende vaticane, semmai facendovi ritorno nel caso di vicende che, coinvolgendo il destino di intere comunità cattoliche (come per ciò che concerne della Polonia occupata dal 1939), rimanda anche al ruolo gregario, poi vassallo ed infine tragico dell’ebraismo europeo, autentico «vaso di coccio in mezzo a tanti vasi in ferro». Il tema antigiudaico riemerge comunque agevolmente, in molti passaggi dei documenti citati, a volte esplicitatovi, in altri casi sottointeso. Per Bidussa, d’altro canto, la questione principale è di cogliere come l’identità del papato, e con esso delle istituzioni collegatevi, a fronte dei processi di radicale mutamento, si trasformi in anni decisivi anche attraverso il confronto con il tradizionale substrato antiebraico presente nelle curie così come nella cattolicità di base.
Lo sguardo dell’autore rimanda quindi ai tanti interrogativi su come un’istituzione a propensione universale ragioni su di sé nel mentre le cose avvengono e si consumano. Al medesimo tempo, raccolte le fonti che di essa ci sono state trasmesse, si interroga su come si possa oggi, per parte nostra, dotarci di uno sguardo retrospettivo nei suoi confronti. Da questo punto di vista, la posizione assunta dallo studioso si sforza di essere soprattutto emica, prima che etica. Così lo stesso Bidussa: «se si vuole comprendere come si comporta un’istituzione è alle sue “regolarità” che dobbiamo prestare attenzione, a come queste sono sottoposte a prova nei momenti di tensione e di alto rischio. E dobbiamo valutare che cosa confermano, quanto non variano dal loro agire, pensare, giudicare, una volta rientrata l’emergenza. Questo perché essenzialmente le istituzioni sono fondate sulla continuità piuttosto che sulla discontinuità». Ed in immediata successione: «anche per questo è un errore ritenere che il ritrovamento di un documento ci fornisca da solo una soluzione o cambi radicalmente un quadro dato. Un documento è un indizio che chiede di essere ascoltato, indubbiamente, ma non è una prova».
La sfasatura incolmabile tra i tempi in cui un documento è formulato e quelli della sua successiva rilettura è una delle radici più fertili del lavoro archivistico e dell’interrogativo storiografico. Di contro non solo al pressapochismo ma anche all’ansia di schiacciare su un unico tempo presente qualsiasi valutazione di merito, due aspetti che accompagnano quella pubblicistica che trasforma la storia in una sorta di eterno «qui ed ora». Non a caso, gli indici di interpretazioni adottati da Bidussa per disegnare il profilo storico del pontificato, sono, nell’ordine, l’adattamento, la diversificazione e la reintegrazione. Adattamento della propria azione rispetto al repentino mutamento del quadro europeo ingeneratosi con gli anni Trenta e poi radicalizzatosi durante la guerra; diversificazione delle risposte che la Chiesa offre al riproporsi di certi problemi, a partire dalla stessa «questione ebraica», intesa essenzialmente come manifestazione di un antisemitismo apocalittico da parte del nazionalsocialismo; reintegrazione, in uno scenario postbellico, tra il 1945 e il 1948, completamente diverso da quello di poco precedente, rispetto alle prerogative proprie, al magistero esercitato, alle aree di egemonia e di influenza, alle relazioni esterne e, con esse, alla propria continuità di istituzione. Leggere tutto ciò come esclusivo opportunismo, ovvero come mera concessione ai trend del momento, è quanto di più astorico possa essere fatto. In quanto non aiuta a formula un giudizio storicizzante sul senso del passato.
Rimane il fatto che il volume non sia, né intenda in qualche modo essere, una storia di un pontificato o della Chiesa in un dato tempo bensì del tessuto di relazioni che si stabilisce tra un’istituzione pressoché priva di sovranità territoriale, ma dotata di una grande capacità di influenza culturale (quindi comportamentale) verso il suo esterno, con il sistema dei poteri agenti nell’arco di tempo preso in considerazione. Anche per tale ragione, il testo va letto al pari di una lezione di metodo, che invita ad imparare a maneggiare le carte, i documenti, le fonti, il lessico, la grammatica mentale ed ideologica di un soggetto storico. Ha quindi ragione Gadi Luzzatto Voghera quando riscontra, in merito, che «si tratta di un testo che incrocia molti piani e diversi saperi che non sempre sono controllati da una storiografia che si è fatta in questi ultimi decenni sempre più specialistica e settoriale, con la creazione di micro-nicchie nelle quali spesso queste pagine entrano senza chiedere permesso».
Anche da ciò, quindi, la scelta di rifarsi ad una cronologia irrituale, attraverso il ricorso alle encicliche come binario di scorrimento per interpretare lo sfarinamento degli assetti conseguenti al 1919 (laddove Germania e Polonia sono due piattaforme privilegiate per capire l’azione papale, aggiungendovi però anche l’Ungheria, l’Austria, la Croazia e poi la Palestina mandataria e gli Stati Uniti), il consolidarsi dei regimi concordatari e il rapporto prima cordiale poi inquieto con il fascismo, l’estrema delicatezza degli scambi intercorsi con il regime nazionalsocialista, il rifiuto radicale del comunismo sovietico ma anche gli irrisolti rapporti con l’America di Roosevelt, lo spartiacque della guerra di Spagna nella sua natura di «crociata», la Seconda guerra mondiale con le informative e le testimonianze che già nel 1942 giungevano al Vaticano sullo sterminio in atto, l’evoluzione dell’insediamento ebraico nella Palestina britannica e gli assetti del dopoguerra.
Il rimando all’antisemitismo, ai suoi dispositivi concettuali, alle sue manifestazioni lessicali e alla violenza fisica che porta inesorabilmente con sé, non segnala solo il modo in cui la Chiesa di due pontificati ha visto gli “altri” (gli ebrei) ma il modo in cui ha reagito a quei mutamenti introdotti dai processi politici in corso attraverso esercizi di irrisolta e del tutto incompiuta autocoscienza. Se l’arco di tempo compreso dall’analisi documentale fatta nel libro va dal 1932 al 1948, tuttavia la dimensione analitica rimanda a logiche di lungo periodo, che non possono essere racchiuse in un intervallo cronologico circoscritto. Lo stesso principio di persistenza e continuità di un’istituzione ecclesiale si misura su tempistiche che solo in parte possono essere fatte aderire con quelle secolari degli altri agenti in campo. Basti pensare ad una mera ovvietà fattuale: la Chiesa precedeva, ha convissuto ed è sopravvissuta ai totalitarismi novecenteschi. Il linguaggio delle fonti, ovvero la sua interpretazione, diventa allora strategico, dovendo lo storico-archivista ricavare dei tracciati di plausibilità da una serie di elementi perlopiù simbolici, metaforici, allusivi, fatti di sottointesi che dicono senza tuttavia concedere un’immediata intelligibilità. La qual cosa è piena di implicazioni, poiché concede spazi di enorme incertezza alla piena comprensione di un operato, quand’esso diventa oggetto della valutazione storica.
Anche per questo l’apertura degli archivi vaticani non rimanda al solo giudizio di fatto su di un pontificato ma rispetto ad un’intera istituzione. Altrimenti, come è già stato opportunamente notato, il tutto si tradurrebbe in un viatico per una delle ultime beatificazioni papali mancanti del Novecento, quasi a volere soddisfare un obbligo inesistente, quello di consegnare l’intera azione dei pontefici ad una dimensione metastorica. Non a caso va aggiunto che la documentazione resa accessibile non riguarda solo l'archivio apostolico vaticano, ma anche quelli di altre istituzioni, tra le quali la prima e la seconda sezione della Segreteria di Stato, in particolare per quanto riguarda i rapporti con gli Stati; la Congregazione per la Dottrina della Fede; la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli; quella per le Chiese orientali; la Penitenzieria Apostolica; la Reverenda Fabbrica di San Pietro.
A questo punto, qualche nota conclusiva va offerta agli studi di David Bidussa, anche al netto di questa sua ultima fatica, poiché ciò che ci si trova tra le mani sono sempre opere ipertestuali, dove la stratificazione di elementi si trasforma da subito in una pluralità di ipotesi di ricerca, in percorsi ramificati, ovvero in storia nel senso più reticolare della sua accezione. Ragione per cui la sfida che egli raccoglie e rimanda al lettore è quella dettata da una vera e propria perlustrazione antropologica delle relazioni sociali, attraverso la storicizzazione dei significati condivisi. Si tratta, per l'autore, di dare corpo e sostanza a mappe concettuali estremamente mobili ma non per questo fragili e facilmente intercambiabili. Storico delle idee, David Bidussa infatti ci consegna con il suo ultimo volume una riflessione sulle idee che si possono intrattenere sulla formazione del discorso storico.
Da sempre, in fondo, la cifra del suo lavoro, sospeso tra testi, contesti e trame del reale, rimanda al rapporto tra archivio, ricerca e laboratorio. L’archivio delle fonti; la ricerca del loro significato; il laboratorio della storicizzazione. Anche per questo, nella sua raffinata intelligibilità, la sua attività non si adopera tanto per ricostruire il «vero», e neanche la «verità» (come invece ancora cercava di fare Pierre Vidal-Naquet) bensì il «reale». Il quale coincide essenzialmente con un insieme di idee condivisibili di realtà, quella trascorsa ed, in immediato riflesso, di comprensibilità di quella presente. Il rimando d’obbligo, ancora una volta, è ai significati strategici che sono racchiusi nella parola chiave «complessità». La quale, a forza di essere richiamata a vuoto (per giustificazioni, rimozioni, negazioni), rischia di perdere la potenza euristica che le dovrebbe altrimenti essere riconosciuta. Si riparte quindi da questa istanza epistemologica, senza la quale tutto è perduto: non solo la coscienza del passato (erroneamente confusa con la «memoria») ma anche e soprattutto la difficilissima cognizione del presente.