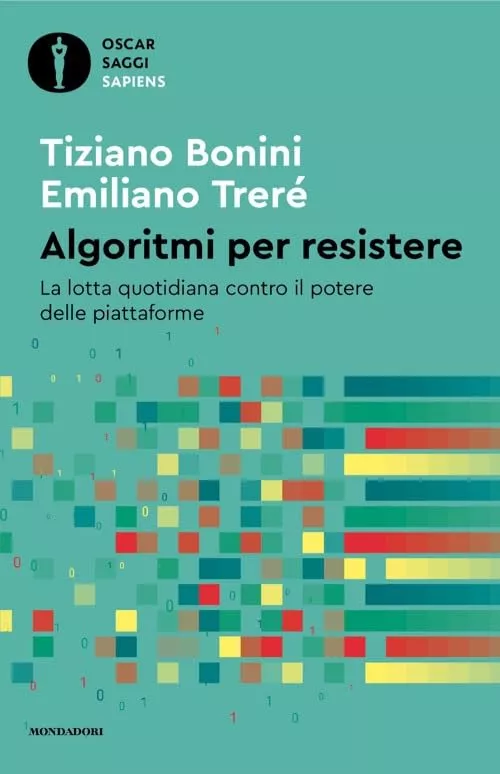Algoritmi: resistere, resistere, resistere
Terminata la lettura di Algoritmi per resistere – La lotta quotidiana contro il potere delle piattaforme (Oscar Studio Mondadori, 2025) mi è tornato in mente il film di Ken Loach, Sorry We Missed You (2019). Ricordo che, quando lo vidi, uscii dal cinema con un senso di sfiducia nei confronti delle forme istituzionalizzate di tutela del lavoro e più ancora verso l’efficacia di qualsiasi opposizione strutturata al capitalismo digitale e alle sue aberrazioni, di cui parlava il film. Loach, mi parve, non era tanto interessato a una denuncia morale del sistema, quanto a mostrare una disillusa constatazione della sua pervasività e della sua capacità di cooptare la soggettività stessa: raccontava un capitalismo digitale che non si limita a controllare i corpi o a imporre regole ma assorbe l'identità individuale, spingendo le persone ad agire come se le sue logiche fossero naturali o inevitabili. Loach mette in scena, in Sorry We missed you, un paradigma di precarizzazione ontologica, dove l’individuo non è solo esposto all’insicurezza materiale, ma viene ridisegnato come imprenditore di sé stesso, responsabile del proprio successo o del proprio fallimento. Il sistema di “auto-imprenditorialità” imposto dal lavoro in piattaforma (rappresentato emblematicamente dalla figura del corriere “autonomo”, con Amazon mai citata nel film ma incombente) non è altro che un dispositivo disciplinare iper-moderno, che spaccia una subordinazione a tutti gli effetti, invisibile ma totalizzante, per una forma di libertà (libertà dagli orari, autonomia nella gestione del tempo, affrancamento dalla fabbrica e dalla sua organizzazione verticale, e altre illusorie promesse).
In questo senso, l’opposizione al nuovo capitalismo digitale appare nel film come immanentemente neutralizzata: non c’è spazio per la rivolta, perché i soggetti – anche i familiari del protagonista – sono esausti, isolati e assorbiti in un ciclo ininterrotto di prestazioni alienanti che ricordano i ritmi disumani della fabbrica fordista. Loach ci obbliga a interrogarci su come rifondare una soggettività collettiva in grado non solo di resistere, ma di immaginare l’impensabile e cioè un’altra organizzazione del tempo, del lavoro e delle relazioni. Contemporaneamente all'uscita nelle sale pre-Covid di questo film, Tiziano Bonini e Emiliano Treré, docenti rispettivamente all'università di Siena e di Cardiff, si mettevano al lavoro su una ricerca che hanno pubblicato nel 2024 con il Massachusetts Institute of Technology e che possiamo leggere oggi, tradotta da Andrea Libero Carbone. L’ho letta come una sorta di contro-narrazione, concreta e teoricamente documentata, al pessimismo strutturale di quel film, che mi aveva così colpito, lasciandomi con un mucchio di domande senza risposta: Algoritmi per resistere è un'analisi approfondita delle pratiche di resistenza che emergono all'interno – e non soltanto "contro" – dell'ecosistema digitale delle piattaforme. Senza negare la pervasività e la violenza simbolica del capitalismo delle piattaforme, gli autori mostrano come i singoli, da soli, ma soprattutto quando riescono a unirsi a collettività omogenee, riescano, con fatica ma a volte con successo, a scardinare o deviare l'uso prescrittivo degli algoritmi, piegandoli a fini solidaristici, cooperativi o anche di semplice protesta.
Una prospettiva che recupera il valore delle micropolitiche della resistenza, forme di opposizione diffuse, quotidiane, spesso decentrate, attuate da utenti comuni o attivisti che agiscono all'interno delle piattaforme digitali e dove anche piccoli gesti contano e acquistano valenza politica. Nel film di Ken Loach il lavoratore autonomo – il corriere – era il simbolo tragico dell'auto-sfruttamento. Bonini e Treré ci fanno entrare in un mondo di lavoratori digitali-agenti capaci di risposta che, pur all'interno di un sistema che li vorrebbe passivi e isolati, trovano spazi di agency e di coalizione. La loro appassionante ricerca, empirica e teorica, riaccende la possibilità di intravedere una resistenza molecolare ma reale contro la dittatura degli algoritmi. Laddove in Sorry we miss you era impossibile per gli individui agire per influenzare il mondo dal quale si sentivano sfruttati, in Algoritmi per resistere si intravede uno spazio d'azione situato, parziale, tutto da costruire ma concreto: i lavoratori delle piattaforme, pur inseriti in un micidiale sistema di controllo algoritmico, trovano margini per reagire, adattare e negoziare le regole imposte e persino per sabotarle. Il sottotesto cruciale del libro mi pare quello di smontare il mito della neutralità tecnologica: se non si individua un "padrone" diventa praticamente impossibile combatterlo. Il primo passo quindi è considerare l'Intelligenza Artificiale come radicata in strutture materiali, politiche e di potere; ogni algoritmo riflette interessi, ideologie e relazioni sociali.
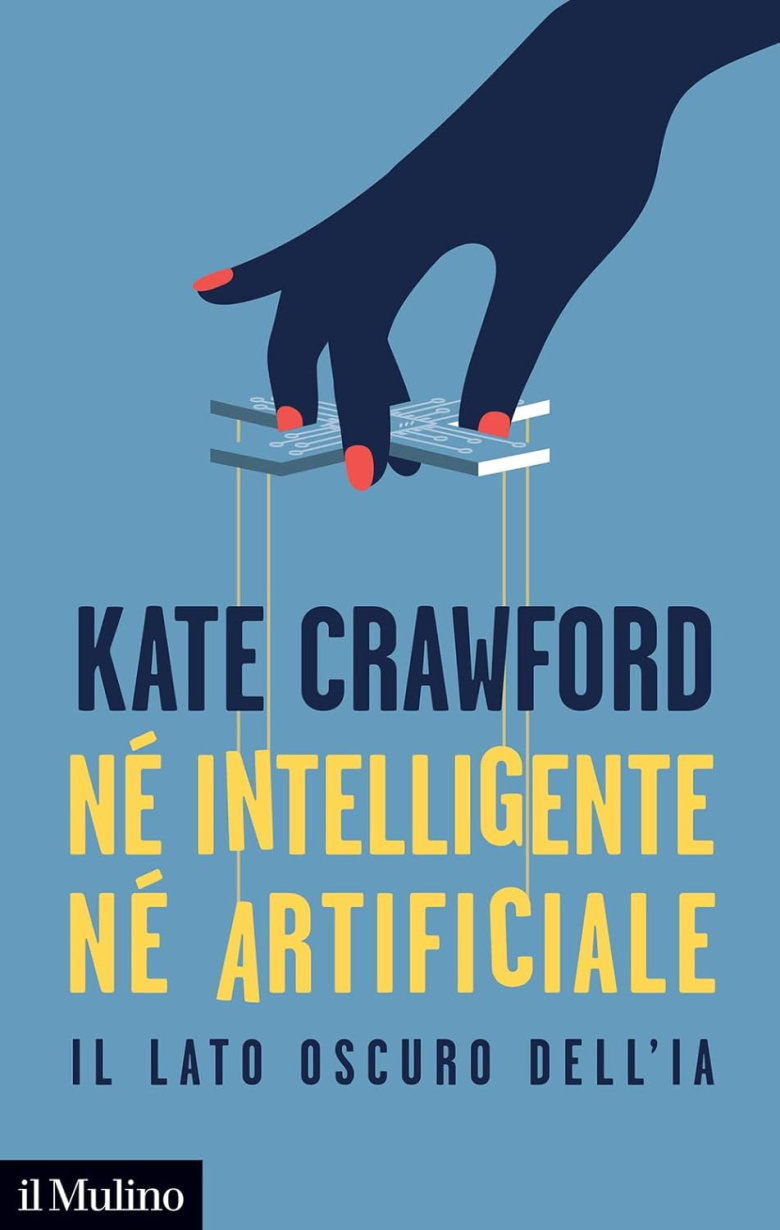
Bonini e Treré mostrano chiaramente che gli algoritmi, applicati al lavoro, sono strumenti di governance opaca e asimmetrica e mi hanno richiamato alla memoria un libro di Kate Crawford Né intelligente né artificiale (Il Mulino, 2021) dove l'autrice, sostanzialmente, lasciava intendere che smascherare le finzioni dell'AI, cioè mettere in luce ciò che l'Intelligenza Artificiale nasconde dietro la sua retorica di oggettività e neutralità, è già il primo passo verso la riappropriazione di autonomia individuale, necessaria per intraprendere azioni di lotta. La vulgata vuole che gli algoritmi di machine learning non capiscano, non ragionino, non contestualizzino, elaborino pattern statistici su grandi moli di dati: un alone di "magia tecnica" li pervade, con la cosiddetta "intelligenza" che serve da metafora fuorviante, per scoraggiare il pensiero critico. Ma Bonini e Treré dimostrano invece come l'AI delle piattaforme sia totalmente contaminata dai rapporti di potere e dalle disuguaglianze sociali: i rider, i driver, i freelance sono immersi in sistemi algoritmici opachi dove le decisioni – sui turni di lavoro, sui percorsi, sui compensi – sembrano derivare da logiche computistiche e quindi neutrali, quando invece sono espressioni di interessi economici precisi. Nel libro ci sono molti esempi concreti, storie vere di persone con le quali gli autori sono stati in contatto – così raccontano nell'Appendice sui metodi di ricerca che hanno applicato – attraverso interviste fatte in diversi contesti nazionali e internazionali, partendo quindi "dal basso": la loro "cassetta degli attrezzi" – dicono – non si è tuttavia limitata all'etnografia digitale. Hanno anche incontrato i loro informatori sul campo, osservandoli durante le loro attività quotidiane e intervistandoli di persona, oltre che su Zoom, GMeet, Skype.
Un loro ricercatore ha addirittura lavorato in Messico per due settimane come corriere per avere un’impressione diretta di come l’algoritmo opera all’ombra del muro di regolamenti criptici e di come funziona sul piano pratico la gamification (l’uso degli elementi tipici del gioco come i punti, i livelli, le classifiche, le sfide, le ricompense in contesti non ludici come il lavoro, la cultura, la politica), cui il capitalismo digitale ricorre per stimolare la competizione, illudere sul senso di progresso personale, occultando la logica implacabile della performance, dell’efficienza e del rendimento. "Scoprirsi come classe" nel processo di lotta (è una frase di James C. Scott, antropologo politico statunitense, 1936-2024, noto per i suoi studi sulle forme di resistenza dei gruppi subordinati, soprattutto nelle società contadine del sud-est asiatico, uno dei riferimenti bibliografici più citati da Bonini e Treré; Scott, nei suoi libri parla dei contadini che praticavano una resistenza silenziosa ma persistente contro lo Stato, i proprietari terrieri o le élite locali; non rivoluzioni spettacolari ma piccole azioni quotidiane, sabotaggi, finti errori, ostruzionismi vari, non cooperazione), uscire dall'isolamento e riunirsi, per creare reti di solidarietà, è il primo passo per resistere agli algoritmi.
"Oggi – scrivono i due autori – forse si va delineando una nuova fase del capitalismo industriale, di fronte alla quale si sta ricomponendo una classe inedita, dove per 'classe' non intendiamo una formazione sociale specifica in senso marxiano, bensì una 'moltitudine' globale e più eterogenea, composta da lavoratori delle piattaforme, prosumers culturali e attivisti politici", per resistere al potere degli algoritmi e di chi li ha programmati, perché gli algoritmi sono strumenti di oppressione ma possono anche diventare strumenti di resistenza. C'è, nel libro, una dichiarazione di posizionamento che mi ha colpito, perché non l'avevo mai vista in un saggio italiano e che sembra ispirata alla tradizione dei feminist standpoint studies e alla riflessione postcoloniale sulla produzione della conoscenza: i due autori si presentano nell'introduzione come "maschi bianchi, nati in Italia, accademici di prima generazione, con un percorso di studi sui media e sulla comunicazione, entrambi cisgender". Inoltre: "Pur essendo nati e cresciuti in famiglie della classe operaia e della piccola borghesia di provincia del centro Italia, riconosciamo che le nostre esperienze di classe sono diverse da quelle degli intervistati e che la nostra posizione di ricercatori che vivono e lavorano nel Nord globale ci dà accesso a privilegi che i partecipanti a questo studio non hanno". Mi è sembrato non un esercizio di trasparenza formale ma un gesto politico: rendere visibili i propri privilegi strutturali e allo stesso tempo non rimuovere le ambivalenze dell'identità – con il loro passato in famiglie operaie e piccolo borghesi – dimostra una consapevolezza che arricchisce il testo: anche chi si colloca "dalla parte degli sfruttati" ha il dovere di interrogarsi sempre sulle asimmetrie che intercorrono tra chi studia e chi è studiato, tra chi racconta e chi, di quel racconto, è l'oggetto.
Leggi anche:
Tiziano Bonini | Costi planetari / IA: né intelligente, né artificiale
Tiziano Bonini | Social media come imprese coloniali
Tiziano Bonini | Può l’intelligenza artificiale essere etica?