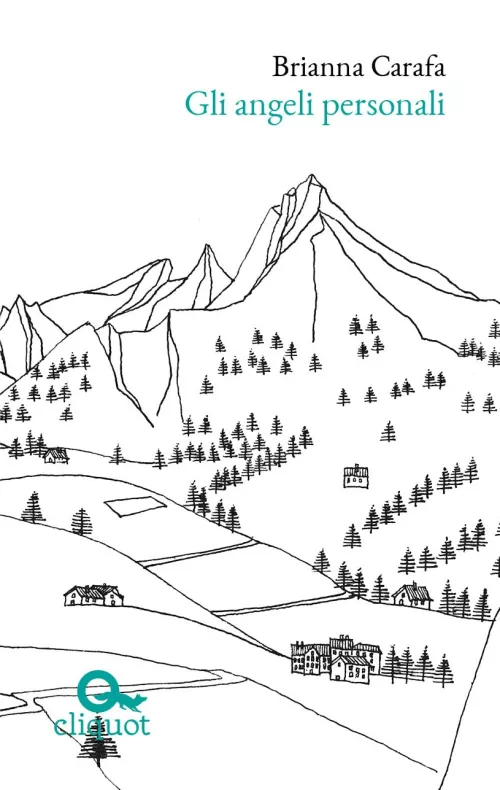Brianna Carafa, Gli angeli necessari
Sono vedute dell’esterno quelle che intervallano i racconti di Brianna Carafa che l’editore Cliquot ha messo insieme ora, la prima volta in forma di volume, riunendoli – con un inedito – dalle pagine di Paragone-Letteratura e Botteghe oscure su cui avevano fatto la loro comparsa tra il ’57 e il ’78.
I disegni della scrittrice, dal tratto semplice e continuo, mostrano luoghi disabitati, o a dir meglio, abitati con misura, dove ancora è possibile cogliervi un’ultima traccia di presenza umana, sottile e come vista da lontano: alberelli e casette – già miniature – costruiscono le pendici quiete di un monte sul vuoto della pagina; e la profondità di una strada deserta restituisce il peso del silenzio – testimone di un’assenza discreta, un discreto ritrarsi. Sono momentanee aperture – distensioni dello sguardo – in cui le forme minute compongono lo spazio e trattengono insieme una semplicità bambina e una serenità da fiaba; ed è la distanza la lente dentro cui ogni cosa sembra trovare un ordine pacificato, una grazia improvvisa (l’atto d’interrogazione, ancora sospeso, tarda qui ad arrivare).
Dove l’occhio si appoggia alla pagina il segno chiama il vuoto che compie la scena, tutta costruita per spazi giocati tra la linea d’orizzonte (figura insolubile, insieme del lontano e dello sguardo) e un guardare (dall’alto, dal basso, da distante) che già allude a una presenza, per quanto inapparente e ritratta dietro il quadro proiettivo che sigilla ogni prospettiva: sono i limiti visivi tra cui si modulano l’altezza di un monte, la viuzza di paese, i pianori dispiegati in lontananza; e che pure già porta il segno di un’animazione sotto gli effetti del prender posizione dello sguardo: il picco si fa immenso, il castello sovrasta, la valle si adagia, e i muri – dove sorgono – sono impenetrabili alla vista e messi di fronte agli occhi come per trattenere, serbare opaco un mistero di assenti.
Sembra di affacciarsi alla soglia di quei versi che la scrittrice pubblica nel ’53 sul primo numero di Montaggio, la rivista di poesia da lei diretta: “Non ci stupisca/ l’intelligenza delle stelle/ o il disegno del destino/ nel cavo della mano/ come non il grano/ che germina nel campo/ alla sua stagione”: che è uno scandito scendere a ritroso la scala dei segni e del linguaggio per trovare un punto d’arresto nell’interezza di una ‘vita naturale’ che può solo accadere: lì dove il correre e il dover vivere della vita – tema caro a queste scritture – ha luogo in un destino che si compie senza scarti, e che non chiede spiegazioni. È un momento di quiete liberatoria, che lascia posto all’esterno e che, senza volerli trattenere – come si fosse su una soglia che travalica l’umano – accoglie e finalmente accetta senza tensioni né paure, quei “miracoli ed eventi familiari, simili alla sera”, di cui è ordito il tempo.
Allo stesso modo accade, nei racconti e nei romanzi di Carafa (La vita involontaria, Einaudi 1975, ora Cliquot 2020; Il ponte nel deserto, Einaudi 1978), che la scrittura si affidi, per intervalli brevi, a una sospensione dello sguardo: quando l’occhio, rasserenandosi, si scopre a inseguire ignaro la presenza e il movimento dei fenomeni che appaiono all’esterno, alla stessa inaspettata maniera in cui si trova a “distinguere il contorno degli oggetti abituandosi al buio”.
Ed è come esser messi di fronte al nascere dello sguardo: un incantarsi che ha scoperto un proprio passo e un proprio respiro silenzioso tra la neve, nel brulichio vivo e anonimo di una cittadina, come nel fermento animato di un frutteto dentro cui si delineano – impensate – “le petunie celesti, bianche, viola, con il ronzio delle api tuffate nei loro calici, il sole e i profumi dell’estate, le lunghe teorie di formiche sulla corteccia degli alberi, l’intrico dei rami contro il cielo, le creste di luce sui fiori del mandorlo, il ricettacolo d’ombra nel fondo…” Ancora, sarà l’apertura inarrivabile del mare “calmo, celeste, tranquillo” a guardarci come limite ultimo e a restituirci in veste eterna la figura cara del Ritratto di straniera.
Tutti i racconti qui, in fondo, giocano col tempo, e lo sfogliano tra passato e presente, in un esercizio mobile di memorazione, come momenti di un accaduto che sta accadendo di nuovo, nell’atto di scrittura. Ma l’immaginazione che si dispiega nel tempo narrativo del ricordo, – quella “vita vissuta che torna ad essere vita inventata” (Delfini) – non porta mai con sé solo l’evento: la scrittura non disseppellisce ripulendo, e non mette a nudo come singoli oggetti le figure e i gesti da cui trae ascolto. Ne riporta invece alla luce il terreno – i suoi umori, le sue ombre – dentro cui gli eventi hanno avuto luogo e continuano a prodursi rimodellandosi di nuovo.
Così che anche quella “piccola isola” che è il ricordo (e sale subito alla mente quel faticoso rimemorare di Ulisse che è l’unico artificio – proprio della lingua – capace di istradarne i passi del ritorno) non può che rivelarsi insieme ai tumulti tempestosi del suo mare, che sono qui le luci eccezionali e grandiose dell’emozione che ne ha impresso, in origine, le forme: e questo è il vero ritorno, la rinnovata scoperta di uno scrivere che stanzia dentro il buio del tempo da cui riporta immagini ancora in vibrazione.
Così propensa a interrogare il fragile stare in piedi della vita, la scrittura di Carafa prova a ripercorrerne gli inizi (Il Giardino perduto, La Governante) da cui fa emergere, in tutta la sua vividezza crudele, l’essere nell’infanzia che prende dimensione e forma dentro le percezioni del piccolo: il suo guardare dal basso all’alto; il suo farsi accosto timido e reverente alla giacca del genitore; il suo cogliere desiderante – gesto animalesco e struggente, involontario e colpevole – l’odore di nicotina che sfugge dalla mano del padre per farci complici di un intimo e inavvicinabile segreto dell’essere grande.
L’infanzia prende misura lì, tutta compresa nella distanza che eccede le persone care (il padre, Luisa, la Governante; e in filigrana, la madre perduta di morte prematura) e che si incunea aspra ad assegnare il posto preciso di bambina. Descritta nella divaricazione di questo allontanamento, la prima età sembra raccogliersi in un antro, stretta in uno spazio angusto che non conosce il proprio esterno – e come potrebbe non avendolo mai (ancora) vissuto? (e qui si fa largo, tangibile, l’idea del vivere come strada percorsa, costruzione che si dà per accumulo, momento per momento…). Eppure, condizione quella di bambina, che intuendo i propri limiti li sfida, disperando di non potervi trovare un senso e di veder giungere il reale da distante come enigma e spazio di paure. È il modo stesso in cui si presenta all’orecchio dell’infanzia il discorso adulto: un inestricabile parlottio su cui si stagliano parole gravi, pericolose e avvolte di mistero, che si fa spazio da dentro il torpore ovattato di un sonno bambino.

“Già avevo capito e proprio per questo avevo provveduto a dimenticare”: così la narrazione fa danzare tra luce e ombra il ricordo della bella figura di Luisa, mettendo a nudo un sapere di sole sensazioni che si muove profondissimo sulla superficie dell’inconscio, pronto a ingannarsi – per non dover soffrire – e a fingere a stesso una dimenticanza che qui viene riconsegnata, in tutta la sua complessità, alla distanza del racconto. Ne viene una scrittura cristallina e mobile che segue le impressioni cangianti del sentire: visioni dall’interno, esposte all’azione della mutazione e del contrasto. Come a suggerire che il reale sia, in fondo, un doloroso, sofferente, esaltato essere dentro l’incostanza del mondo: che è poi sempre, anche, un eccesso del corpo (sul punto di gridare, di piangere) costretto nello scontro a sperimentarne i limiti e le soglie.
È tutto un muoversi, un cambiare di umori e di figure (si capisce qui la verità delle trasformazioni dell’Alice di Carroll: il suo essere continuamente fuori misura, il suo farsi a pezzi), dove l’esporsi non collima mai con quanto incontra, ma scopre invece ad ogni passo incomprensioni, delusioni e tradimenti. Così, persino le figure amate, che si vorrebbero grandiose (quella del padre: un eroe, un Dio…), vedono stingere implacabilmente i propri lineamenti, colte dall’indifferenza, o dalla noia, prese nell’estraneità e nella distanza di cui sembra essere intrisa l’età adulta.
L’infanzia si manifesta qui nelle sue ombre e nello splendore delle immagini che vi scaturiscono in un flusso di invenzioni trasformative: come atto dell’immaginazione – costruzione necessaria a questo reale – che libera la persona da un antro troppo stretto, per muoverla verso il sogno e l’invenzione ad occhi aperti (è il giardino splendido in cui trova conforto la solitudine di bambina, e a cui l’età adulta torna, chiedendo se sia mai davvero esistito, se dovrà essere definitivamente perduto…)
Il fremito a cui la scrittura si espone è quello che si dà sempre stando sull’orlo di una rivelazione, accompagnata da una colpa. È la vita che si mostra attraverso nuovi e imprevedibili scostamenti e non può mai manifestarsi per quello che è: così che il reale sembra potersi avvicinare solo sulla soglia di un’incomprensione, sul filo di uno sviamento, nella divaricazione che genera, similmente, conflitti e stupori: è la piega su cui nasce, preziosa, l’intensità emotiva. E sono momenti di un’emozione assoluta quelli che vengono messi in scena, che si agitano nell’eccesso del sentire: ogni cosa viene fatta battere sulla caparbia – bambina – dedizione al proprio amore per le figure care, che, mai corrisposto, si muta in tensione e conflitto (bisognerà aspettare le pagine conclusive di Aracoeli della Morante per ritrovarvi la stessa intensità amorosa nei confronti del padre; e la stessa inevitabile sconfitta).
La vertigine generata da un presente che cerca un proprio senso è il presentimento spaesante di non poter decidere del proprio destino, e insieme, è l’impossibilità di risalire ad una propria origine. Sulla linea del tempo si fissa uno sguardo strabico che contempla contemporaneamente il passato e il futuro per scoprirvi, in entrambi i sensi, un divieto d’ingresso. Il vivere, colto nel vortice delle sue molteplici possibilità, mostra qui lontananze invalicabili: la vita degli altri si fa cosa distante e irraggiungibile, come opaca e inafferrabile è per i figli quella di ogni genitore; e l’esistenza muove svelta alla solitudine e al senso di estraneità che ne proviene.
Lo stesso fondo inaccessibile si intuisce nel breve racconto di Elodia, la compagna di banco – schiva, reietta – che esponendo allo sguardo della classe i lividi del proprio corpo, non fa che indicare quanto impenetrabile sia la sua figura, chiusa in un proprio mondo duro, capace di raccogliere soltanto ripugnanza e imbarazzo. Come un gioco di luce troppo forte che addensa il buio intorno: che è incomprensione, impossibilità di capire. E il gelo, che infine emerge dal vociare sotterraneo dei bambini, fa da contrasto a un ultimo tormentato frugare della bimba nel cavo di una cartella di misere cose: percezione che lo spiraglio aperto sul reale appena rivelato si sia già definitivamente richiuso; il suo mondo ridotto a un niente. Come se nulla, in fondo, possa mai realmente accadere.
Molte cose si vedono nascere in questi racconti, e tra queste il tempo che si riversa per la prima volta in un’infanzia ancora tutta compresa nella condizione immutabile e eterna dello spazio (le sembianze: quelle di un giardino che è paradiso). È la figura di Luisa a renderne visibili i passaggi, in un racconto che ne scandisce la parabola con movimenti sapienti: si accosta alla donna in un primo disatteso ricordo; ne ritarda l’ingresso tra i luoghi del giardino e il luna park; ne consuma l’incontro in una sera, per poi perderla e ritrovarla – dopo il suicidio – come immagine di sogno. È la figura – forse unica in questi racconti – a cui viene riservato il diritto di un’età adulta; la sola che sembra poterne indicare la strada e renderne praticabile l’accesso: come riconoscimento del limite, accettazione dello sbaglio e del destino che è, poi, un “aver ragione ed essere sconfitta”.
Il ritratto – filo che lega questi racconti, dedicati nella prima parte alle persone più intime della cerchia famigliare della scrittrice (già indicati come Gli angeli personali), e poi rivolti a più lontane figure, a nuovi incontri – è l’esplicita dichiarazione di una scrittura che si muove attorno alla figura umana, ma che già si trova a interrogare il principio stesso della raffigurazione, il senso di immagine dentro cui prende forma: quel suo mettersi di fronte che fa del guardare un essere guardati; quella sua inaccessibile opacità da schermo che pure alimenta una visibilità inesauribile; quel suo dovere di somiglianza che rende partecipi ed estranei al tempo stesso (tutta l’opera di Carafa è un esercizio sul limite, teso tra visibile e invisibile, tra rivelazioni e nascondimenti).
In fondo, la figura umana, colta nella rappresentazione del ritratto, serve a questo: predispone il limite capace di “restituire realtà e misura alle cose”; impone, dentro un riflesso condiviso, le coordinate di una posizione; segna il confine (mobile) della nostra estraneità che è poi anche, indissolubilmente, il riconoscimento di ogni nostro essere singolare. E se l’illusione dell’infanzia è la tensione che eccede verso qualcosa di inavvicinabile, il concreto imporsi della figura che sta di fronte rende possibile la costruzione dell’immagine di sé.
Che qui è immagine sofferta, costretta a guardarsi per diffrazione nel suo faticoso venire alla luce, perché le è stato imposto un nascere senza apparire: costruita tutta nelle pieghe di un sentire che volge in pensiero – la scrittura ne è il deposito, la traccia concreta –, è immagine differita, negata nei suoi tratti visibili, proprio come il riflesso assente nello specchio coperto dalla Governante (per non cedere – viene detto – alle vanità dell’apparire). Mai raggiunta nell’evidenza delle proprie sembianze, l’immagine si alimenta allora di uno scostamento che produce un pensiero denso, molteplice, e un linguaggio che si muove tra fessure, spiragli, non coincidenze.
È una figura interiore di bambina quella che prende forma in negativo: che nella resistenza aperta alla dura legge della Governante – incarnazione di regola e potere – proverà a dirsi per contrasto “cosa non ero”; e che nella disobbedienza e nella trasgressione tenterà la costruzione di un proprio mondo e “la certezza di esserci”. Quella del sentire è una presa di forma scolpita per movimenti di cangiante inversione: sulla piega che vede accompagnarsi sempre alla vittoria una sotterranea sconfitta, che lega la vittima al suo carnefice, che trae dalla violenza il germe della pietà, senza conforto.
È un’iniziazione che si dà nel gesto bellissimo di riconoscere e nominare ogni sentimento sul contorno chiaroscurale del proprio opposto: così che ne possa emergere un pensiero sempre duplice, capace di trovare anche nel conflitto “una sorta di affetto” in cui imparare la lealtà e il rispetto della dignità dell’avversario. Un sentimento nell’altro: come quando, nel definitivo congedo della Governante al realizzato desiderio di libertà farà eco immediata la vertigine sgomenta dell’abbandono.
Gli angeli personali sono le presenze più care che stanziano sulla soglia del reale, mai sbiadite. Sono figure che vegliano il reale, qui offerte nella distanza del tempo e della scrittura, attorno cui ha luogo tutta la faticosa formazione del pensiero e del sentire: quello scatenamento di forze che avvia la domanda del perché nell’infantile incapacità di accettare la sconfitta che la vita riserva, pur avendone già inteso il correre inesorabile e i fallimenti. Si può fallire, insegna Carafa, come una delle tante possibilità messe in gioco dalla vita, di cui rivela il fondo insicuro e l’insensatezza; quindi, l’errore, l’incapacità, la distrazione, il dubbio, il movimento fragile che altalena – sul vuoto – scelta a destino.
Esistere è possibilità del reale, una delle possibili forme in cui la vita si cristallizza e dentro cui si consuma. Ne dà misura l’amico Manlio (Altrove) col suo matematico e paradossale esperimento che è la scommessa di poter propiziarsi il proprio destino e raggiungere, andandone a caccia, la “giusta occasione” che in fondo – ha la certezza – lo attende dentro un nugolo di occasioni mancate: è il tentativo di sollecitare una momentanea coincidenza dell’esistere come azzardo a cui votare la vita, che in realtà non fa che azzerare il conto di atti sempre ripetuti in un meccanismo vuoto, in una circolarità che rende vano ogni ritrovamento e immutabile il movimento del tempo.
Eppure il vero scacco al reale è quello che si dà nel Ritratto di straniera, il racconto pubblicato nel ’78 su Paragone-Letteratura, poco dopo la scomparsa della scrittrice e dedicato alla figura della nonna: straniera la si dice, perché incapace di afferrare il reale su cui sembra correre invece, senza farsi trattenere. La narrazione, dalla presa leggera, ripercorre i gesti della sua figura tenera e altera, annodandoli come in un merletto vaporoso attorno al centro vivo di domande che incitano con ostinazione il vivere, affidandogli un senso. La nonna emerge con la grazia di quei personaggi che fanno della comicità dolce e malinconica un modo di attraversare il mondo senza esserne scalfiti: un angelo necessario che disposto sulla soglia del reale ne afferma una propria fantasia, conservando inalterato il proprio sogno.
E come tutte le figure splendenti della letteratura – lei, più di ogni altra in questi racconti, è figura eminentemente letteraria, circondata da nobili e principi decaduti, da polvere e da crepe – si fa presenza potente: capace di procurare una lacerazione al reale, di smontarlo nei cardini del suo costrutto, nei meccanismi del suo funzionamento, per farne cosa incomprensibile.
Sono domande piane, nude, quelle messe in scena per rivelare il mondo nei suoi paradossi e nei suoi egoismi, nelle scaltrezze e negli inganni che lo tessono. Eppure, domande complessissime, messe a fondamento del desiderio (“…che ciascuno possa avere una casa…”) che guida l’intera vita della protagonista in un progressivo abbandono di titoli e ricchezze che la sottrae ad ogni vincolo sociale: un procedere che in realtà si fa ritorno a quegli spazi aperti della terra – paesaggi “mossi, incolti, disabitati” – dentro cui si è riconosciuta la libertà intravista un giorno (o solo immaginata?), nelle lontananze del ricordo.
Figura gettata nel mondo a cui è estranea – a cui tutti si è estranei – va conservando intatta la propria infanzia: che qui è necessità di aprire gli spiragli del reale per farne entrare nuovamente l’aria. Perché le regole che conducono il movimento del mondo sembrano perdere senso se poste di fronte a un sogno ostinatamente intatto (e, poi, veramente così bambino, così ingenuo?), capace di guardare lontano, a partire dalla semplicità disarmante del proprio desiderio e dalla necessità imperiosa della sua domanda: perché, in fondo, non è davvero possibile che tutti abbiano una casa? perché non può esistere davvero un mondo senza povertà? perché non possono darsi le ragioni di una pace universale?