Julia Deck, tra Ann e sua figlia
Milan Kundera era convinto che tutte le storie finiscano per indagare “l’enigma dell’io”. Nel suo libro L’arte del romanzo (tradotto da Ena Marchi per Adelphi nel 2023), l’autore ceco naturalizzato francese affermava di credere fermamente che “dal momento in cui si crea un essere immaginario, un personaggio, ci si trova automaticamente di fronte alla domanda: che cos’è l’io? In che modo lo si può cogliere?”.
Quando si scrive, però, è evidente che l’io non può fare tutto da solo. Deve per forza confrontarsi con l’altro. Diceva Paul Celan nel suo testo Il meridiano, dedicato alla “verità della poesia”, che ogni autore di versi “ha bisogno di un interlocutore. Gli va incontro, lo annuncia”. La stessa via che deve percorrere il romanziere.
Finora, Julia Deck non si era mai confrontata in maniera frontale con tutto ciò che ruota attorno al “più lurido di tutti i pronomi”, come lo definiva l’ingegnere Carlo Emilio Gadda. L’io, appunto. Anche perché, nel suo percorso di scrittura, aveva sempre scelto il romanzo-romanzo. Proclamando a gran voce che, lei, le storie e le figure che le abitano, si è sempre divertita a inventarle. Come dire che all’io ha riservato un angolino in ombra in testi assai apprezzati dalla critica e dai lettori: Viviane Élisabeth Fauville (Adelphi 2014), Sigma e Proprietà privata (Prehistorica Editore 2022 e 2025). Trame perturbanti, cesellate con il bisturi dell’ironia e del cinismo, raffinate e folgoranti. Sempre pronte a sorprendere.
Poi, la vita ha sbattuto Julia Deck davanti al richiamo insistente dell’io. Facendole vivere in prima persona una storia drammatica: sua madre Ann, traduttrice di origine inglese, in una limpida domenica di aprile è stata colta a tradimento da una devastante emorragia cerebrale. Quando la figlia l’ha trovata, riversa sul pavimento del bagno nel suo appartamento di Tolbiac, al nono piano, erano passate ventotto ore. Più di una giornata intera trascorsa da sola, per terra, accanto alla vasca sporca di sangue. Incapace di muoversi, di chiamare aiuto, di articolare parole.
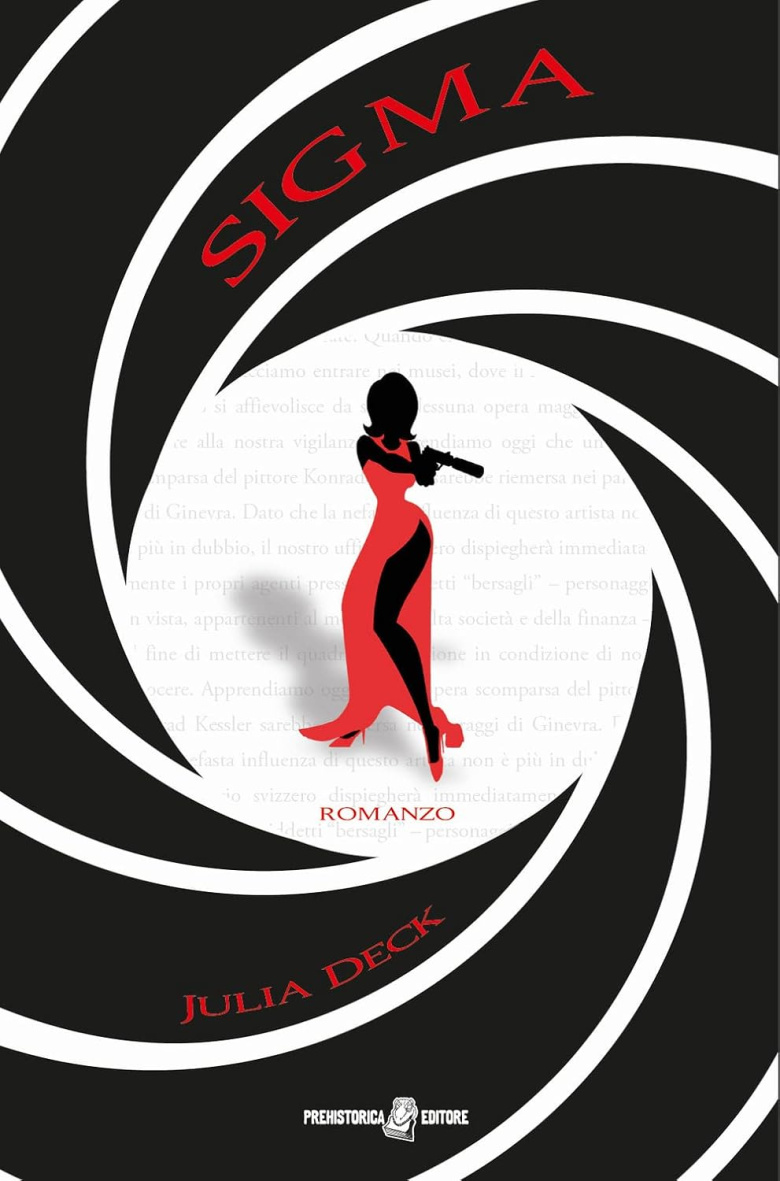
È quello il colpo di dadi, inaspettato, che una figlia teme arrivi prima o poi, senza annunciarsi, nella vita. E quando si materializza, porta appresso a sé una caterva di dubbi, incertezze, domande. Insieme alla convinzione profonda che, dei propri genitori, i figli non sanno mai abbastanza.
Ha preso forma da lì, dal desiderio di affrontare per la prima volta non una storia d’invenzione, ma un percorso narrativo più intimo e confinante con l’ambigua drammaticità della vita reale, Ann d’Inghilterra, il nuovo romanzo di Julia Deck tradotto da Yasmina Melaouah per Adelphi (pagg.201, euro 19), che nel 2024 ha vinto in Francia il Prix Médicis.
“Un colpo di dadi mai abolirà il caso”, sosteneva il poeta Stéphane Mallarmé. E l’aver tentato per la prima volta la strada di un racconto così intimo ha spinto Julia Deck a scoprire che ci sono diversi piani di narrazione per mettere a fuoco se stessi, la propria storia, l’esistenza della donna che ci ha messi al mondo e i complicati intrecci familiari. Sulla pagina, il gioco di rifrazioni, lo specchiarsi in altri specchi, diventa complesso, sfuggente. Tanto che quando la voce narrante dice “io” capisce che, nel divenire del testo, la storia vista con gli occhi della figlia è passata prima per il vissuto della madre.
Il calvario di Ann diventa, così, non solo una presa di coscienza di quanto i corpi segnati dalla malattia siano per il sistema sanitario, e per la società tutta, impicci da collocare al più presto in strutture assistenziali, che pretendono il pagamento di parcelle esorbitanti. Tanto che Julia Deck si diverte, con ironia feroce, a storpiare i nomi stessi degli ospedali, trasformandoli in Charité-Arbitraire, Brico-Ouest. Ma questa storia così personale spinge anche la scrittrice a percorrere a ritroso le tappe della vita di Ann. Dalla sua nascita in una piccola località a quattrocento chilometri da Londra alla brillante carriera scolastica, coronata dalla laurea in Letteratura francese. Per farla approdare, poi, a una nuova vita in Francia, segnata dall’uso di una lingua non materna, che attraverserà i tempi della Nouvelle Vague, gli Swinging Sixties, gli anni Ottanta del tramonto dell’engagement e dell’imporsi di nuovi miti, nuovi riti, fino al grigiore del finire del ‘900. Arrivando a una vecchiaia vissuta senza mai abbassare la guardia. Come una regina d’Inghilterra in esilio, aggrappata ai giorni che rimangono grazie all’inestinguibile passione per la letteratura, il cinema, la musica.
Dietro l’indomita ombra di Ann emerge, lentamente, sempre più nitida, mentre scorrono le pagine del romanzo, la figura della figlia: Julia Deck. Che scrivendo questo libro scopre come si possa raccontare se stessi in un gioco continuo di rimandi alla vita dell’altra, della madre ingombrante come un monolite, sempre in fuga da un segreto che non troverà una risposta limpida e definitiva. Perché il romanzo è fatto di realtà e finzione, ma non c’è mai una netta linea di demarcazione a separare il vissuto e il narrato.
Per ricomporre l’io di chi racconta bisogna, così, avere il coraggio di altalenare autobiografia e immaginazione. In una continua messa a fuoco di una verità che può concedersi ai riflettori degli inoppugnabili dati biografici, per svicolare in fretta dentro la penombra del non detto, dentro la materia oscura del non confessato. Avventurandosi in un viaggio accidentato verso l’arcano senso della vita, che solo la letteratura può arrischiarsi di scandagliare.

“Quando scrivo, in Ann d’Inghilterra, che accarezzo l’idea di un libro in cui potrei finalmente dire la verità, c’è anche un fondo di ironia – spiega Julia Deck, padre francese e madre inglese, che è stata ospite di Pordenonelegge –. Perché sì, voglio trovare la verità, ma, al tempo stesso, mi chiedo anche che cosa sia. Mentre mi dedicavo a questo nuovo libro ho avuto la sensazione di avvicinarmi, lentamente, alla verità. Ovvero, al processo che permette di dare voce a una situazione. Nella vita, come nei romanzi, realtà e finzione si mescolano sempre. Quindi, mettere in scena dei personaggi, una trama, finisce per rivelare qualche cosa. Un po’ come accade nelle sedute di psicoanalisi, anche se con me questa pratica non ha mai funzionato”.
Invece funziona la pratica della scrittura di un romanzo?
Sì, perché il romanzo materializza le proprie ossessioni. Fornisce le parole giuste per raccontare determinate situazioni. A me permette di capire certe cose che, altrimenti, resterebbero per sempre indecifrabili.
Realtà e finzione: due facce della stessa materia narrativa?
Non credo che ci sia grande differenza nello scrivere un romanzo che si basa su dati autobiografici rispetto a quello che utilizza soltanto la fantasia. Se trasferisco sulla pagina alcuni fatti della mia vita non per questo devo raccontare la realtà nuda e cruda. Attingo a situazioni reali, mi riferisco a persone reali non a personaggi, però devo inventare, ricreare, tutto quello che sta attorno.
Però sono pur sempre due strutture narrative difformi?
Ma certo. Se attingi all’autobiografia, hai a disposizione un materiale narrativo enorme. Quindi il lavoro principale è quello di ridurre, devi costringerti a utilizzare i fatti e i personaggi che possono funzionare sulla pagina. Anche perché, in caso contrario, si rischia di annoiare il lettore con un’alluvione di storie secondarie. Nel caso, invece, di un romanzo che nasce solo dalla fantasia, il processo creativo è inverso. Lì, infatti, bisogna aumentare i dettagli, potenziarli. Creare un microcosmo che sia credibile per chi vi si immerge.
Anche Ann è vera fino a un certo punto?
Ho voluto guardare mia madre dall’esterno. Racconto Ann partendo dal 2022, dal suo malore a cui segue il ricovero. Ma tutta la sua vita precedente ho dovuto reinventarla come se avessi a che fare con il personaggio di un romanzo, tenendo conto che lei negli anni della giovinezza era pur sempre una ragazza, non ancora mia madre. Era un’inglese, rimasta sempre inglese anche quando si è trasferita a vivere in Francia. Anche dopo 50 anni. Inoltre, ho voluto darle una sfumatura di nobiltà. Perché se è vero che la regina d’Inghilterra quella nobiltà l’ha ereditata, mia madre ha dovuto conquistarsela. Senza alcun sostegno, potendo contare solo sulla propria forza di volontà e su un’inestinguibile energia vitale.
Crede nella scrittura come forma di terapia?
Non è quello lo scopo della scrittura. Io, ad esempio, non ho mai scritto dei diari. Neanche quando ero adolescente. Non mi fa piacere raccontare la mia vita. Infatti, finora, ho sempre scritto romanzi-romanzi. Però, in alcuni momenti, la scrittura può risultare liberatoria: per esempio, quando in Ann d’Inghilterra ho cominciato a raccontare la mia infanzia usando la terza persona. All’inizio mi sembrava un procedimento di scrittura finto, artificiale, e mi annoiava un po’. Però subito mi sono detta che non dovevo raccontare Julia, ma guardare quei fatti con gli occhi di Ann. Era sua la gravidanza, suo il travaglio e il parto. Così, ho capito che questa strategia mi permetteva di allontanarmi da me stessa, esorcizzando certi sensi di colpa legati a quegli anni lontani. In altre parti del libro, invece, mi sembrava più efficace usare direttamente l’io. Così ho ottenuto due personaggi distinti, due volti della stessa Julia. In questo caso, sì, potrei definire la scrittura come un processo terapeutico.
In tutti i suoi romanzi c’è uno sguardo critico sul mondo reale, anche se lei non costruisce mai libri di denuncia.
Sono stata molto influenzata dalle letture che ho fatto. Nel Diciannovesimo secolo gli scrittori avevano un posto importante nella società. Charles Dickens e Jane Austen condivano i loro romanzi con un’ironia decisamente pungente. Gli scrittori francesi di oggi rinunciano a osservare la realtà con lo sguardo tagliente che caratterizzava la prosa di Balzac, Flaubert, Zola. Penso che l’ironia sia salutare nei romanzi, perché ci permette di parlare alla società, di creare un confronto dialettico con i lettori, pur senza voler trasformare la narrativa in una tribuna politica.
Tra Ann e sua figlia, tra mille incomprensioni, c’è sempre stato un canale di comunicazione preferenziale fatto di libri?
La letteratura è sempre stata la lingua comune da condividere con mia madre. All’inizio ci parlavamo in francese, ma posso dire che umanamente ci capivamo poco. Poi, all’improvviso, quando avevo 16 anni, le ho detto che sarei passata a parlare con lei in inglese. Sicuramente sono molto migliorata, intendo nei miei dialoghi in inglese, però abbiamo continuato a non capirci. Oggi usiamo un po’ il francese e un po’ l’inglese. Ma i momenti più belli sono quelli in cui leggiamo insieme i romanzi di Dickens.
C’è un mistero in Ann d’Inghilterra, legato alla vita di sua madre: sembra che la via narrativa agli enigmi la affascini sempre, quando scrive.
Ho la sensazione che se in un romanzo non c’è un mistero, rischia di non esserci nemmeno la storia. Si parte sempre da un problema, da un enigma legato alla realtà. Quando ho iniziato a scrivere Ann d’Inghilterra ero sicura di riuscire a risolvere il mistero legato alla vita di mia madre. C’era stata un’altra figlia prima di me, o no? Poi, però, mi sono accorta che dare una risposta poteva risultare artificioso. Perché la realtà non è mai nitida, alberga sempre in sé i germi della menzogna. Allora, ho preferito seminare informazioni, girare attorno a quel segreto, senza fornire la soluzione.
Leggi anche:
Massimo Ilardi | Julia Deck: i mostri accanto a noi







