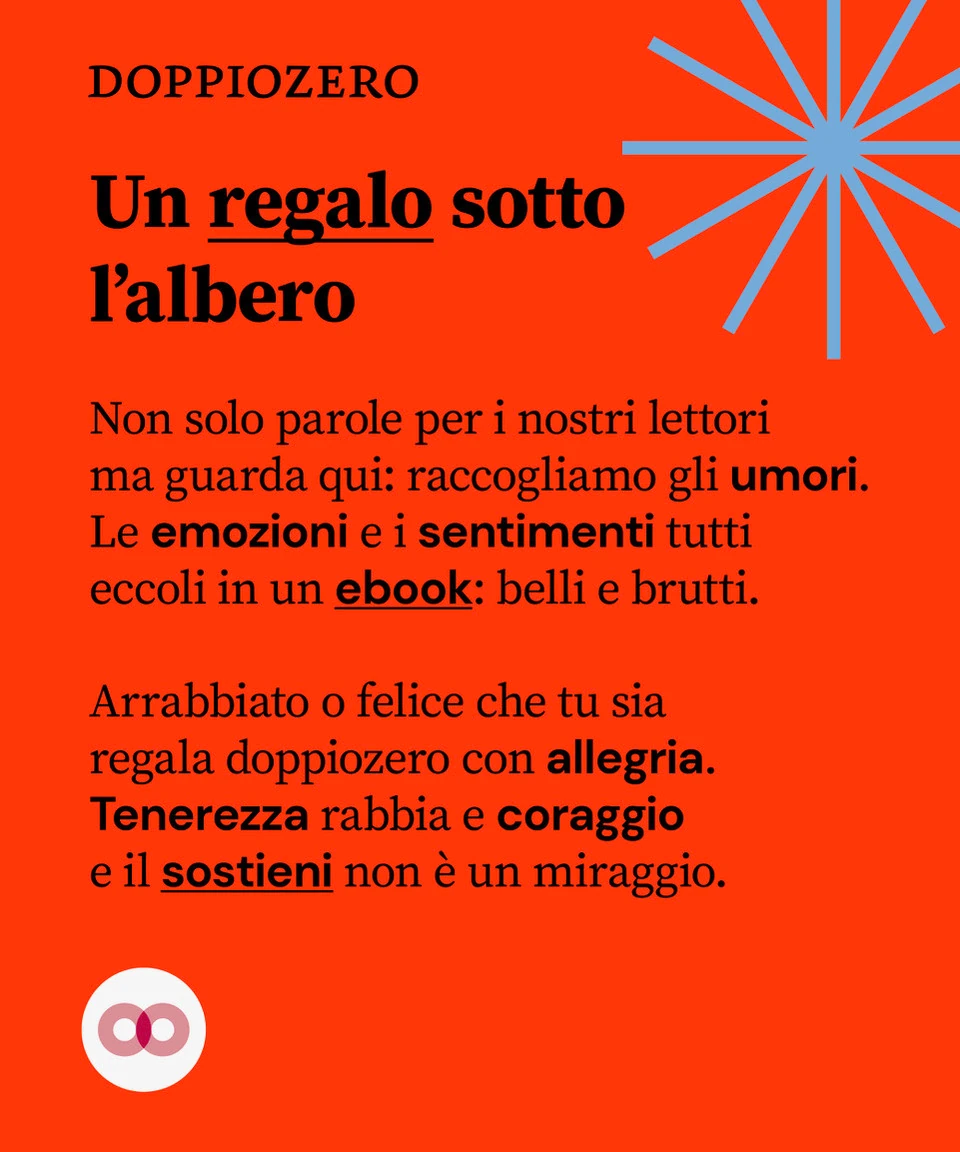Teaching- vs. research-universities
Come si definisce una buona politica industriale? Quali relazioni esistono con le politiche dell’istruzione superiore? E quale credito concedere alle retoriche su “innovazione dirompente” e start up? Sono queste le domande cui Gianfelice Rocca, presidente di Techint e fondatore dell’Istituto clinico Humanitas, già responsabile educativo di Confindustria, si propone di rispondere.
Un’analisi del sistema industriale italiano costituisce la premessa. Sono le industrie a media tecnologia, per Rocca, a meritare riconoscimento e sostegno strategico: la petrolchimica, l’elettrotecnica, la meccanica, l’automobilistica, la medicale, la nautica. Il mito della Silicon Valley (o del “giovane-Steve-Jobs-nel-garage-di-casa”) ci spinge a dimenticare una circostanza fondamentale: sono i settori industriali intermedi a sospingere l’economia italiana. L’Italia è più simile alla Germania che alla California, e può attendersi un maggiore beneficio da innovazioni di tipo incrementale.
I percorsi educativi superiori dovrebbero essere profondamente modificati per venire incontro alle esigenze dell’industria manifatturiera, e anche l’università, dal punto di vista di Riaccendere i motori, richiederebbe modelli organizzativi del tutto diversi. Rocca è cauto e felpato ma le sue affermazioni, se contestualizzate, preludono a svolte radicali. Così, quando auspica che l’ANVUR introduca distinzioni “tra forti competenze educative e tecnologiche e obiettivi di eccellenza scientifica”, non si limita a plaudire all’operato dell’agenzia nazionale di valutazione universitaria. Si schiera invece per la netta separazione tra research- e teaching universities.
La proposta solleva difficoltà che sembrerebbe inopportuno trascurare; ma su cui Rocca tuttavia sorvola. Esemplifichiamo. L’università italiana ha un preciso profilo storico-istituzionale. Al suo interno il reclutamento dei docenti si è svolto (e si svolge tuttora) senza alcuna distinzione tra atenei maggiori e minori. Localismi e affiliazioni accademiche hanno determinato carriere (o conferimenti di incarico) molto più di qualsiasi criterio autenticamente “meritocratico” e concorrenziale. “[A differenza di quanto] accade a livello internazionale, la dimensione degli atenei [italiani] non è correlata a migliori risultati in termini di qualità della ricerca”. “[La circostanza] non sorprende se si considera che le eccellenze appaiono diffuse nei diversi dipartimenti delle università italiane”, affermano affermano Pasqualino Montanaro e Roberto Torrini nel testo Il sistema della ricerca pubblica in Italia (in: Questioni di economia e di finanza, 219, aprile 2014, Banca d’Italia, Roma 2014, p. 39).
In assenza di chiamate nominative e di un’effettiva competizione tra ricercatori è sbagliato supporre che un docente in servizio nelle università di Pisa, Roma o Milano valga ipso facto più (o meno) del suo pari grado di Chieti, Cagliari o Bergamo. Se scegliessimo di introdurre la distinzione tra research- e teaching universities per così dire dalla sera alla mattina come potremmo spiegare a taluni studiosi, ma non ad altri, che la loro professione è improvvisamente mutata? Per di più in assenza di un’attendibile anagrafe nazionale della ricerca?

Sbrigatività e salti argomentativi nuocciono talvolta a un libro che pure si sforza di essere persuasivo. Rocca ci esorta a credere nella sua imparzialità. La richiesta tuttavia si rivela a tratti inesaudibile. Egli stesso imprenditore del medium tech, pretende che la difesa del settore, non altro, sia la priorità del governo; e che l’intera politica educativa debba essere orientata alle “esigenze del mercato”. Ma è proprio così dal punto di vista dell’interesse generale? Le “esigenze del mercato” possono essere oggi molto diverse da quelle di domani.
La difesa del settore manifatturiero in cui si hanno ampi e diramati interessi si avvale, in Riaccendere i motori, di argomenti non strettamente industriali. A differenza dell’high tech, sostiene Rocca, il medium tech favorisce “coesione sociale”. Contiene la forbice salariale. Premia l’esperienza, e dunque riduce l’obsolescenza del “capitale umano”. Promuove inoltre un atteggiamento cooperativo tra aziende e saldo radicamento territoriale.
La domanda è: il tratto coesivo e territoriale che si presume associato al medium tech è connaturato ad esso, dunque per così dire tipologico, o storico e contingenti? Mi spiego. I distretti industriali italiani si sono in buona parte evoluti nei decenni precedenti all’affermazione dei paesi emergenti sui mercati globali. E’ il tipo di produzione o piuttosto la concorrenza (o meglio la mancanza di concorrenza) di mercati del lavoro selvaggiamente deregolati ad avere modellato economie regionali e culture imprenditoriali?
La prospettiva microeconomica si intreccia ripetutamente a quella macroeconomica sino a risultare indistinguibile: ma questo non è lecito sotto profili di metodo. Chi può ragionevolmente escludere che l’investimento pubblico (diretto o indiretto) in medium tech riduca (anziché accrescere) opportunità e benessere diffuse? Le variabili micro sono troppo numerose perché si possa dare per scontata questa o quella conseguenza macro. D’altra parte si tratterebbe pur sempre di togliere risorse ad altri settori. Il medium tech assicura ai lavoratori una maggiore longevità di servizio, assicura Rocca, perché è frutto di innovazione e esperienza insieme. Certo: ma la consuetudine di richiamare in servizio lavoratori anziani e già pensionati, da parte delle aziende, verosimilmente non avvantaggia l’occupazione giovanile.
“Bisogna abbattere le barriere di diffidenza tra [imprese e università]”, ammonisce il presidente di Techint, e l’intenzione è lodevole. Modi argomentativi sommari non sono tuttavia i più adeguati al processo di distensione. Pur trattando di università, Rocca manca di dare un sia pur minimo resoconto di posizioni diverse da quelle da lui sostenute; e fa proprie attardate polemiche (contro “gli anni Settanta”) che riecheggiano punti di vista litigiosi e retrivi apparsi di recente presso lo stesso editore (Maurizio Sacconi, introduzione a Giuliano Cazzola, Simonetta Matone, Filippo Mazzotti, Domenico Sugamiele, Anni ’70. I peggiori della nostra vita, Marsilio, Venezia 2011, pp. 7-18).
Sono nato nel 1966 e ho dunque un rapporto archeologico con gli anni Settanta: nient’altro. Avevo poco più di un anno quando la contestazione studentesca attraversava la penisola. Al tempo del sequestro di Aldo Moro frequentavo la seconda media. Trovo perciò dissociativo, oltreché discriminatorio, invocare misure distruttive dell’autonomia della ricerca rievocando contrapposizioni ideologiche passate.
A mio avviso l’università è (nel senso che deve essere) un luogo di democrazia avanzata, in cui le ragioni del “talento”, dell’indagine critica e dell’autodeterminazione si intrecciano virtuosamente a quelle dell’equità sociale. Al pari di tanti ricercatori e scienziati della mia generazione (o delle generazioni più giovani) ho avviato la mia carriera universitaria sotto le condizioni meno propizie, dopo che reclutamenti indiscriminati ope legis, a cavallo dei decenni Settanta e Ottanta, avevano saturato i dipartimenti e distrutto le corrette modalità di accesso alle professioni della ricerca. Chiedo quindi di non essere ucciso dagli stupidi missili di una guerra fredda che continua a esistere solo nell’immaginazione patriarcale. Che la discussione segua allettanti linee pragmatiche e verta sulle difficoltà reali di chi in università vive e lavora ogni giorno. Oggi.
Le attuali agenzie di valutazione non hanno sinora rappresentano la svolta “meritocratica” attesa. Al contrario: la loro azione rischia di consolidare oltremisura statu quo accademico e privilegio anagrafico. L’Italia è un paese che ha un’impellente necessità di persone capaci e disinteressate, cioè di ricercatori innovativi. Impegnamoci dunque perché l’intero sistema universitario nazionale accolga più elevati standard scientifici e deontologici. Non ci si può ragionevolmente proporre di favorire cinque o sei poli di “eccellenza” lasciando che tutto il resto vada in rovina; né fingere di ignorare i margini di discrezionalità e arbitrio metodologico che sono stati talvolta denunciati dietro la classificazione di riviste presuntivamente di fascia A. Sorprende che un imprenditore pronto a riconoscere l’importanza sociale delle imprese per i “territori” neghi poi il ruolo economico e civile delle università che hanno sede in centri minori.
Perché l’università cambi, afferma Rocca, occorre che “i fondi siano allocati correttamente, i metodi di selezione risultino ‘meritocratici’ anziché ‘relazionali’ e vi siano opportunità di collaborazione con il mondo dell’impresa”. Concordo. Tale processo, conclude tuttavia l’autore, è troppo “lento e complesso”. Meglio escogitare stratagemmi di più rapida attuazione. Spetterebbe dunque ai corsi in inglese di nuova istituzione attrarre studenti non italiani e promuovere un’”internazionalizzazione dal basso”: questa la tesi.
Personalmente mi esprimo a favore della conoscenza delle lingue, dei soggiorni di studio e ricerca all’estero, dell’istituzione di rapporti ben più stretti tra università (almeno) comunitarie. Osservo però che la priorità di gran parte delle università italiane è un’altra: appunto la trasparenza dei processi di reclutamento e la corretta “allocazione” delle risorse. Che importa se il processo di riforma sarà “lento e complesso”? Importa che sia giusto e necessario. O vogliamo raccontarci che la presenza in aula studenti di olandesi e americani bonificherà l'istituzione accademica a mo’ di “vincolo esterno”, in maniera neutra e indolore?
L’enfasi eccessiva è a mio avviso rivelativa di un’attitudine strumentale. L’introduzione dei corsi in inglese, che possiamo peraltro ben auspicare, è utile a taluni dipartimenti e alle aziende interessate a stabilire relazioni durature con professionisti internazionali. Ma non risolve le difficoltà dell’università italiana nel suo complesso e si esaurisce nel vantaggio di pochi. La creazione di un’agenzia governativa di sostegno alla traduzione in lingua inglese della migliore saggistica universitaria o addirittura la riforma “meritocratica” degli istituti di cultura italiana all’estero, trasferiti nelle competenze del MIUR (oggi invece di competenza del ministero degli Affari esteri), non avrebbe minore efficacia sul piano delle relazioni internazionali. Una brillante monografia su Paolo Uccello non è meno “globale” della laurea magistrale in inglese; forse contribuirebbe meglio all’immagine diplomatica del paese.
“Assumere la centralità dell’impresa”, suggerisce Rocca, “non snatura l’istituzione universitaria: non la svuota, non la banalizza e non toglie necessariamente spazio alla ricerca speculativa o alle scienze umane”. Temo che, così posta, l’affermazione sia nient’altro che una petizione di principio. L’istituzione universitaria è sempre (e direi violentemente) “snaturata” quando si assume che suo compito prioritario (o unico) sia esaudire le richieste immediate dell’impresa – non educare alla ricerca, premiare la curiosità o formare cittadini. Rocca assume sì che il compito della formazione (anche tecnica!) sia stimolare un’ingegnosa versatilità (“strumenti più che conoscenza”, come dice Gianfelice Rocca in Riaccendere i motori, p. 44.), ma non chiarisce come questo possa accadere se i corsi di studio espungono competenze storico-critiche, artistiche e più in generale l’abitudine all’interrogazione, al libero esame, al dubbio metodico. Quale “versatilità” potremo mai attenderci da una nazione di “quadri” istruiti all’ubbidienza? Il “paese dei periti” vagheggiato in Riaccendere i motori risulta pericolosamente simile alla tetra coorte di “yes-men” adunata da Ridley Scott in 1984, il video di lancio del Macintosh.
E’ evidente: se accettiamo di istituire incentivi per le discipline più “spendibili” sul mercato (proprio quelle che ne avrebbero minore bisogno!) assoggettiamo l’intero sistema universitario a una pressione economico-finanziaria insostenibile. Le discipline non applicative – tutte: non solo le Humanities – dovranno competere con le discipline applicative proprio sul piano dell’applicatività, e se non lo faranno saranno escluse dalla distribuzione “premiale”. Tutto ciò esula dal semplice esercizio di valutazione dell’attività di dipartimenti e ricercatori: corrisponde invece a un vasto disegno di normalizzazione politica e istituzionale.