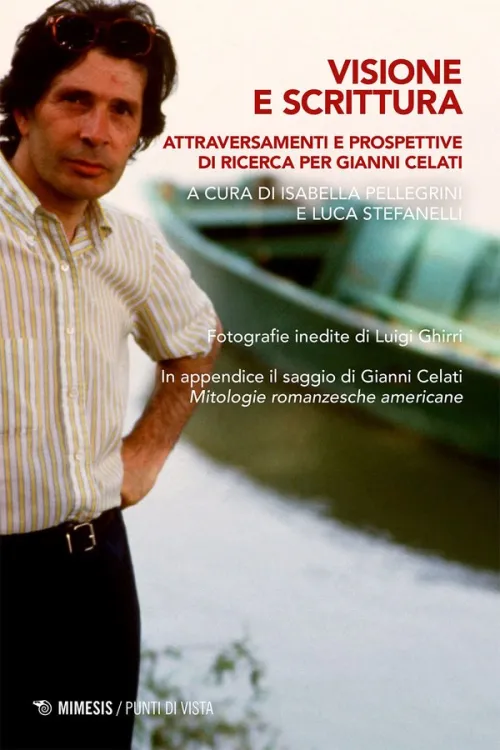Celati tra Joyce e Céline
Venticinque anni fa usciva, per la Toronto University Press, Gianni Celati: The Craft of Everyday Storytelling di Rebecca J. West. Era il primo libro accademico interamente dedicato allo scrittore che, già ben noto in Italia, cominciava ad essere tradotto e studiato anche nel mondo di lingua inglese. Gianni e Rebecca erano legati da una bella amicizia e l’uscita del libro fu l’occasione per una festa molto familiare a casa della professoressa West, una delle docenti di punta del dipartimento di Romance Languages della University of Chicago. Il libro, corposo, con in copertina quella che diventerà l’iconica immagine dello scrittore, solido nella struttura argomentativa, sollecitante per i collegamenti fra il Celati narratore, saggista e “video maker”, faceva bella mostra di sé su un tavolino della sala.
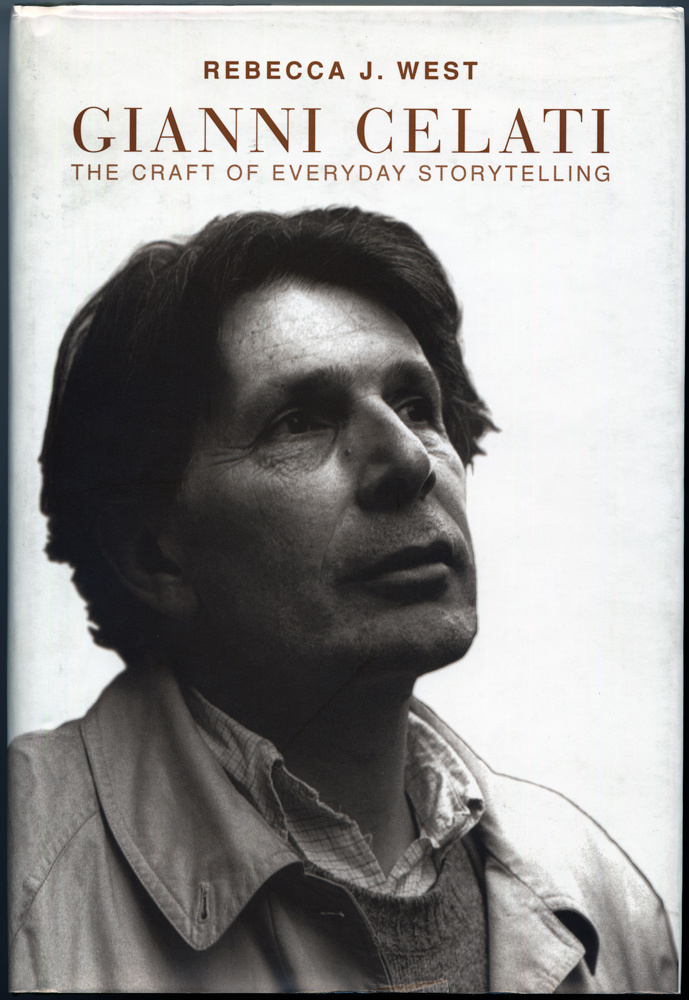
Come è noto a chi conosce la bibliografia critica su Celati, il volume della West ha molti meriti, e, certo, non solo quello di essere stato il primo ampio studio sull’opera dell’autore. Gianni a inizio cena si scusò per non avere avuto ancora il tempo di leggerlo, ma probabilmente mentiva. Comunque si vedeva che era lusingato e, soprattutto, che era contento dell’occasione di trovarsi a Chicago con Rebecca, il suo compagno e filosofo della matematica William Walker Tait (Bill), da Celati molto stimato, e altri amici. Durante la serata si parlò di tutto, ma non del libro, oggetto però di ripetuti brindisi che resero la festa ancora più amicale e affettuosa. A un certo punto, d’improvviso, senza nessun collegamento con quanto si stava dicendo, Celati, seduto comodamente in poltrona, con il suo tono un po’ cantilenante e artatamente incerto, da attore naturale, prese la parola e disse con un filo di voce: “Che poi l’altro giorno ho capito in che cosa consiste il pensiero debole: che ognuno dice quel cazzo che gli pare!”.
Per Rebecca quella frase deve essere stata una secchiata d’acqua ghiacciata, perché alcuni passi del libro sono dedicati proprio a un presunto rapporto fra la poetica di Celati e il pensiero debole. Per chi invece aveva letto il libro e si era meravigliato di quell’inatteso collegamento, l’apparentemente incongrua considerazione di Celati confermava che a volte è facile prendere degli abbagli quando si fa troppo affidamento su quelle che sono le mode del momento. E in quel momento in America la filosofia italiana era Vattimo e il pensiero debole, mentre Melandri o certa fenomenologia, che avevano di certo molto più a che fare con il pensiero di Celati, non erano al centro degli interessi degli italianisti che cercavano con intraprendenza e serietà di studiare e di far conoscere anche al di là dell’Oceano alcune nuove voci della letteratura italiana. L’accostamento con Vattimo deve essere stato proprio indigesto a Celati se in un’altra occasione ebbe a dire: “Io… non… capisco… Rebecca… dice che ho scritto… quello che ho scritto… perché ho letto… Vattimo” (Alessandro Carrera su Doppiozero). Risfogliando quel libro a distanza di anni, ci si accorge che i riferimenti al pensiero debole sono marginali, e che forse Celati, indispettito da quella erronea filiazione, anziché lasciarsi andare a una polemica accademica, ne aveva fatto una piccola, stralunata gag comica eseguendola persino davanti alla sua amica, per bacchettarla di sghembo.
Oggi sarebbe bizzarro fare certi collegamenti, soprattutto dopo il grande e meritorio lavoro editoriale svolto negli ultimi vent’anni da studiosi e amici di Celati come Marco Belpoliti, Nunzia Palmieri, Ermanno Cavazzoni, Jean Talon, Andrea Cortellessa e altri che hanno reso facilmente disponibili non solo le opere e i saggi, ma anche le preziose interviste, gli interventi o alcune lettere.
Riprendendo da Canonici si diventa (Palumbo 2022) di Isotta Piazza le due definizioni di canone, credo che si possa dire che se Celati ancora non è un autore di primo piano del “canone diffuso” (quello cioè costituito da opere di largo successo editoriale che entrano nel patrimonio di generazioni di lettori popolando quel campo letterario ormai del tutto industrializzato), di sicuro fa parte del “canone ufficiale”, quello sorvegliato dalla “comunità dei lettori ‘qualificati’” (p. 149). La sua presenza nel canone ufficiale è testimoniata della sempre maggiore quantità di libri, convegni, numeri monografici di riviste a lui dedicati. E, verrebbe da dire, non poteva essere altrimenti perché Celati non è stato solo uno scrittore di racconti, ma un pensatore coltissimo ben più sistematico e coerente di quanto si possa credere, oltre ad essere artista poliedrico, libero, trasgressivo, inquieto, capace di smuovere, interrogando e interrogandosi, e spesso anche riscrivendosi, come dimostrano anche le edizioni dei suoi romanzi o di Finzioni occidentali, il suo libro di critica letteraria più solido, rielaborati ripetutamente a distanza di anni.
L’analisi delle Varianti strutturali e linguistiche nelle riscritture di ‘Lunario del Paradiso’ è stato oggetto di un laboratorio svoltosi all’università di Pavia, i cui esiti sono ora pubblicati in un ricco volume collettaneo Visione scrittura. Attraversamenti e prospettive di ricerca per Gianni Celati, a cura di Isabella Pellegrini e Luca Stefanelli (Mimesis, 2025). I vari saggi del volume, tutti caratterizzati da un estremo rigore scientifico, affrontano aspetti diversi dell’opera di Celati: la narrativa e la saggistica degli anni ’70 (Giacomo Micheletti sulle verbigerazioni, Luca Stefanelli su Finzioni Occidentali, Prazzoli su Lunario), la collaborazione con Ghirri (Cecilia Monina); il silenzio nelle novelle degli anni ottanta (Enrico Testa), la satira nell’ultima produzione (Giulio Iacoli) e la scrittura di viaggio (Jean Talon). Il contributo sulle riscritture (1989, 1996) di Lunario (la prima edizione è del 1977) è firmato da un gruppo di alunni dell’Almo Collegio Borromeo (Avella et al.), tutti studenti di Lettere/Filologia dell’Università di Pavia, e inizia con una bella citazione in esergo tratta da Comiche (in Romanzi, comiche e racconti, Mondadori 2016, p. 69): “Così io sempre debbo ricominciare a scrivere ciò che ho già scritto e che è successo in un passato ormai scemo d’attualità e per giunta sovente nemmeno a me. Mischiati i casi miei con i casi di altri cioè”. Chi parla è il professor Otero Aloysio, protagonista del romanzo; ma l’urgenza di rivedere e riscrivere oltre che di contaminare il caso proprio con quello di altri, contaminazione che riguarda anche gli stili di scrittura e dei media, è una costante nella ricerca di Celati. Aloysio, o l’io narrante che si dice tale, è in questo una sorta di sua deformata e stralunata proiezione. L’analisi comparata delle diverse versioni, condotta con cura dai giovani ricercatori, prende in considerazione le interpolazioni strutturali (inserzioni e eliminazione di parti di testo, trapianti di blocchi testuali, riorganizzazione dei capitoli) e le revisioni stilistiche (attenuazione della mimesi dell’oralità, del turpiloquio, inserzione di forestierismi ecc.). Ciò che emerge è la necessità di Celati di “eseguire” sempre in modo diverso una narrazione, come se ci fosse una sorta di canovaccio o di spartito da mettere in parola e in voce ogni volta in modo diverso. L’idea che un libro non si dia una volta per tutte, come oggetto conservato dentro una bacheca e da venerare come una reliquia, è un cardine della poetica di Celati. La scrittura è come una esecuzione musicale: ogni esecuzione aggiunge e toglie qualcosa, è uguale e diversa. Lo stesso avviene nelle narrazioni orali, nel teatro, nelle riscritture che sono “un modo di prolungare lo stato di non fissazione che è nei flussi immaginativi”. E nelle riscritture, come nelle letture o nelle traduzioni, “non viene fuori niente di buono se non c’è quella contentezza, che è la stessa degli incontri con sconosciuti dove ci si scambia pensieri e fantasie, o la stessa degli incontri amorosi segreti e fluidi” (Conversazioni del vento volatore, Quodlibet 2011, p.110).
Quanto questa apertura all’incontro amoroso segreto, fluido (e contaminante) sia una marca della poetica di Celati lo si evince anche dalla lettura di due altri libri appena usciti, entrambi da Quodlibet, di Simone Giorgio e Giacomo Micheletti. Al centro dei due studi ci sono due amori letterari di Celati: Joyce e Céline, amori giovanili mai rinnegati, anzi oggetto di continue rivisitazioni e riscritture. Joyce fu oggetto della tesi di laurea, discussa nel 1965 all’Università di Bologna con Carlo Izzo e la supervisione del linguista Luigi Heilmann, mentre la traduzione dell’Ulisse è stata la sua ultima immensa fatica, uscita da Einaudi nel 2013. Di Céline Celati tradusse con Lino Gabellone Colloqui del professor Y e Il Ponte di Londra entrambi usciti nel 1971, quindi, da solo, Guignol’s band nel 1982, e infine nel 1996 curò Guignol's band 1.-2., sempre per Einaudi. I preziosi volumi di Giorgio (L’ascolto di una tradizione. Gianni Celati e l’Ulisse di Joyce) e di Micheletti (L’anarchia della ribellione permanente Gianni Celati e Lino Gabellone traduttori di Céline) scandagliano a fondo questi due rapporti che hanno prodotto traduzioni rilevanti, ma che sono stati anche determinanti nella definizione dello stesso stile di Celati scrittore: un’ulteriore dimostrazione che la sua ininterrotta attività di traduttore non può essere vista come un’attività marginale rispetto a quella di scrittore: le due esperienze si sono continuamente intrecciate e contaminate.
I libri, pur accomunati da un analogo studio di due relazioni privilegiate, muovono da prospettive critiche diverse e complementari: storico-critica quella di Giorgio, stilistica e linguistica quella di Micheletti.
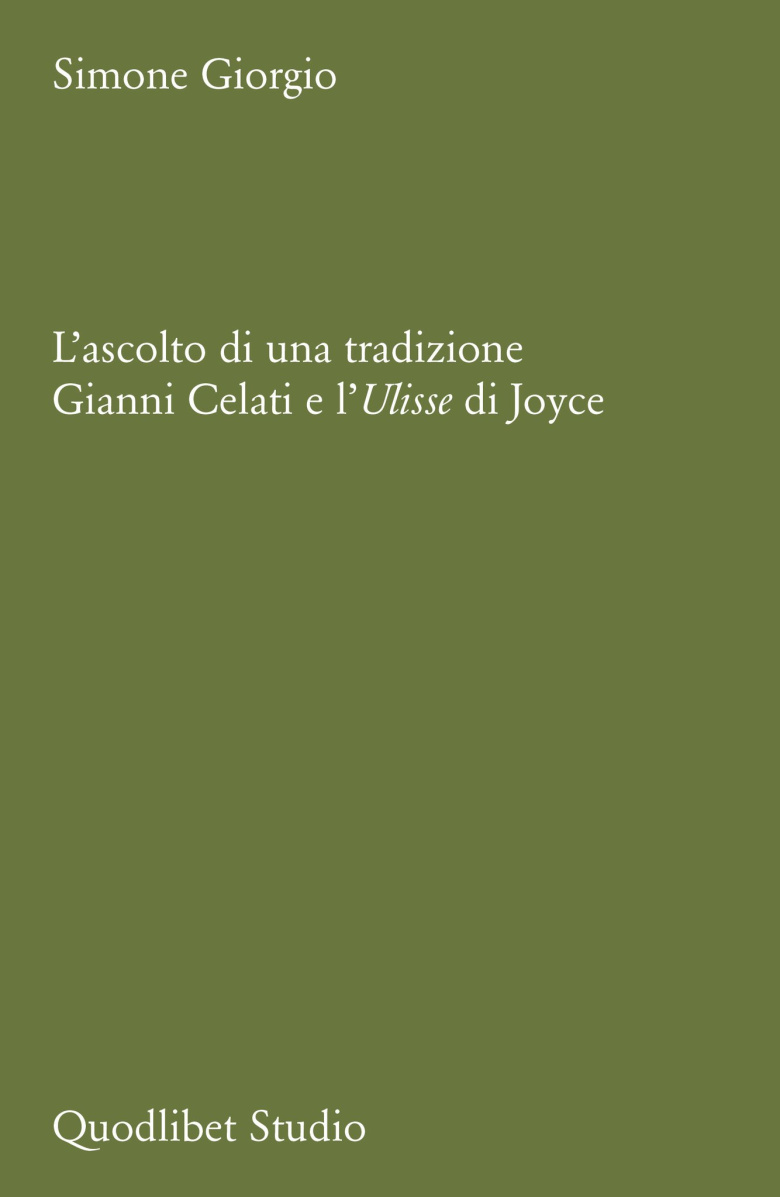
L’ascolto di una tradizione inizia con una ampia riflessione sulla categoria critica del modernismo e dei modernismi, sempre più al centro delle ricostruzioni storico letterarie anche in Italia, dopo che per decenni era stata utilizzata quasi esclusivamente per descrivere gli sviluppi novecenteschi delle letterature anglofone. Punto centrale e originale della trattazione di Giorgio è l’accostamento della poetica celatiana, e di altri scrittori come Sebastiano Vassalli, Luigi Malerba, Nanni Balestrini, a quella che Mark Fisher in Spettri della mia vita (2019) ha definito il modernismo popolare. Secondo Giorgio “questi autori tentano di colmare il divario tra scrittori e pubblico che negli anni in cui scrivevano era percepito come elemento fondamentale del modernismo, riutilizzando però, almeno in parte, tecniche tipiche di questa corrente” (pp. 14-15). L’opera celatiana assumerebbe così una “sorta di posizione anfibia” fra gli sperimentalismi elitari del modernismo e la cultura popolare. Lo iato fra scrittori modernisti e pubblico verrebbe in parte colmato attraverso il recupero di forme “oraleggianti” e una certa “interdisciplinarità, volta a seconda dei casi a incorporare nel testo elementi visuali o musicali” (p. 15). Anche per questo, due densi e documentati capitoli sono dedicati alla visualità comica e all’oralità parodizzante, e in entrambi i casi è decisiva la “lunga fedeltà di Celati a Joyce” (p. 39). Notevole è la pubblicazione in Appendice di tre passi della tesi di laurea sin qui inedita, che non solo stupiscono per l’acume dell’analisi e la padronanza del linguaggio dell’allora giovane critico, ma anche perché mostrano quanto certe linee di ricerca che Celati svilupperà in seguito (la satira swiftiana, Beckett, il cinema, il problema del montaggio narrativo, la regressione, il frammento, l’unità ritmica ecc.) fossero già presenti allora.
L’analisi della versione celatiana dell’Ulisse di Joyce non è, per scelta dichiarata, uno dei temi del libro di Giorgio, che peraltro dedica alla riflessione di Celati sul tradurre alcuni passaggi puntuali e significativi; Celati traduttore di Céline, è invece al centro della minuziosa indagine linguistica di Micheletti che, con gli strumenti affilati del lessicografo e del filologo, passa al microscopio le scelte lessicali e sintattiche traduttive del Ponte di Londra, cercando così di rendere un po’ più chiaro in che cosa è consistito quel gioco di prestigio con le parole che, a detta di Celati, era necessario per restituire in qualche modo la testura di una lingua altra e sorprendente.
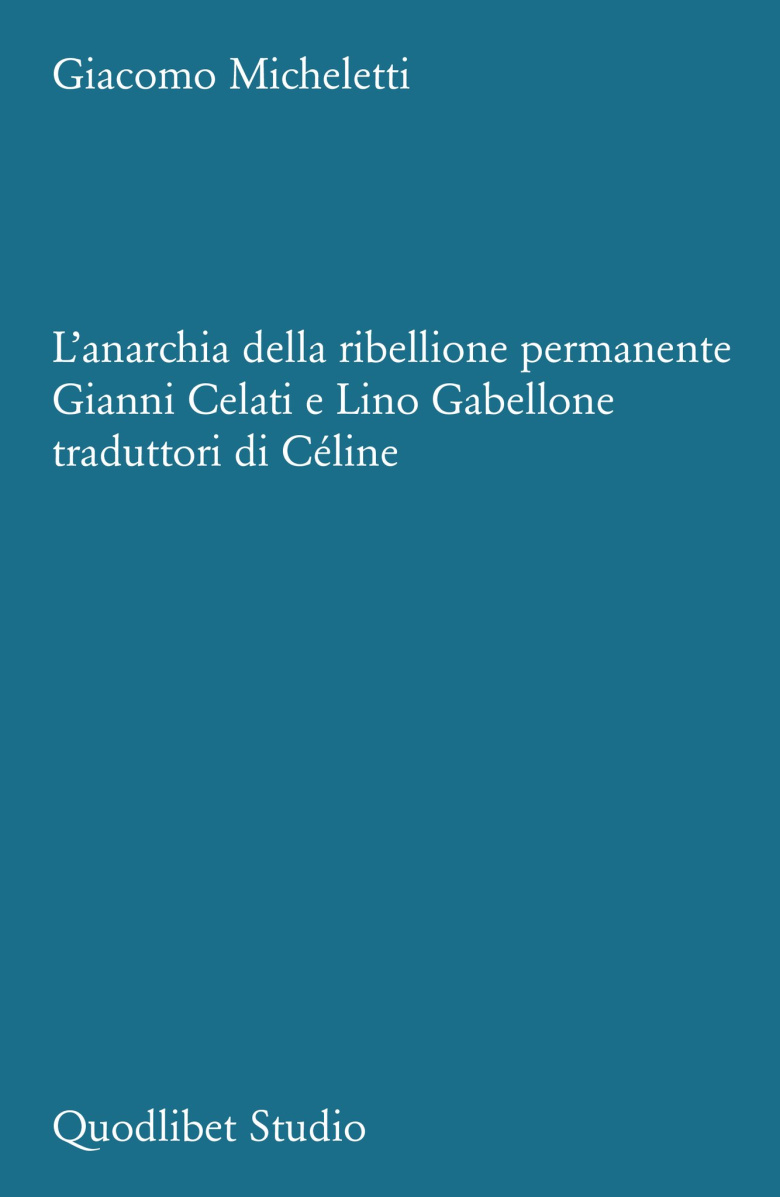
Scrive Micheletti che “le versioni céliniane di Celati e Gabellone costituiscono una sorta di ‘duplice pietra miliare’ nella storia della traduzione in lingua italiana; un’esperienza che, per la peculiarità dei problemi posti dalla lettera originale, problematizza e riformula lo stesso concetto di traduzione: ora, come nei Colloqui con il professor Y, in un sorta di riscrittura ‘all’improvviso’ condotta recitando ad alta voce, secondo le intuizioni e gli umori del momento, le battute del “canovaccio” di partenza; ora reinventando la familiarità straniante del vocabolario argotico-popolare di Il ponte dei Londra in una ‘stralingua’ mai esistita” (p. 9).
Capita spesso di incontrare in testi di critica su Celati affermazioni di questo tenore, ma poi il discorso rimane appeso a una enunciazione generica. Micheletti invece mostra in che cosa consiste concretamente questo gioco linguistico, creativo e dottissimo, condotto collettivamente e, immaginiamo, gioiosamente, da Celati e Gabellone. Il lettore può seguire in tre momenti incentrati sull’analisi della sintassi, del lessico, della morfologia e le figure di suono, la metamorfosi del complesso testo francese, caratterizzato da una forte componente argotica, in un italiano di nuovo conio eppure tradizionale, frutto di un pastiche colto e popolareggiante, che pesca, consapevolmente, lessico e espressioni idiomatiche da vari repertori che vanno dai gergalismi e regionalismi, alla commedia e novellistica della tradizione cinquecentesca, alla lingua furbesca, al linguaggio giovanilistico. Questo lavoro sul lessicale svolto da Celati e trasferito nelle scelte traduttive è documentato da Micheletti attraverso la creazione di quattro affascinanti glossari (parole gergali, regionalismi, lingua del comico dal rinascimento a Totò, giovanilismi) che testimoniano “lo scavo rabdomantico di Celati tra gli scarti e le rimozioni della storia linguistica” (p. 116), in un sorta di recupero archeologico di ciò che la lingua ufficiale ha messo al bando.
Quelli che si sono presentati, sono solo brevi assaggi di tre volumi molto ricchi che probabilmente avrebbero lusingato, incuriosito e fatto contento Celati, e che di sicuro confermano il buonissimo stato di salute degli studi su uno dei più originali intellettuali e pensatori, per nulla debole, del nostro tempo.