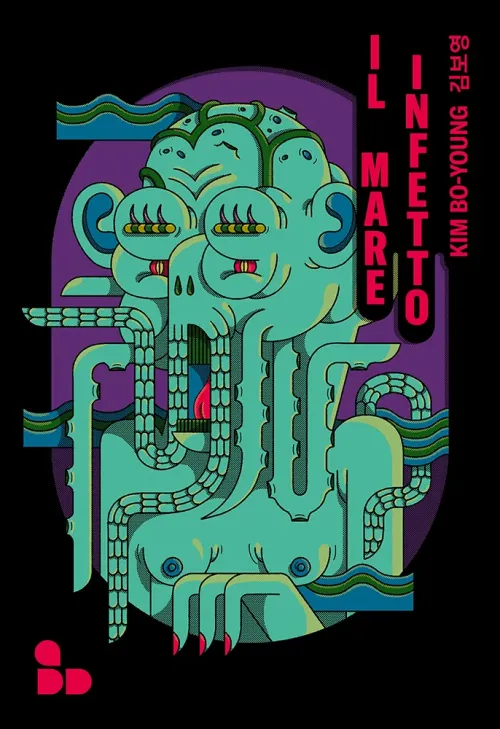Kim Bo-Young, Lovecraft in Corea
Mu Young, guardia del corpo per mestiere e zia affettuosa per vocazione, sta aspettando il treno per Haewon, un villaggio di mare isolato, dove intende passare del tempo in compagnia dell’amatissima nipote, Hyeon-i, che deve essere sottratta a una madre irresponsabile. Il treno arriva, e con esso anche l’avviso di un terremoto molto forte sulla costa orientale della Corea, in prossimità della destinazione delle due viaggiatrici. Mu Young, tuttavia, decide di partire ugualmente. Tre anni dopo, Haewon è diventato il luogo dell’apocalisse. Il terremoto ha liberato il virus di una patologia antichissima capace di trasformare le persone in mostri acquatici, Hyeon-i è morta, e il villaggio è intrappolato in un lockdown rigidissimo. Mu Young, ormai trasformata in una specie di guardiana dell’ordine pubblico, consuma il suo lutto in un luogo sempre più inabitabile.
Questa la storia declinata in Il mare infetto, di Kim Bo-Young, appena pubblicato da ADD editore e tradotta dal coreano da Giulia Donati. Seguendo una consuetudine antica, essa è incastonata in una cornice “testimoniale”. All’inizio e alla fine del romanzo, compaiono alcuni documenti epistolari. L’autore delle due lettere è un dottore in biochimica, che è anche “Presidente del comitato di difesa della specie umana dalla razza antica”, qualunque cosa questo significhi. Il destinatario, invece, è un “onorevole presidente” di cui non viene precisato il nome e che riceve il racconto dell’esperienza vissuta nel villaggio di Haewon, dove Hyen-i si sarebbe recato per ragioni di ricerca scientifica. Per chi conosce la tradizione antica dei scientific romances, questo incipit rimanda alla strategia usata, per esempio, da H.G. Wells in The Island of Dr Moreau (L’isola del dottor Moreau, 1896), dove una storia con analoghi toni orrorifici viene raccontata attraverso una testimonianza, quella di Edward Prendick, inserita nella cornice di un’altra testimonianza, quella di suo nipote Charles Edward Prendick. La “doppia garanzia” ha lo scopo di rendere credibile un universo narrativo che si allontana progressivamente da ogni verosimiglianza.
Tuttavia Wells non è uno dei modelli citati da Kim Bo-Young, che invece concepisce il romanzo come un omaggio esplicito a H.P. Lovecraft, e in particolare a The Shadow Over Innsmouth (1936). Autrice eclettica spesso ricordata per la sua collaborazione con Bong Joon-ho in Snowpiercer (2014). Vincitrice giovanissima del Korean Science & Technology Creative Writing Award e poi, per ben tre volte, del South Korean SF Novel Award, Kim Bo-Young ha inaugurato la vita professionale come game developer e graphic designer, per poi passare alla sceneggiatura e alla scrittura narrativa. Nonostante si dichiari poco consapevole della tradizione occidentale della fantascienza, la scrittrice è già presente in riviste come Clarkesworld (“An Evolutionary Myth” e “How Alike Are We”) e nel 2021, il suo On the Origin of the Species and Other Stories (pubblicato in Italia da ADD come L’origine della specie) è stato inserito nella long list dei National Book Awards. ADD pubblica anche Il mare infetto, candidandosi a essere l’editore che meglio rappresenta la letteratura coreana di questi anni. E Il mare infetto articola con congruenza il ragionamento inaugurato in L’evoluzione della specie: un topos ricorrente delle narrazioni fantascientifiche e weird occidentali viene rivisitato attraverso uno sguardo nuovo, che di occidentale non ha nulla, e sollevare questioni antiche, ovvero che cosa distingue gli umani e per quale motivo dovremmo considerarci “creature superiori”.
Questo snodo concettuale ha spesso preso sostanza in narrazioni edificate sul confronto tra l’umanità e mostri minacciosi di varia natura. Quando negli anni ’50, per esempio, Richard Matheson scrive I Am Legend (Io sono leggenda, 1954), si è ancora nel Golden Age della narrativa fantascientifica, e la diffusione di una impostazione più sociologica del genere nato maschio e cresciuto tecnologico deve ancora arrivare. E tuttavia, in questa parabola orrorifica che contempla sia una pandemia che una metamorfosi mostruosa degli umani sono presenti tracce di un’epoca complessa. Negli anni in cui inizia e finisce la guerra di Corea (1950-1953), mentre le truppe americane difendono, oltre ai loro interessi, l’indipendenza del sud del paese a fronte di una invasione da parte del nord, il senatore Joseph McCarthy inizia la sua guerra contro i comunisti (veri e presunti tali), millantando una invasione di pericolosissimi soggetti che vogliono, per così dire, “succhiare il sangue” al sistema capitalistico americano. Nel 1953 vengono giustiziati i coniugi Rosenberg, con l’apporto determinante di quel Roy Kohn che diventerà il consigliere principale del Trump politico. Nel 1954 esce appunto il romanzo di Matheson, nel quale un virus trasforma tutti gli esseri umani – tranne l’eroe, ovviamente – in spaventosi vampiri. E a proposito di presenze minacciose forse vanno aggiunte le cause legali intentate dal 1950 in avanti dal NAACP (National Association for the Advancement of Colored People): i neri diventano improvvisamente visibili, alieni pericolosi che vogliono rovesciare il sistema.
Alcuni anni dopo, la DC Comics’ Vertigo imprint pubblica il graphic novel Sweet Tooth (2003-2009), scritto e disegnato dal canadese Jeff Lemire. Siamo di nuovo in epoca post-apocalittica, dopo una pandemia collegata a una metamorfosi nell’umano. Stavolta, però, i buoni sono i “trasformati”, gli ibridi umano-animale che sono immuni al virus al quale gli umani soccombono. Gli anni di pubblicazione del graphic novel coincidono con il primo mandato di Barack Obama, ovvero col momento in cui chi era considerato addirittura non abbastanza umano da essere cittadino americano – gli eredi dei deportati dalla costa occidentale dell’Africa – addirittura diventa presidente. Di nuovo, è come dire: i buoni sono i non umani. L’avvincente, omonimo adattamento televisivo del graphic novel esce nel giugno del 2021, ovvero nella fase calante della pandemia, ovvero il momento in cui si è trattato di trovare un senso per quello che era accaduto e per come ci aveva cambiati, fisicamente e psicologicamente.
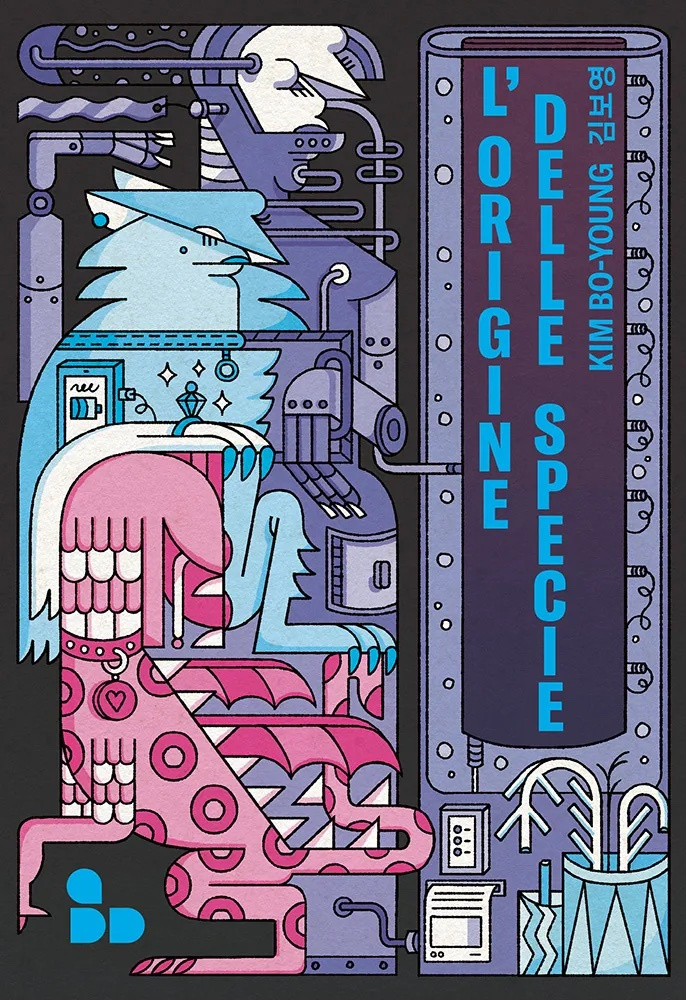
Non appare chiarissimo se un parallelo riscontro con il contesto storico abbia un peso nella scrittura di Il mare infetto. Il romanzo è stato pubblicato nel 2020, dunque non possono non esservi echi del COVID-19. Ci sono però due dati che relativizzano il peso di questa contingenza tragica. In primis, per ammissione condivisa, la Corea del sud ha gestito le prime fasi della pandemia in modo esemplare, tenendo a bada il contagio con una strategia che ha funzionato perfettamente. Peraltro, potrebbe essere questa la ragione per cui il presidente socialista del paese, pur non avendo mantenuto tutte le sue promesse elettorali, è stato rieletto nel 2020 per un secondo mandato, garantendo in questo modo la stabilità politica necessaria alla ricostruzione. La seconda questione da tenere a mente viene sottolineata dalla stessa Kim Bo-Young in una intervista pubblicata sul Korean Literature Now nell’autunno del 2021: l’autrice vive in una zona remota della campagna coreana, quasi senza abitazioni intorno, dunque la pandemia è stata per lei soprattutto un problema teorico più che una limitazione nella vita pratica. Nella medesima intervista, Kim Bo-Young suggerisce alcuni percorsi interpretativi sul suo romanzo. Il riferimento lovecraftiano di cui si diceva determina la volontà di scegliere una malattia capace di modificare l’aspetto del corpo, come la peste o la lebbra, ancor prima che esplodesse l’epidemia di COVID-19. Naturalmente non era possibile ignorarla, anche se appunto l’impatto sulla vita personale dell’autrice è stato molto ridotto. Molto più preoccupante appare a Kim Bo-Young il cambiamento climatico e il modo in cui esso rimodella l’ambiente e le specie che lo abitano. Le creature marine che prendono il posto degli umani non sono necessariamente presenze negative, sebbene mostruose. Alcune di esse riescono a essere amate, perché sono migliori di mariti distratti e litigiosi e sanno relazionarsi con l’ambiente meglio degli umani.
Alla fine dei conti, Il mare infetto è anche una storia sui molti modi in cui si manifesta l’amore. Una donna si innamora di un mostro che ha rimpiazzato il suo uomo e si dispera per la sua morte. Una zia affettuosa si espone a un rischio mortale per salvare sua nipote. Una specie generata da un terremoto cerca di riportare alla vita una bambina morta. Insomma, c’è una tessitura di affetti, insolita e priva di sbavature, in questa storia. Essa si intreccia col gioco sapiente con la mostruosità fisica, che risulta da un corpo instabile e in continua metamorfosi. Da una parte, l’acqua come luogo della metamorfosi richiama riferimenti molto diversi e ugualmente importanti. C’è Oceano rosso, l’opera monumentale di Song Han, con la sua visionaria invenzione di una stirpe acquatica, ma c’è anche River Solomon (The Deep), con la proposta di un riscatto immaginifico delle donne africane scaraventate in acqua dalle navi negriere e dei loro figli nati anfibi. Dall’altra, vi è questa tensione ricorrente nella letteratura coreana recente verso il riconoscimento della propria identità come connessa a un “corpo adeguato”, quello dei mostri di Haewon come quello dell’alieno metamorfico di Dolki Min (In forme): sono tutti “sweet monsters” che rivendicano il diritto di esistere.
Leggi anche:
I precedenti articoli di Nicoletta Vallorani
Niccolò Scaffai | Ecologia e fantascienza / Jeff Vandermeer e la misteriosa creatura di Borne
Adele Errico | Il mondo secondo Philip K. Dick
Alberto Mittone | Che cosa è reale? / I mondi di Philip K. Dick
Alberto Mittone | Lino Aldani, maestro di fantascienza