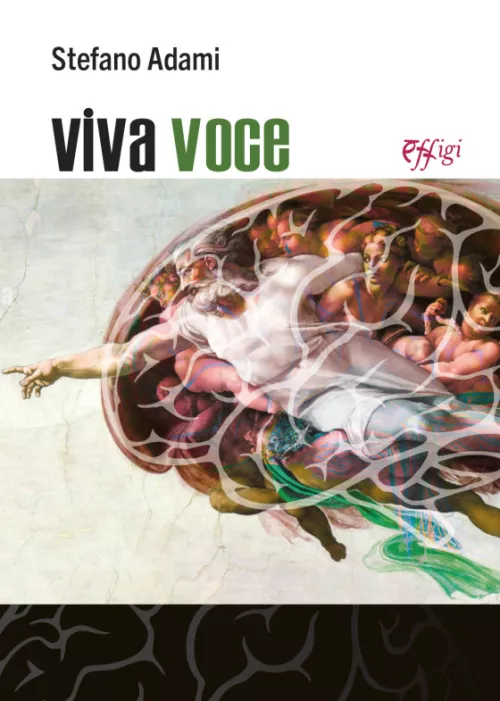Stefano Adami, un corpo a metà
Si parla tanto di corpo, di corporeità, del rapporto mente/corpo, dei problemi causati dal famoso dualismo cartesiano, ma cosa accade quando una sera, tornando a casa, una persona cade e non riesce più ad alzarsi fino al mattino seguente, quando comincia a rendersi conto che metà del suo corpo non c’è più, non nel senso che è sparito materialmente, ma nel senso che non risponde più ad alcuna sollecitazione? E cosa accade quando la mente fa fatica a capire cosa sta accadendo e si pensa ancora come se il corpo fosse tutto intero? Stefano Adami, giornalista e scrittore, ha avuto un ictus che gli ha fermato metà del suo corpo. Ne ha scritto sul libro, Viva voce, Effigi, Arcidosso (GR) 2024, che comincia così: “Salgo in casa, devo mettermi al computer a scrivere. Sono solo… All’improvviso mi succede una cosa inaspettata, non so proprio cosa pensare. Mi comincia a sbattere molto violentemente la clavicola sinistra, proprio sotto il mento, come se fosse un foglio di carta. Cosa mai vista… Fra un paio di mesi compio 50 anni. Non so cosa mi succede. Forse è un attacco d’asma, o di cuore. Mi alzo, voglio andare in bagno a sciacquarmi con acqua fredda. Magari così passerà tutto. Appena in piedi, sento una fortissima coltellata alla base della mia colonna vertebrale… Crollo a terra. La parte sinistra, chissà come, non funziona più. Faccio molti tentativi di rialzarmi, ma solo il braccio destro si punta a terra, fa leva, mi sostiene. Ma cosa diavolo m’è successo? Ogni volta che provo a rialzarmi, crollo duramente a terra, sbattendo il volto” (p. 7). È l’ictus. Comincia l’odissea di Stefano e il libro è la storia di questa odissea. Il suo stato d’animo, l’incontro con i medici e i terapisti, il modo come funzionano, soffrono e reagiscono sia il suo corpo dimezzato, sia la sua mente, il suo sapere e la sua cultura, il suo immaginario. Il libro è scritto con gli errori di chi è colpito dall’ictus e dunque rivela la straordinaria forza di volontà di Stefano. Ma prima di arrivare a questo ha dovuto passare l’inferno delle incomprensioni della medicina e della riabilitazione fino a quando, su mio suggerimento, non ha incontrato i terapisti della scuola di Carlo Perfetti, con il quale avevo interagito (e continuo a farlo con i suoi ex allievi) in un apparentemente strano ma bellissimo rapporto tra filosofia e riabilitazione neurocognitiva.
Stefano, che ha voluto mantenere tutti gli errori causati dalla sua difficoltà e dal suo sforzo di scrivere in condizioni molto difficili, racconta, dal punto di vista del paziente, anche le relazioni (e le incomprensioni) che si sono create tra lui e i terapisti, i medici, gli psicologi con i loro protocolli. Ecco come uno psicologo si rivolge al paziente: “ ‘Lei Adami, deve avere delle motivazioni, capisce’, continuava spiegandomi con molta gentilezza lo psicologo. ‘Deve porsi degli obiettivi’, scandiva. ‘Lei si deve impegnare. Non deve pensare di passare il tempo che le resta parcheggiato su questa carrozzina a fissare il nulla. Deve mettere in campo le sue abilità residue’. Tempo che mi resta? – pensa Stefano – Abilità residue? Ma di cosa mi sta parlando questo qui? Il tempo che mi resta, dato come sono messo, spero che sia il meno possibile. Le abilità residue, manco le vedo” (p. 23). Ogni volta vi è la distanza e l’assenza di empatia tra lo stato d’animo del paziente e il protocollo condito con un buon senso conformista dello psicologo. È la distanza teorizzata, praticata e deformata del cosiddetto sapere scientifico. Il punto di vista dell’altro, un altro più debole, non conta. Viene così trasformata, per dirla con Michel Foucault, una relazione di potere in uno stato di dominio. In una relazione di potere tra terapista e paziente il lavoro consiste nel far sì che il paziente, con l’aiuto del terapista (con il quale ha costruito un mondo intermedio), diventi sempre più autonomo trasformando la relazione stessa. Se ciò non accade allora ci troviamo in uno stato di dominio, in uno stato cioè in cui la relazione di potere si cristallizza e non si modifica. Un passaggio importante è il punto di vista del paziente sia come persona sia come colui che ha un’immagine di sé con cui deve confrontarsi. È quel che ci narra Stefano: “Il Cerebello tendeva a dirmi e a confermarmi che non mi era successo nulla” (p. 20). E invece Stefano si trovava a riproporsi le classiche domande filosofiche, ma a partire dalle sue condizioni, con mezzo corpo inerte: “Cosa indichiamo quando diciamo io? Il nostro cervello? Il corpo? Le sensazioni? Le emozioni? La nostra storia personale, la memoria? O forse un possente impasto di tutto questo? E cosa succede quando l’impasto viene violentemente lacerato? Se si danneggia profondamente un tessuto, come quello cerebrale, cosa succede all’anima? E cosa al corpo? Si può ricostruire l’unità? Come? In quanto tempo?” (p. 17). Si può ricostruire l’unità con un corpo dimezzato? La risposta è sì, come dimostra il libro stesso di Stefano, ma nella tragica consapevolezza che non si torna indietro, ma si guarda in avanti a partire dalle condizioni dopo il trauma. Stefano Adami sa benissimo questo, ma sa anche come il suo sapere interagisca con la sua condizione, aiutandolo a mantenere la sua unità. È così che Thomas Mann ed Eraclito entrano in gioco nel rapporto che Stefano istituisce tra immaginario, sapere e realtà. L’insieme di queste istanze è ciò che lo rende uno, salvando la sua integrità nonostante la lesione.
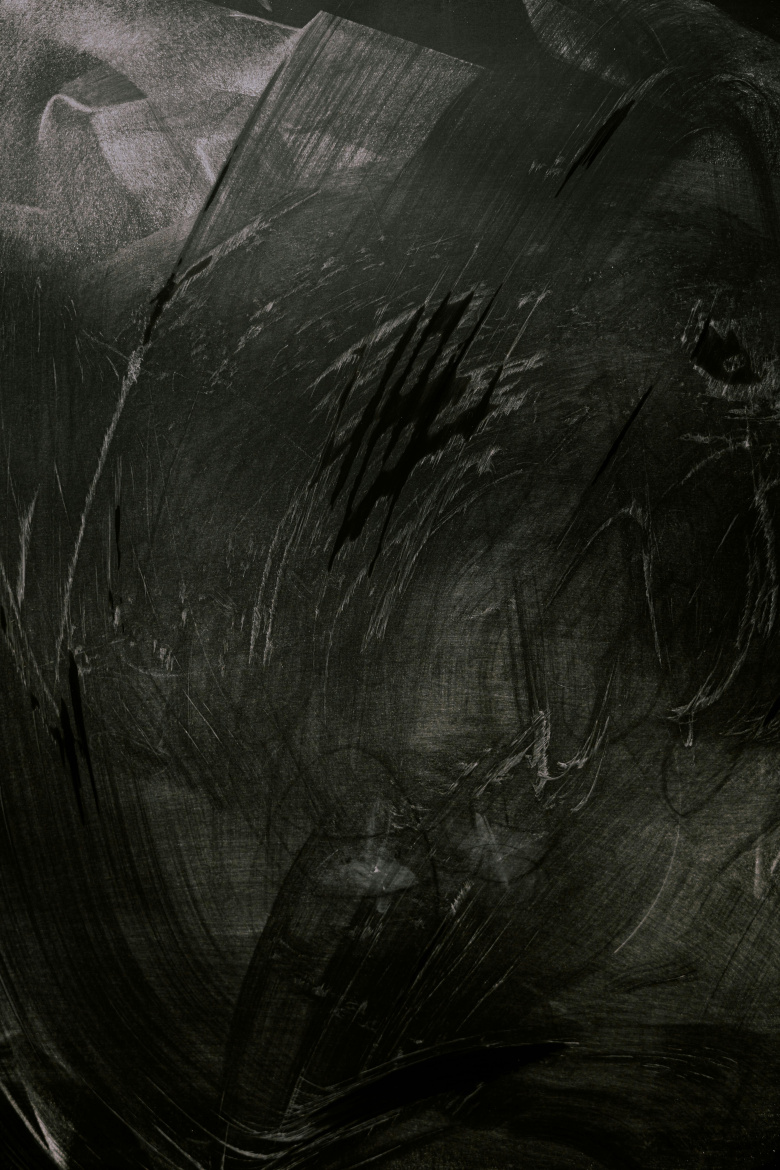
In Uno, nessuno, centomila, Vitangelo Mostarda si guarda allo specchio e vede una cosa di cui non si era mai accorto. Il suo naso era storto. Chiede a sua moglie, la quale gli conferma che il naso era sempre stato storto. Lo specchio gli comunica un’alterità di sé che l’altra, la moglie, gli conferma. Da qui il gioco tra uno, nessuno, centomila. Cosa comunica lo specchio a Stefano Adami? “Vado davanti allo specchio e guardo la mia parte sinistra. Quella parte sinistra. Guardo bene. È e non è la mia parte sinistra. La spalla, la sinistra, sembra molto più bassa dell’altra. Il braccio sembra un punto interrogativo all’incontrario. Pesa tantissimo. Sembra d’acciaio. La mano è serrata come una trappola per topi. Guardo giù. La gamba? Paralizzata. Il piede? Idem. Almeno sono intonati col resto” (p. 37). Qui l’altro da sé non è il volto, ma il corpo che per riappropriarsi di sé, per tornare a viversi, direbbe Merleau-Ponty, come corpo proprio deve accettare la sua alterità causata dal trauma. “Almeno sono intonati col resto”. Stefano trova un’armonia nel corpo disastrato. Ma questo fa parte dell’autoriflessione di Stefano, ma non entra nella relazione tra paziente e terapista, sì, perché questa relazione, secondo la nostra cultura, deve avere a che fare con la verità, di fronte alla quale la stessa relazione perde d’importanza. “Faccia il suo lavoro, Adami, – dice la dottoressa – io non le parlo di filosofia. Le conclusioni le traggo io grazie. Magari mi parlasse di filosofia – pensa Stefano – male non le fa… Lasci perdere Adami – incalza la dottoressa –. Lei vuole sapere perché è qui? È semplice. (Scandisce). Non perché noi siamo cattivi. Ma perché lei ha avuto un ictus. Lo sa cosa è un ictus vero signor Adami? Lo so, certo che lo so. L’ho avuto… Quindi, riprende lei, sa anche che non tornerà più, mai più, come prima… Gode. Lo vedo. E poi, riprende, sig. Adami, quella vita di prima era veramente felice? Mi stavo cominciando a innervosire. Sto Sherlock Holmes in gonnella sta camminando avanti e indietro sul mio scroto e con le scarpe attrezzate. Va bene, ho capito, cazzo – sbotto – toglietemi anche la felicità di prima, toglietemi l’amore, cazzo, toglietemi il calore, così divento proprio come lei…, anche se non ci tengo. Contenta?” (p. 92). La verità! La verità! Il sadismo della dottoressa si accompagna al tentativo da parte della dottoressa di trasformare la relazione di potere in uno stato di dominio sul paziente e tutto in nome della verità. Il paradigma della conoscenza basata sul primato del rapporto soggetto-oggetto – e qui l’oggetto è il paziente che deve subire la verità della terapista – fa sì che il paziente sia appunto un oggetto e non un altro soggetto. La relazione terapista-paziente si cristallizza in un dominio che ha tutta l’aria apparentemente neutrale della verità che si dice al paziente. Costui non è una persona che pensa, soffre, immagina, sogna, di cui ci si preoccupa (la cura), ma un oggetto che in quanto tale deve ricevere la consapevolezza del suo stato. Ma Stefano aiutato da chi concepisce la terapia come una relazione che costruisce mondi intermedi è riuscito a trovare da sé, in modo autonomo, la sua verità e la sua unità nonostante il trauma, nonostante spesso si sentiva come un paguro, “dentro un guscio non suo. Un guscio spesso rigido dove il mio di prima era morbido flessibile – o fragile laddove ero abituato alla sua resistenza” (p. 114). E così, parafrasando il Kant di Che cos’è l’illuminismo?, egli è riuscito a uscire dalla condizione di minorità e a usare il proprio corpo, che non è più quello di prima, senza la guida di un altro, di cui pure, come tutti, ha avuto bisogno.