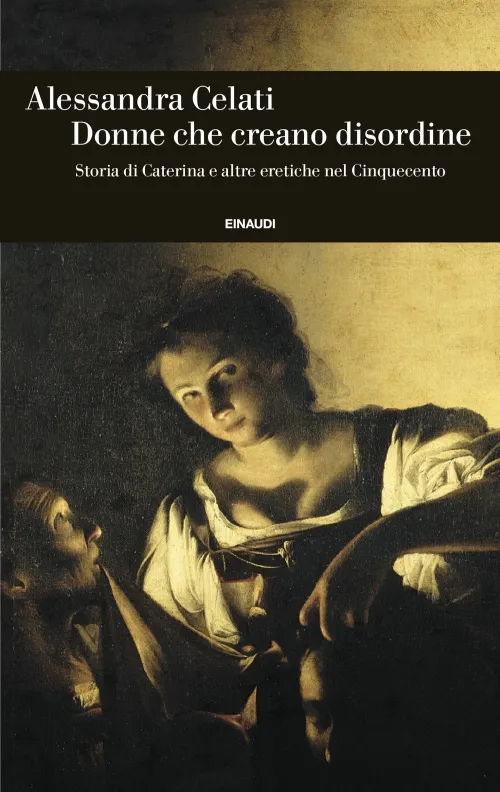L'alternativa eretica delle donne
Mentre leggevo il libro della storica Alessandra Celati, Donne che creano disordine, storia di Caterina e altre eretiche del Cinquecento, uscito a giugno per Einaudi editore, mi tornavano in mente i versi di Emily Dickinson: Tornare ai miei libri –/ Un piacere – alla fine di stanche Giornate –/ Rende quasi cara l’Astinenza –/E il Dolore – dimenticato – si fa Lode –.
In quest’epoca in cui l’approssimazione regna sovrana e l’informazione è instagrammata e instagrammabile, in cui la complessità del sapere viene ridotta a slide in favore della semplificazione dei contenuti e della loro divulgazione, il libro di Celati mi è sembrato una boccata di aria fresca, pieno di quel rigore storico che si avvale delle fonti e le analizza senza preconcetti, restituendoci le diverse sfumature della realtà stratificata e complessa.
Il libro analizza la diffusione dell’eterodossia tra le donne nella Venezia della seconda metà del Cinquecento, a seguito della Riforma luterana prima e del Concilio di Trento poi, e lo fa analizzando le carte processuali dell’Inquisizione e i documenti d’archivio, ricostruendo la microstoria – cara ad autori del calibro di Carlo Ginzburg – di alcune personalità femminili che, a diverso titolo, facevano parte di una diffusa rete ereticale in quegli anni.
Quando si studia la storia moderna, infatti, nella cosiddetta macrostoria l’Italia sembra quasi essere passata indenne dalla Riforma luterana, nonostante il Concilio di Trento e la successiva Controriforma che portò a una nuova idea del cattolicesimo e all’inasprirsi della stretta del tribunale dell’Inquisizione, mentre il libro di Celati ci fornisce un aspetto inedito e interessante non solo sulla diffusione dell’eterodossia in quegli anni nel nostro Paese, almeno in alcune zone privilegiate per gli scambi, commerciali e intellettuali, come Venezia, ma anche su quanto l’adesione a una nuova visione religiosa abbia condotto, consapevolmente o meno, molte donne a uscire dagli schemi della rigida società patriarcale dell’epoca.
Nella ricca introduzione Celati espone le sue basi metodologiche – far dialogare la storia religiosa con quella sociale, e la storia con la storia di genere – i documenti utilizzati e lo scopo della sua ricerca, che è individuare l’impatto della Riforma sulle donne, tracciando un percorso di ribellione e entropia femminile a partire da figure dimenticate dalla macrostoria. Si analizzano così le vite di donne (ma anche uomini) qualunque che, spesso senza saperlo, hanno contribuito con le loro scelte individuali a tracciare sentieri nuovi, più liberi e in questo modo hanno contribuito a cambiare la narrazione della Storia in generale.
Non una Storia fatta di regine, cortigiane o pulzelle d’Orleans, ma di umili serve, prostitute, suore, donne borghesi, alcune dottissime e avide lettrici, altre analfabete, alcune esse stesse eretiche e per questo accusate dal Sant’Uffizio, altre accusatrici di mariti riformisti, alcune salve grazie all’abiura, altre che hanno pagato con la vita la loro coerenza, ma tutte, indistintamente, intelligenti artefici del proprio destino.
Con una penna leggera ma puntuale, che traccia brevi ritratti di queste donne attraverso l’immaginazione ma senza mai perdere di vista il rigore della ricostruzione storica, Alessandra Celati mappa così la rete ereticale presente a Venezia e nel suo contado, sovrapponendo storie e legami, mettendosi sulle orme delle sue protagoniste e restituendo loro una voce e un posto nella Storia e nel suo cambiamento. Sfilano tra le pagine Caterina Cobertalda, ignorante ma determinata, i coniugi Lucrezia e Vincenzo Maggi, uniti nella fede eterodossa, la figura indomita di Aurora Clario, la prostituta Lunarda, la coltissima Viriginia Panarelli, prima sodale e poi tradita da suo fratello Teofilo, a sua volta eretico, e moltissime altre, le cui esistenze individuali si intrecciano e si allontanano aprendo sentieri per una nuova comprensione storica. Le loro vicende, fatte di viaggi, prigionie – spesso insieme ai propri figli – in carceri malsane, processi, accuse, condanne e abiure pubbliche, sono appassionanti e sconvolgenti a un tempo, e travolgono il lettore, avvincendolo, ma il dato più interessante è la riflessione storico-sociale che Celati desume da queste esistenze.
Va sottolineato, come primo aspetto, il contesto storico in cui ci troviamo: un contesto patriarcale, in cui le donne vivevano in dinamiche di disuguaglianza, dominio e sottomissione, sia nell’ambito sociale che religioso e in cui persino le fonti utilizzate vanno vagliate e soppesate alla luce del fatto che Celati ha utilizzato le carte processuali dell’epoca “frammenti di storie, raccontate a maschi, estorte da maschi e analizzate con lenti maschili”, inducendo l’autrice a verificare ipotesi e congetture “di volta in volta, attraverso una lettura tra le righe che vagliasse il peso delle ammissioni come delle omissioni; e grazie al dialogo con la storia sociale, famigliare, delle donne e di genere e all’attenzione costante verso la specificità di personaggi, contesti e ruoli”. Aspetto particolarmente interessante è il ribaltamento di uno stereotipo di genere da parte delle donne: in età moderna la donna era infatti comunemente considerata minus habens, ovvero incapace di sviluppare un pensiero autonomo e dunque eversivo.
Celati sottolinea come praticamente tutte le donne a processo per eresia, dalle illetterate alle più colte, abbiano utilizzato lo stereotipo della loro incapacità cognitiva per proclamare la propria innocenza davanti al tribunale ecclesiastico: come poteva infatti una donna ignorante, per sua natura inabile a sviluppare un pensiero personale, aderire al movimento riformista o, in certi casi, farsene addirittura promotrice? Le donne si occupavano infatti solo “di cose da donne” e dunque la cura dei figli e la gestione domestica. Le accusate misero in atto una forma di riappropriazione semantica della loro presunta inferiorità mentale e la maggior parte delle volte questa astuta difesa funzionò, tanto che il bias dei giudici nei confronti dell’intelligenza femminile portò a numerosi decadimenti processuali e assoluzioni, quando le donne non decisero di abiurare. Un esempio su tutti, quello di Angelica Spadaro, moglie di Zuan Giacomo (entrambi anabattisti), che fu rinchiusa, insieme alla figlia Maddalena di soli quattro anni, in un carcere “luogo di punizione e di dolore, pensato da maschi per maschi”, dove entrambe si ammalarono gravemente. Al processo, Angelica “ricorse a tutti i trucchi che la sua condizione femminile le offriva per provare a sottrarsi ai suoi accusatori. Dichiarò subito di avere «poca memoria e cattiva gravidanza», dalla quale veniva «tanto fastidio che ora vi dirò una cosa e poco da poi un’altra»”. Come Angelica, resistettero strenuamente agli interrogatori donne come Paola Zavattier e Isabetta d’Alessadria, che difesero il proprio nucleo famigliare e la propria rete ereticale: di fronte alle minacce dei giudici di estorcere una confessione con la forza, emergono chiare ad esempio la dignità e la tempra morale di Isabetta che dichiarò: «Fé ciò che vi piace, son qua».

Un altro elemento interessante per la storia di genere emerge quando Celati analizza la rete di relazioni in cui le donne dell’epoca erano immerse: se è vero che normalmente le donne vivevano più che altro in un hortus conclusus, in cui si viveva la dicotomia “aut maritus aut murus” (come raccontato, ricorda Celati, dalla studiosa cinquecentesca Arcangela Tarabotti nel suo volume L’inferno monacale, Edizioni di storia e letteratura, 2025), e dunque la loro vita era relegata o alla vita domestica o in quella monacale, pure le donne delle classi meno elevate, dovendo sbrigare commissioni in città, riuscivano a vivere gli spazi pubblici e a tessere importanti reti relazionali che probabilmente facilitarono l’accesso a teorie anabattiste o riformiste.
La Riforma, inoltre, per chi vi aderì, favorì anche alcuni cambiamenti all’interno delle dinamiche matrimoniali: in alcuni casi le donne la utilizzarono per denunciare come eretico un coniuge violento, in modo da liberarsene in tempi in cui non esisteva il divorzio, ma in altri contesti la Riforma sembrò quasi tracciare un sentiero per una maggiore parità all’interno della coppia, se pure appena accennata. Se infatti alcune donne, come la fiera Aquilina, lottarono per i propri diritti, abbandonando il tetto coniugale di un marito eretico, fedifrago e violento e riuscirono ad ottenere persino il riconoscimento di un vitalizio in un’epoca in cui le donne non disponevano né della propria dote né delle proprietà ereditate, che restavano appannaggio del marito, e venivano spesso picchiate perché esisteva la consuetudine (in voga in Italia fino all’abrogazione dello ius corrigendi, nel 1956) di picchiare la propria moglie per “educarla”, pure le coppie che condividevano una visione eterodossa svilupparono una consuetudine matrimoniale volta a una più ampia orizzontalità. “Le coppie eterodosse italiane” scrive Celati, “anche in virtù della condizione di segretezza, clandestinità e persecuzione che si trovarono a condividere, trassero spesso affiatamento nella comune fede religiosa”. La Riforma inoltre lasciava spazi maggiori al concubinaggio, e se pure Celati sottolinea come la sessualità in età moderna non fosse così strettamente sorvegliata e non erano rari i casi di esperienze sessuali prima del matrimonio, il concilio di Trento pose una stretta molto forte sulla libertà sessuale, con un’attenzione particolare verso le esperienze more uxorio: “Con un gioco di squadra tra Inquisizione e vescovi, a partire dal 1563 la Chiesa si dedicò a «riordinare la sessualità», distruggendo famiglie e processando «teorici» degli amori proibiti, con un accanimento che non si ebbe ad esempio nel caso dell’usura. I concubini dovevano essere stanati dai vescovi, ma per coloro che incapparono nelle maglie del Sant’Uffizio per reati di natura religiosa, il comportamento more uxorio divenne un’aggravante”. Il diritto canonico fino ad allora aveva ammesso le convivenze de facto in base a un principio di consensualità, ma a seguito del decreto tridentino Tametsi del 1563, la Chiesa avviò una stretta sulla regolamentazione della vita matrimoniale e, conseguentemente, sul controllo dei corpi di entrambi i generi.
Altro aspetto peculiare è il ricorrente uso dei libri e della lettura per avvicinarsi al movimento ereticale: la Riforma, che favoriva la lettura diretta e dunque anche la libera interpretazione dei testi sacri, portò sia gli uomini che le donne che vi aderirono all’alfabetizzazione, e dove i soggetti coinvolti non impararono a leggere, pure il contenuto dei libri veniva esposto loro tramite letture ad alta voce e l’intelligenza stimolata dal dibattito critico e teologico. Quando questo dato emerse all’interno dei processi, contribuì alla demonizzazione della lettura, considerata premessa fondamentale della devianza religiosa, allontanando l’Italia da un processo di alfabetizzazione collettiva che invece si verificò nei paesi in cui la Riforma protestante prese piede. Anche le donne erano coinvolte nella lettura e nei dibattiti teologici, e spesso affinarono il proprio intelletto leggendo e disputando “come uomini” in barba alla consuetudine, filosofica e religiosa, che continuava a considerarle minus habentes.
Inoltre “L’avvicinamento al discorso riformistico, la lettura dei testi proibiti, la divulgazione di idee ereticali e la pratica di comportamenti eterodossi, soprattutto laddove praticati in autonomia, costituivano agli occhi degli uomini del tempo un’evidente prova della superbia e irrazionalità femminile, mentre, per queste donne, rappresentarono una possibilità, se pur rischiosa e spesso effimera, di autodeterminazione”.
Il quadro che emerge da questo saggio è dunque ricco e sfaccettato, fatto di contraddizioni e conferme di un certo assetto culturale, ma si pone l’obiettivo, peculiarmente microstorico, di individuare le sfumature di cui era costituita la società moderna, sottolineandone diversità e complessità.
Le storie delle donne raccontate da Alessandra Celati non sono il frutto dell’immaginazione romanzesca di un’autrice che tenta di gettare luce sulla condizione di un’intera categoria sociale – quella femminile – di fatto spesso tagliata fuori dalla Storia, ma costituiscono un lavoro prezioso che ripercorre le storie processuali di moltissime donne, che si manifestarono nella storia e di cui ci rimane traccia proprio perché provarono a uscire dai “recinti” che la società aveva eretto per controllarle, e che con i loro comportamenti e la loro personalità svilupparono una forma entropica di disordine sociale che le portò all’attenzione delle autorità, lasciando una traccia documentale che oggi ci permette di ricostruire un intero quadro sociale. Queste donne, abbracciando la cultura ereticale, rispondevano a un bisogno di affermazione personale, tanto più forte quanto più alto era, per le donne, il prezzo da pagare per essersi allontanate dall’ortodossia, sia religiosa che sociale, ma hanno contribuito a mostrare, già in età moderna, il desiderio di un cambiamento possibile, di un’autonomia individuale e di genere, un modo nuovo di porsi fuori dal recinto che la cultura patriarcale aveva costruito per loro, rovesciando la gerarchia dei sessi.
Scrive Celati nell’introduzione: “Se, fin da piccole, le fanciulle erano allevate nella convinzione che fosse loro dovere obbedire e assumere la subordinazione come un destino, le donne protagoniste di questo libro incepparono, anche se non necessariamente in modo intenzionale, la macchina della soggezione. Disconoscendo le autorità religiose e talvolta famigliari a cui erano sottoposte, mettendo in atto condotte religiose e talvolta morali inadeguate al loro genere essere realizzarono forme più o meno consapevoli di ribellione e crearono disordine”.
Dall’età della Controriforma sono passati più di cinquecento anni, molto è cambiato e tanto si è ottenuto, ma ancora le lotte per la parità di genere non si arrestano, segno che la tanto agognata uguaglianza sociale ancora non è stata completamente raggiunta, e lunga, sebbene meno accidentata, sembra essere la strada. Saggi come questo sono dunque preziosi per riscoprire l’eredità delle donne che ci hanno preceduto, dissipare dubbi sul contesto dal quale provengono le disuguaglianze di genere e indurci a seguire l’insegnamento della Storia, inserendoci in quel selciato di ribellioni individuali che da sempre ha contribuito a creare, sassolino dopo sassolino, un sentiero nuovo, imbattuto, che dal disordine rompa le regole e aiuti a costituire un ordine sociale nuovo, più giusto e finalmente egualitario.