Sulle alture / Federico Falco, Silvi e la notte oscura
Ha senz’altro ragione Lucas, un parente argentino del signor Palomar, quando, dopo avere rilevato il “ritorno sfrenato e turistico alla Natura”, manifesta tutta la sua diffidenza verso l’atteggiamento diffuso di chi guarda “alla vita di campagna come Rousseau guardava al buon selvaggio”. Lucas, nato negli anni ‘70 dalla fantasia di Julio Cortázar, sempre teso verso la riflessione sul rapporto tra realtà circostante e la sua comprensione filosofica e scientifica, è infastidito dalla nouvelle vague del naturismo da weekend promossa da gente che saltella con lo zaino in spalla e la barba lunghissima. Non tarda dunque a schierarsi a favore di ciò che, ottenuto dall’uomo con i mezzi della tecnica, reca sollazzo: sceglie uno scotch on the rocks, per esempio, come antidoto contro i suddetti amatori occasionali del diporto agreste, i beoni in braghe corte convinti che fuori dalle mura cittadine tutto possa rientrare in un progetto esistenziale di promozione armonica dello sviluppo fisico e culturale, dai wafer ai solstizi.
In Silvi e la notte oscura, pubblicato da SUR nella bella traduzione di Maria Nicola, l’elemento naturale ha sì un ruolo importante ma non vi è traccia dell’ottimismo esclamativo dei contemplatori seriali che nei panorami suggestivi vedono il miracolo della bontà cosmica. Tantomeno è rintracciabile, nel libro, l’oramai frusta contrapposizione tra lo squallore maligno della vita metropolitana e la presunta generosità disinteressata del tran tran rustico. Tutto il contrario. Pur essendo ventilati come le pinete quando preannunciano qualche corso d’acqua nelle vicinanze, i cinque racconti che compongono il libro non indulgono alla richiesta di chi desidera riprendere fiato dalla miseria umana con una bella invettiva prêt-à-porter contro la terra desolata della modernità.
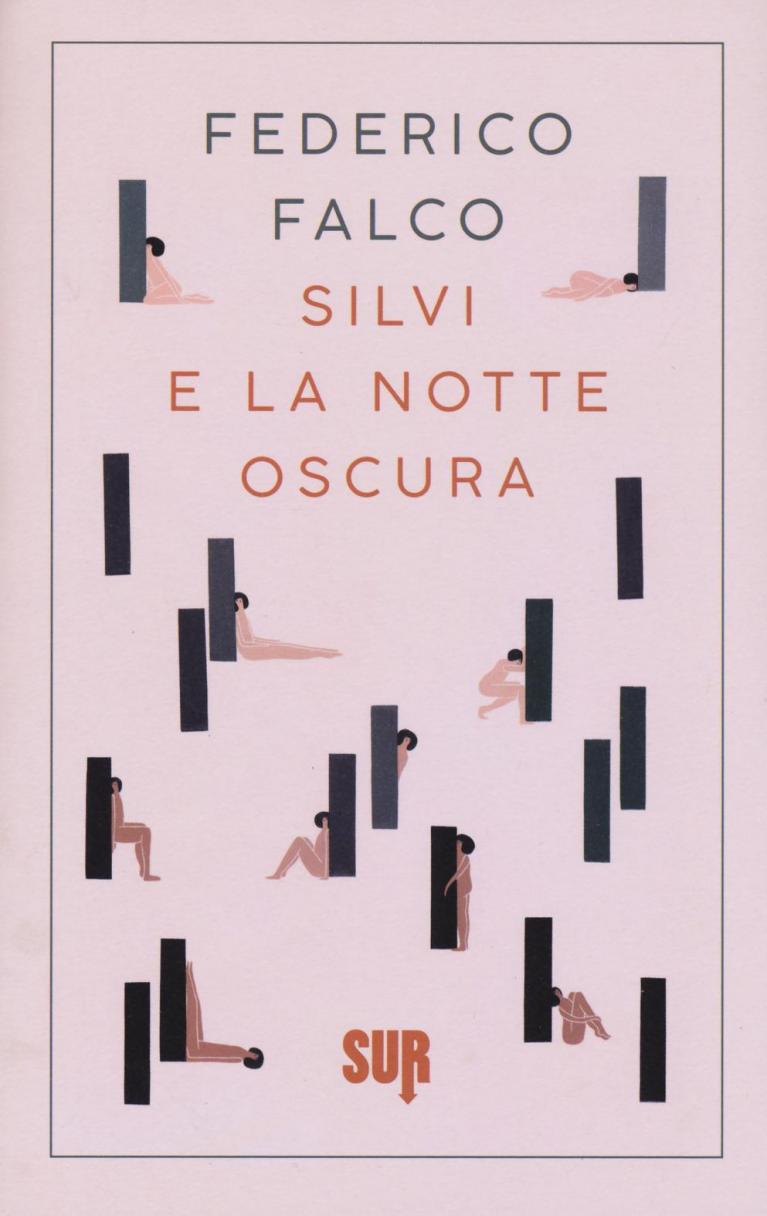
Senza essere integralmente emarginati, i personaggi che popolano il libro vivono una condizione marginale, per motivi diversi, ma tutti riconducibili alla perdita e alle sue varie e a volte segrete declinazioni, come il re delle lepri, il primo a spuntare dalle alture del libro, il cui riserbo è tale da rendere difficile, di primo acchito, la sua collocazione nella specie umana, almeno fino a quando non imbraccia il fucile per abbattere una volpe colta a frugare tra i cespugli. La ragione del confinamento di questo individuo rimane ignota, il racconto indugia nella rappresentazione meticolosa ma non pedante del contesto naturale omettendo informazioni biografiche che possano giustificare la radicalità della scelta del personaggio. In questo modo Federico Falco, sorprendentemente accorto e saggio, mette in chiaro fin dal principio una cosa: come non vi è, in questo ciclo di racconti, l’idealizzazione dell’elemento naturale, è altresì assente la fascinazione verso il dropout che ha rifiutato il giogo dalla vita sociale organizzata a favore di presunte relazioni “più vere”, “autentiche”: il re delle lepri ha instaurato nel bosco una specie di monarchia teocratica tollerata dai leprotti della radura presumibilmente solo a causa della loro rinomata condizione di inferiorità, si potrebbe dire, militare. Se si dovesse stabilire una linea di discendenza, l’antenato più prossimo al re delle lepri sarebbe dunque il maliardo Kurtz il cui delirio di onnipotenza pervade le pagine di Heart of Darkness, piuttosto che gli eroici reietti di Poker Flat (Francis Bret Harte, The Outcasts of Poker Flat, 1868), espulsi dalla spietata organizzazione sociale americana dei tempi della Gold Rush, variazioni della tipizzazione letteraria del ripudiato sconfitto dal cuore d’oro.
L’incanto di tutti e cinque i racconti risiede nella capacità di rendere conto della tacita accettazione, mai espressa a parole, di vite scarne, disadorne, in cui le interazioni coi propri simili sono eventi rari, quasi anomali, e le frasi che si scambiano i personaggi così misurate da sembrare uscite da un contagocce.
Gli incontri, anche quelli amorosi, sono sempre provvisori. I dialoghi riecheggiano nelle pagine successive, come se prendere le debite distanze da qualcuno in realtà fosse il modo migliore per ridurle, tanto con i mormoni (“Silvi e la notte oscura”) e i giapponesi (“La vita dei boschi”), quanto con i locali malfidenti (“Un cimitero perfetto”), i fantasmi (“Il fiume”) e, in generale, con chi è stanco degli equivoci.
Il tipo di solitudine rappresentata non ha a che fare né con lo smarrimento nell’elemento naturale perturbante, motore delle trame che muovono dalla paura dell’incontro sovrannaturale, né, all’opposto, con l’estraneità di chi, all’interno di un gruppo sociale, si aggira nei territori dell’esclusione. E non c’è nessun ordine esterno cui contrapporsi, perché si è comunque “atomi di mortale umanità”, come dice il ben noto racconto “Wakefield” di Nathaniel Hawthorne, poco cambia se dentro o fuori dalla comunità locale. Infatti, per esempio, in “La vita dei boschi”, il quarto testo della raccolta, Mabel abbandona la pineta dove ha sempre vissuto con il padre senza neppure un guizzo di rabbia nei confronti di chi sta disboscando tutta l’area: nemmeno il richiamo della porzione di terra cui appartiene la sua identità familiare può spostarla dalla voragine di lontananza in cui è finita senza accorgersene, giorno dopo giorno. Il lento lavorio del vento tra le cime ha levigato anche lei, che è capace di sopportare le umiliazioni e, impermeabile allo spirito emancipatorio e alle sue molteplici varianti, decide di affidare la sua esistenza a un forestiero dotato di una gentilezza essenziale.

Foto di Johannes Plenio.
Mabel – come Silvi del resto, anche se per ragioni diverse – è una straordinaria rappresentante della frangia di umanità che anima il libro, esseri umani non completamente scentrati, bensì fuori posto rispetto all’asse attorno a cui girano tutte le relazioni orientate dalle consuetudini, come se vivere lontano dai principali centri di agglomerazione urbana li abbia resi dei disallineati cronici.
A ciò si aggiunge la riflessione sul paesaggio e sulla percezione paesaggistica, che trova nel racconto “Un cimitero perfetto” una mirabile esemplificazione. Víctor Bagiardelli, che progetta parchi cimiteriali famosi in tutto il mondo, è stato chiamato a Coronel Isabeta, un paesino sprovvisto di cimitero, per dare finalmente ai cittadini un luogo dove seppellire i propri cari. Ha accettato l’incarico dell’anonimo sindaco perché pensa che la particolare posizione geografica gli possa garantire la riuscita dell’impresa, vale a dire la costruzione di uno dei camposanti più belli della regione.
Bagiardelli valuta le distanze e calcola la pendenza della porzione collinare su cui devono iniziare i lavori come il marito defunto della protagonista di “Il fiume” guardava il verde circostante, lui che aveva la mania di dover dire a voce alta il nome scientifico di qualsiasi pianta, fiore o erbaccia che gli capitasse sotto gli occhi. Nello sguardo mediato che hanno entrambi i personaggi c’è la rappresentazione del principio di artificializzazione con cui è possibile isolare una porzione di quella totalità naturale da cui l’umanità è riuscita, parzialmente e solo provvisoriamente, a emanciparsi, un continuum di creazione e distruzione dominato dal caos.
Quelli contenuti in Silvi e la notte oscura non sono racconti esclusivamente argentini. Sono nati sotto il segno di una tradizione letteraria transnazionale, anglofona e ispanofona, che da più di un secolo e mezzo porta con sé la riflessione sul narrare in rapporto al sentimento della solitudine umana e che trova in Nathaniel Hawthorne così come in alcune pagine dello scrittore e naturalista William Henry Hudson i suoi capostipiti e in Silvi e la notte oscura una declinazione contemporanea da cui non sarà possibile prescindere.
Nota di Lettura
Il testo citato all’inizio è “Lucas, le sue meditazioni ecologiche”, in Julio Cortázar, Un certo Lucas, trad. it. Ilide Carmignani, SUR, 2014 (p. 33). Sulla riflessione circa il narrare in rapporto al sentimento della solitudine umana si segnala il saggio di Gianni Celati “Storie di solitari americani” che apre il volume omonimo edito nel 2006 da BUR. A William Henry Hudson, autore che appartiene sia alla storia della letteratura inglese sia alla storia della letteratura argentina, sono dedicate tra le pagine più belle di Solo per Ida Brown (trad. it. Nicola Jacchia, Fetrinelli, 2017), il romanzo postumo di Ricardo Piglia.







