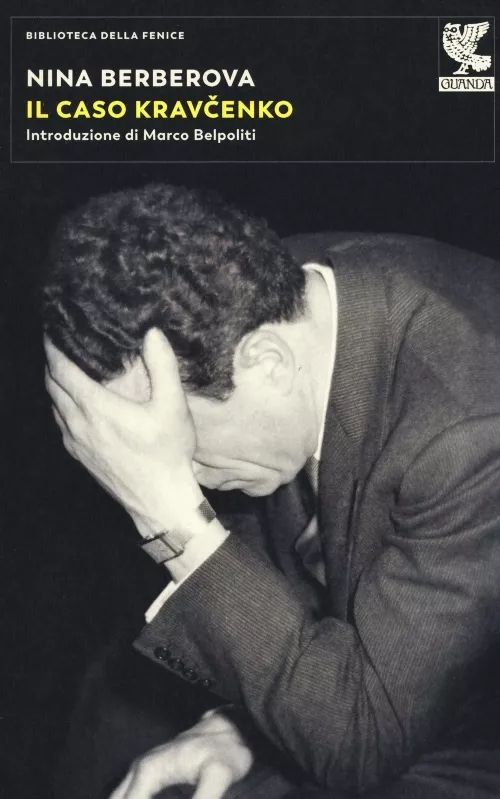Processo / Nina Berberova, Il caso Kravcenko
Viktor Kravcenko è un ingegnere agricolo ucraino. Ha combattuto sino al 1944 nell’Armata rossa con il grado di capitano, è iscritto al partito, si è distinto per qualità professionali ed è inviato a Washington con una «Commissione sovietica per gli acquisti». Nel 1946 esce in quel paese un libro autobiografico dal titolo “Ho scelto la libertà” in cui l’autore ripercorre la sua progressiva crisi morale di fronte alla degenerazione violenta e burocratica del regime sovietico, degenerazione che lo aveva portato nell’aprile 1944 a chiedere asilo politico negli Stati Uniti. Il momento storico è particolare: si stanno deteriorando i rapporti con l’Unione Sovietica allorché inizia il periodo di contrapposizione tra i blocchi, la ‘guerra fredda’. Le rivelazioni dell’autore sono sconvolgenti: violenze avviate dal gruppo dirigente sovietico, repressione negli anni del terrore, privazioni e violenze perpetrate anche nella vita quotidiana del cittadino sovietico.
Il libro diviene un clamoroso successo editoriale, provoca la reazione vigorosa dell’Urss e viene recensito nel settimanale comunista “Lettres Françaises” che accusa Kravcenko di avere mentito e di non essere l’autore del libro. Questi decide di querelare la rivista e il processo si apre nel gennaio del 1949 in Francia, avanti il Tribunale della Senna. Il dibattimento si svolge alla presenza di un folto pubblico tra cui intellettuali sostenitori della rivista, indicata come coraggiosa avversaria di un traditore dell’idea comunista. Tra questi, e tra i molti, si fanno notare forti personalità quali i letterati Gide, Mauriac, Aragon, Sartre, Arthur Koestler, Simone de Beauvoir e tra gli scienziati il fisico premio Nobel Frederic Joliot-Curie. Alcuni di essi giurano di essere stati in Russia e di non aver visto nessuna delle persecuzioni denunciate da Kravcenco. Qualche testimone avrà peraltro una crisi di resipiscenza, come l’allora deputato comunista Roger Garaudy, direttore del Centro marxista di studi e ricerche. Questi, sentito come teste nell’udienza del 22 febbraio 1949, non esita a indicare presunte menzogne, incoerenze, contraddizioni nel diario di Kravčenko. L’obiettivo è la delegittimazione, il discredito, il dileggio del nemico del popolo: “dopo ogni purga Kravčenko passava di promozione in promozione, al punto che se ce ne fosse stata ancora una si sarebbe ritrovato ministro”. In seguito però, nel 1970, sarebbe stato lui a essere espulso dal partito in quanto deviazionista per le critiche al socialismo reale e alla repressione sovietica della Primavera di Praga.
Nina Berberova è attratta da questa vicenda dai forti connotati politici, la segue come redattrice della rivista di emigrati russi, “Il pensiero russo”, e questi suoi resoconti vengono proposti ora in Il caso Kravcenko (Guanda 2019, con Introduzione di M. Belpoliti). Nata nel 1901 a San Pietroburgo, aveva incrociato nell’ultimo anno di liceo avvenimenti cruciali, quali la rivoluzione d’ottobre del 1917 e la pace di Brest-Litovsk conclusa tra la Russia rivoluzionaria e gli Imperi Centrali. Lasciata la patria, girovaga e vive in povertà, frequenta altri emigrati, scrive le loro storie ambientandole nella “Little Russia” di Billancourt, un sobborgo parigino. A guerra finita si imbarca e approda a Manhattan, impara l’inglese, incontra gli esponenti della letteratura russa, tra tutti Vladimir Nabokov che aveva frequentato a Parigi e che resterà sempre suo grande amico. Un editore francese, Hubert Nyssen, fondatore di Actes Sud, nel 1985 scopre il talento della Berberova con L’accompagnatrice. Compariranno molte altre sue opere, tradotte anche in Italia, con apprezzamento ed interesse.
Seguire un processo come giornalista è un’operazione che esce però dai binari letterari consueti della scrittrice. Nel 1949 aveva già acquisito notorietà per romanzi e racconti usciti negli anni passati, tra cui Gli ultimi e i primi del 1929, L’accompagnatrice del 1934, Genio e regolatezza. Borodin del 1936, Sovrana del 1936, La felicità del 1936, Il lacchè e la puttana del 1937, ma narrare un processo era per lei una novità. Soprattutto al cospetto di una Parigi e di un Tribunale invasi da un pubblico enorme e da uno stuolo di giornalisti attenti nel seguire le varie fasi in un clima di incredulità, tensione e rabbia. Nina Berberova riassume l’andamento delle udienze senza troppi commenti. Il ritmo narrativo è incalzante, delinea un complesso di ritratti e personaggi con stile coinvolgente, con una “partecipazione contenuta” come osserva Marco Belpoliti nell’Introduzione. La lettura trascina, il linguaggio è secco, cristallino senza le riflessioni. La Berberova annota ogni passaggio in maniera quasi furiosa, la sua osservazione è dolente, e riesce a cogliere il più ampio spettro di emozioni. Gli avvocati del periodico provano ogni mezzo per screditare i testimoni avversari, ma le accuse sono rintuzzate, talora con la scomposta reazione del pubblico. Non fiata una mosca di fronte ai testimoni dell’esule russo, giunti a supportare con le loro parole quanto questi ha descritto. Fino a quel momento nessuno sapeva dei campi di lavoro sovietici, delle loro usanze, degli esempi con cui si descrivono le condizioni dei detenuti come la “rondine”, cioè un bambino legato mani e piedi buttato a terra e picchiato, o il “gatto”, cioè la grata dell’ultimo vagone del treno installata per impedire la fuga e la caduta tra le ruote. Davanti al Tribunale sfila, durante i 25 giorni di udienza, un microcosmo della popolazione russa, contadini, ingegneri, molti citati, molti presentatisi spontaneamente. I ricordi sono terrificanti: corpi lasciati lungo la strada, interrogatori senza fine, purghe. La rivista denunciata convoca graduati, soldati, generali, giornalisti vicini al partito. I giochi si fanno sporchi con l’ingresso quale teste dell’ex moglie di Kravcenko che lo accusa di maltrattamenti, anche se la storia risulterà ben diversa e infondata. Viene anche messo in discussione il manoscritto russo del libro, analizzato poi e verificato invece come autentico dal Tribunale. La Berberova annota ogni cosa, divide il libro in giornate, cadenza le udienze in ‘quadri’ e ‘sequenze,’ l’aula assume per lei i contorni di un palcoscenico in cui transitano i testi colti in ogni minuzia.

Uno dei passi più emozionanti è la deposizione di una donna, Margarethe Buber-Neumann, il cui il singolare “privilegio” era stato l’avere conosciuto in vita entrambi gli orrori del XX secolo, i gulag sovietici e i lager tedeschi (le sue memorie compaiono con il titolo Prigioniera di Stalin e Hitler, Il Mulino 2005). Kravcenko vince la battaglia nell’aprile del 1949, ottenendo però un indennizzo piuttosto modesto. Se quello era il verdetto, la sentenza di condanna per i fedeli della rivista non poteva che rappresentare “un piccolo monumento di ipocrisia e di parzialità”, e “grave” era il fatto “che uno dei più grandi settimanali europei al quale collaborano le più grandi firme della cultura occidentale” fosse stato abbandonato “alla mercé del primo provocatore di oltre atlantico”. In occasione poi della sentenza d’appello, avutasi nel febbraio 1950 con la conferma della condanna al risarcimento a favore di Kravčenko, un pezzo non firmato apparso sempre sul foglio comunista prende a pretesto l’ammontare simbolico dei danni liquidati per affermare che per il “famigerato autore” il processo si era concluso con un “fiasco” e che il “furbo traditore” era uscito “dal dibattito praticamente sconfitto”.
Il volume merita ancora due osservazioni.
La prima riguarda il genere letterario cui il lavoro della Berberova appartiene. Esso si inserisce a pieno titolo nel filone cosiddetto del diritto “nella” letteratura, cioè quel viluppo di tematiche giuridiche che sono trattate, direttamente o indirettamente, nelle pagine letterarie. Nel caso del volume in esame le riflessioni sul diritto non emergono all’interno degli intrecci creati e delineati dagli autori, come molto di frequente avviene. La Berberova, con il suo Caso, si inserisce nella schiera degli ‘osservatori’, di coloro cioè che traevano e traggono spunto da fatti reali colti nelle aule giudiziarie, per riprodurli, narrandoli. La squadra è nutrita di numero e ricca di qualità, svariando da Buzzati a Moravia, da Gide a Giono, da Capote ai più lontani Cechov e Dickens. Per non parlare di Hanna Arendt che seguì il processo Eichmann non solo narrando, ma anche riflettendo del contesto in cui l’imputato operò, come segnala Belpoliti nell’Introduzione.
Si aggiunga che questo volume descrive un processo indiziario atipico: indiziario perché recupera fatti ignoti attraverso testimonianze, atipico perché non tratta tradizionali fatti di sangue di sapore poliziesco, ma ricostruisce avvenimenti attraverso persone che vi hanno partecipato o che li hanno subiti, come nei processi relativi ai crimini contro l’umanità del secondo dopoguerra.
Singolare però è l’occasione: si tratta di un processo per diffamazione, cioè volto a tutelare la reputazione, che molto spesso apre una finestra su uno spaccato di mondo. E questo perché è decisiva la “verità” di quello che si sostiene, e se non è provata sussiste l’infrazione. È quella che gli antichi chiamavano “eccezione di verità”, consentita per difendersi quando si è accusati di aver colpito l’onore altrui. Nel caso della Berberova la lesione fu accertata e quindi la rivista francese condannata, in quanto i giornalisti non provarono le loro accuse, che si dimostrarono infondate e quindi censurabili. Su questa linea il pensiero corre a un processo torinese del 1975, purtroppo scolorito dal tempo. Esso fu originato dalla querela di un politico ministro di allora, Giovanni Gioia, nei confronti di uno studioso, Michele Pantaleone, e del suo editore, Giulio Einaudi, per un saggio (Antimafia occasione mancata del 1969) in cui quel politico veniva indicato come “mafioso”. Gli imputati furono assolti perché le carte della Commissione Antimafia confermarono quella qualifica e quindi la ‘verità’ di quanto affermato.
Un ulteriore aspetto del volume merita attenzione. L’evento si colloca, come detto, nel particolare momento storico degli anni 50 in cui le ideologie dettavano le loro ragioni. Terminato quel periodo con trasparente euforia, le scorie non si sono completamente dileguate. Il mondo politico dell’est ha beneficiato di una sorta di un privilegio storico accompagnato da un capitale di simpatia, soprattutto presso gli intellettuali (tra i molti ancora rimasti lo Žižek di L’idea di comunismo, Deriveapprodo, 2011), ispirati dal principio del valore positivo dei fini, dalla nobiltà degli ideali, dalla purezza delle intenzioni. Le tecniche usate per negare l’accaduto sono sempre uguali. Tra tutte il diniego dei crimini con l’attacco a chi li denuncia denigrandolo, denunciando i testi contrari perché prezzolati. Anche di fronte a questi drammatici momenti della storia politica, come ha osservato di recente P. Bruckner (Le Point, 12.5.2019), il negazionismo è un fenomeno da respingere, con forza, come avvenuto per altri avvenimenti passati, in altri paesi. E non si può non convenire con questa opinione, anche se amaramente si nota che il saggio di Kravcenko, da cui si originò il processo seguito dalla Berberova, uscì in Italia nel 1948, riuscì nel 1954 e da allora non è stato mai più ristampato. Consegnato alle tradizionali polverose bancarelle o ai più moderni siti internet di ricerca libri usati. Sempre che lo si trovi ancora.