Immaginazione e negazione generativa / Perché il popolo sposta il vaso?

Consenso e ironia
Le implicazioni di questa fulminante vignetta di Altan sono davvero molte. Così come è forte la provocazione nei confronti della nostra indifferenza. La preoccupazione di Baruch Spinoza riguardo alla nostra disposizione a rimanere sudditi emerge in tutta la sua portata. Una domanda potrebbe essere: se anche di fronte a evidenti errori e scelte sbagliate che persino chi esercita il potere riconosce, quello stesso potere o una delle sue espressioni sente di poter contare su una disposizione incondizionata a colludere, compensare, adattarsi, confermare, comunque e nonostante, il consenso, come sarà mai possibile aprire gli occhi, dire di no, generare una discontinuità e creare un cambiamento dello stato attuale delle cose? La propensione alla conferma, si sa, prevale nelle nostre scelte e nei nostri comportamenti, anche quando è evidente che mantenere la consuetudine produrrà esiti indesiderabili. Le forme di comunicazione politica che fanno un uso strumentale della paura sono sempre state una efficace via di manipolazione delle opinioni e delle scelte di chi governa. Ancor più efficace si è mostrata e si mostra l’individuazione di un nemico, soprattutto se è inventato, estensibile, non dimostrabile, ma, simbolicamente, di particolare momento ed efficacia. La divisione in buoni e cattivi fa il resto e giustifica le semplificazioni sovraniste. Esempi recenti sono il comunismo per Berlusconi e i migranti per Salvini. Non si tratta, ovviamente, di fenomeni che non esistono, ma di fenomeni che opportunamente trattati e manipolati toccano sistemi emozionali sensibili e forniscono una spiegazione in scala uno a uno che si propone anche come soluzione immediata e pratica dei problemi. L’obiettivo è saturare la domanda e i dubbi, impedendo di riflettere sulle conseguenze seconde e terze di quella che si propone come soluzione immediata.
Che seicentomila e più immigrati e rifugiati siano trasformati in clandestini dal decreto sicurezza, in Italia, con conseguenze difficili proprio sulla sicurezza, non diventa motivo di riflessione e analisi, nel momento in cui si dice che il provvedimento risolve il problema e crea sicurezza per gli italiani. Quando si sostiene la negazione degli sbarchi, esultando per la cosiddetta soluzione, si satura la disponibilità a riflettere sul fatto che prima di tutto si tratta di non lasciare affogare le persone. Sostenendo che il Presidente della Repubblica ha firmato una legge dell’attuale governo, si impedisce di riflettere sulla gerarchia delle norme e, quindi, sulla costituzionalità di quella legge che deve essere comunque subordinata alla Costituzione.
Sì, va bene, si potrebbe ribadire: ma perché il popolo sposta il vaso anziché accorgersi che chi governa l’ha fatta fuori dal vaso e, quindi, mettere in discussione chi governa?
Perché chi ha la leadership può contare su un simile ottundimento della capacità di pensare, criticare, reagire e cambiare? Perché indifferenti seguiamo chi ci porta nel baratro? Perché perdiamo la libertà e la civiltà della convivenza in cambio di false promesse di sicurezza che imprigionano il nostro essere e il sentire?
Dire di no

Mimmo Jodice, No, 1976.
Insomma, in una parola di due lettere, perché è così difficile dire di NO?
Eppure vi è un potenziale creativo nella negazione che è forse irraggiungibile per altre vie. Quel potenziale riguarda, principalmente, il rapporto tra norma e anomalia. Allora le domande di prima si complicano ulteriormente fino a portare a chiederci quale sia la soglia di accessibilità all’anomalia, alla messa in discussione della normalità dominante o di quella che pare tale. La domanda riguarda soprattutto chi è in grado di mettere in discussione la cosiddetta normalità e se non si crei uno scarto fra la maggioranza delle persone e una minoranza che, sola, è in grado di sottoporre a critica l’ordine dominante e dire di no.
“La conoscenza della ‘realtà effettuale’ è un’eccezione, patrimonio di pochi”, come scrive Carlo Ginzburg citando Machiavelli, in Nondimanco, Adelphi, Milano 2018? Senza una qualche forma di religione il potere vigente non può mantenersi? O meglio, senza una maggioranza di persone che è fedele a quella forma di religione?
Un avverbio in evidente disuso, nondimanco, contiene una posizione e un movimento relazionale e intersoggettivo di particolare importanza.
L’eccezione rispetto alla norma politica e morale indica, in effetti, una rottura dell’ordine, una sua negazione, una opposizione alle forme dominanti di potere e al consenso che le sostiene. Analizzando con dettaglio e verifiche particolareggiate le implicazioni della parola nondimanco che ritorna ripetutamente nel Principe di Machiavelli e segnala un elemento che è al centro della sua opera, Ginzburg scrive:
“…nondimanco sottolinea la tensione tra virtù come energia e virtù come qualità morale. Quest’ultimo significato sembra costituire la norma cui si riferisce, ostentatamente, Machiavelli – per introdurre poi l’eccezione che corrisponde alla realtà di fatto. Analogamente, in Discorsi, I, XXVI, si legge che il politico deve essere in grado di praticare «modi crudelissimi e nimici d’ogni vivere non solamente cristiano ma umano… nondimeno colui che non vuole pigliare quella prima via del bene, quando si vuole mantenere conviene che entri in questo male». Non si tratta di un omaggio di maniera alla moralità convenzionale, bensì di un riconoscimento della dimensione tragica della politica” (p. 148).
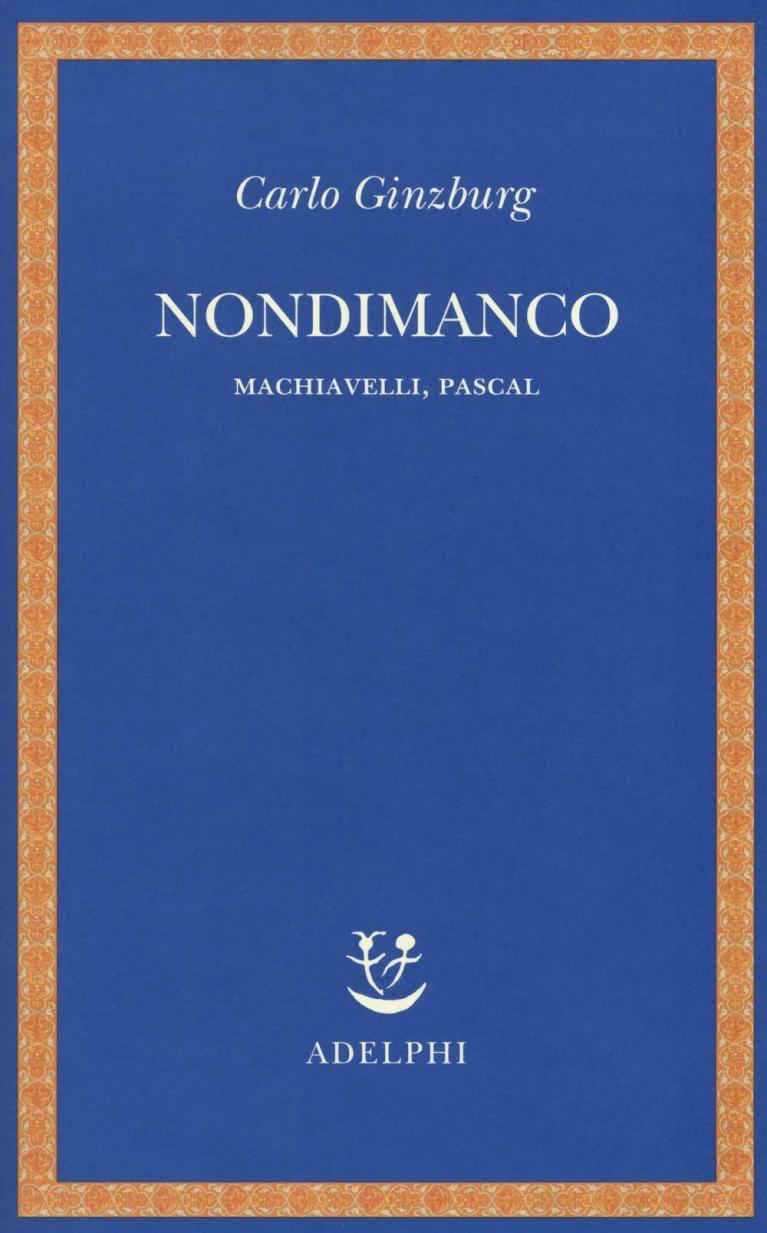
La dimensione tragica della negazione, non solo di chi governa ma anche di chi è governato, assume le caratteristiche di una virtù. Il problema posto all’inizio è che chi è governato, nella maggior parte dei casi, non si accinge e dispone a praticare la virtù della negazione. La difficoltà di dire di no è approfondita da Machiavelli: “perché lo universale degli uomini si pascono così di quel che pare come di quello che è: anzi molte volte si muovono più per le cose che paiono che per quelle che sono” (p. 214). L’uso del verbo “pascono” è decisamente eloquente per indicare la disposizione al conformismo e a consegnarsi a ciò che appare come se fosse la realtà. Quella disposizione ha forse a che fare con la difficoltà dei collettivi a contenere l’incertezza. Di fronte a un conflitto possibile tende a prevalere il conformismo, rimuovendo di fatto l’incertezza e confermando consenso e legittimazione dell’ordine costituito.
Il compito infinito
La potenza del dialogo sta nella sua incertezza. Il dialogo rinvia, in fondo, alla continua possibilità di immaginare i suoi esiti. Se non ci fosse l’incertezza dell’approssimazione e l’immaginazione di esiti possibili ma non determinati, il dialogo non avrebbe senso e forse non esisterebbe. Né la razionalità del processo e degli esiti, né la curiosità che l’altro suscita, né la sola incertezza degli esiti dell’approssimazione fanno del dialogo quello che è, bensì quello che col dialogo si crea e si può creare. Il dialogo è, perciò, il luogo del possibile. Del resto un dialogo, se è effettivo, vive alla temperatura della sua crisi e della sua interruzione.
Michel Foucault, con la densità del suo rigore, dichiarò in una delle sue ultime interviste: “niente è più inconsistente di un regime politico che è indifferente alla verità; ma niente è più pericoloso di un sistema politico che pretende di prescrivere la verità. La funzione del ‘dire il vero’ non deve prendere la forma della legge, così come sarebbe vano credere che risieda a pieno titolo nei giochi spontanei della comunicazione. Il compito del dire il vero è un lavoro infinito: rispettarlo nella sua complessità è un obbligo di cui nessun potere può fare economia. Salvo il caso in cui s’imponga il silenzio della servitù” (Le souci de la verité, “Magazine littéraire”, maggio 1984).
Se risulta problematico essere indifferenti alla verità, ma allo stesso tempo è pericoloso un regime politico che la prescrive, allora in quali direzioni ci interroga la nostra ricerca del vero, comunque presente? Mettere la verità in prescrizione normativa è pericoloso e tendenzialmente totalizzante; allo stesso tempo ridurre il rapporto con la verità alla scivolosa situazione del tutto è vero e tutto è falso porterebbe il legame sociale a una deriva di indifferenza. La verità in fondo è una ricerca, un lavoro senza fine, ma è soprattutto un compito ineludibile, seppur il suo valore consista in una continua domanda. Solo laddove si impone il silenzio della servitù il problema non esiste perché è eliminato. Tra democrazia, totalitarismo e servitù, quindi, si pone la questione della verità, della tensione verso la verità, del senso della verità, come lo aveva definito Aldo Giorgio Gargani. La verità come “glassy essence”, come rispecchiamento, è probabilmente uno dei principali vincoli alla critica e all’invenzione dell’inedito. Scrive Gargani:
“In luogo della verità come rispecchiamento, come glassy essence, diventa più interessante il gioco della prassi, per esempio inventare o escogitare una società più bella e più giusta, anziché scoprire la società più vera. Si tratterà di un’etica senza filosofia, senza teoria, senza teoremi, lemmi e scoli, sarà qualcosa che solo la prassi (non per questo cieca) potrà generare entro i vincoli dei contesti e delle situazioni storiche. E il vero, allora, lo perdiamo? Ma no, il vero sarà, come sempre sarà e come è sempre stato, la conseguenza tardiva di un gesto sociale che l’ha preceduto, che gli ha preparato il posto da riempire insieme all’ordine della sua costituzione” (A. G. Gargani, Il vincolo e i codici simbolici, in A.A.V.V., Il vincolo, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006; p. 86).
Non è probabilmente affermando una verità che ci realizziamo o si valida una conoscenza, ma è nel dubbio e nella possibilità di dire di no che ci individuiamo e troviamo la nostra distinzione di specie. Il “potere di non” sta probabilmente alla base della libertà e della democrazia e fonda il dialogo che di quelle due esperienze è il principale fattore costitutivo. Per essere diventato fondamento dell’agire politico e progettuale umano il “no” deve avere a che fare con la nostra storia e deve probabilmente avere correlati nella nostra esperienza evolutiva di specie.
Oltre
Quando siamo diventati capaci di concepire l’oltre e di riconoscerne l’importanza? È verosimile ritenere che ciò sia accaduto con l’evolversi del pensiero simbolico e della cooperazione e condivisione comunitaria. Il ruolo del pluralismo e della molteplicità condivisa, così come le funzioni svolte dalla comunicazione cooperativa, sembrano essere stati particolarmente rilevanti per tendere ad andare oltre i comportamenti individuali immediati e pratici e la semplice imitazione della consuetudine. Ciò non vuol dire che la forza dell’abitudine, la potenza rassicurante del consueto, la disposizione alla ripetizione e al consenso per ciò che è noto e ripetitivo si siano dileguate. Tutt’altro. Dire di sì all’esistente ha convissuto e convive con la capacità di dire di no. Prove evidenti mostrano, anzi, come la propensione alla conferma dell’esistente tenda ad essere prevalente in ogni manifestazione umana, connessa com’è ai sistemi emozionali di base e alla memoria filogenetica con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di necessità di tutela dalla paura e dall’incertezza.
Solo così si può andare oltre, potendo contare su una base sicura, che però consegna sempre, in una certa misura, al rischio del conformismo e della rinuncia alla ricerca della discontinuità. Del resto “oltre”è sia un avverbio di luogo che di tempo e rimanda, pertanto, al tempo e allo spazio. Andare oltre, perciò, indica sia la disposizione a porre al centro il futuro e non solo il presente, sia la possibilità di creare spazi di possibilità rispetto all’esistente.
Comprendere l’altro come condizione di possibilità generative.
La sorella maggiore di Ludwig Wittgenstein, Hermine, scrive, nei suoi ricordi, di un dialogo col fratello, dopo la sua decisione di rinunciare alla filosofia e di fare il maestro elementare.
“La sua seconda decisione, quella di scegliere una professione del tutto inappariscente, e se possibile di fare il maestro elementare in una scuola di campagna, fu per me in un primo tempo incomprensibile, e poiché noi fratelli siamo abituati a esprimerci per immagini, gli dissi allora, in occasione di una lunga discussione, che immaginarlo come maestro elementare, lui con la sua raffinata intelligenza filosofica, era come immaginare uno che volesse usare uno strumento di precisione per aprire una scatola di latta. Ma Ludwig mi rispose con un paragone che mi ridusse al silenzio. Mi disse, infatti: ‘Mi ricordi un uomo che guarda attraverso una finestra chiusa e che non riesce a capire gli strani movimenti di un passante; non ci riesce perché non sa quale tempesta si è scatenata là fuori, e che quell’uomo forse fa fatica a tenersi in piedi” (H. Wittgenstein, Familienerinnerungen, a cura di Ilse Somavilla, Haymon, Insbruck-Wien 2015).
Appare evidente come non vi sia possibilità di relazione se non come approssimazione, in quanto non c’è “logos” senza “dia”: (intersoggettività) dia-logo; e non c’è immagine senza azione (azione): immagin-azione.
Il primato dell’azione e dell’intersoggettività nell’esperienza umana sono possibili in quanto ogni presenza è unica e per il fatto stesso di essere presente implica una affermazione che è anche negazione, sia a livello individuale che collettivo.
Verità come negazione
È negando che si afferma in democrazia, e così si realizza la forza fragile della democrazia. Il conflitto, inteso come dialogo tra differenze, trae origine dalla possibilità umana di dire di no. C’è dialogo quando c’è differenza, e l’elaborazione di una differenza implica l’attraversamento di un conflitto di minima o elevata intensità. Noi siamo quelli che vivono a partire dall’azione, e cercando significati delle azioni che così diventano esperienze. In questo transito, in cui l’intersoggettività si fa unicità soggettiva, per l’unicità relativa del sense-making che ci caratterizza, essendo noi intersoggettivi che diventano unici nell’intersoggettività, emergono differenze nell’attribuzione di senso e di significati. È nella selva delle differenze di significato che emerge la necessità/possibilità del dialogo. È in quella situazione originaria in cui ognuno è almeno in parte originale che si crea la differenza che deve essere continuamente e dialogicamente elaborata. In origine, dal due nasce l’uno, che nascendo istituisce un nuovo inedito due, la cui presenza richiede elaborazione. Nel momento in cui l’uno che nasce è vero, per il fatto stesso di esserci esige l’elaborazione della differenza che la sua presenza propone. La verità della presenza richiede di essere proposta e affermata, in quanto solo quando diventa vera, cioè quando assume senso per almeno un altro, può essere riconosciuta come tale. Quel riconoscimento è, però, sempre provvisorio e tale da richiedere di essere confermato nel dialogo. Si tratterà, nel tempo, di un riconoscimento che, proprio perché provvisorio, attiva ricerca dialogica alla ricerca continua di riconoscimento. “Sono sempre più convinta che le nostre vite dovrebbero reggersi un po’ più sulla meraviglia che sul cinismo”, ha detto Isabella Rossellini [intervista, Robinson, 6 gennaio 2019].







