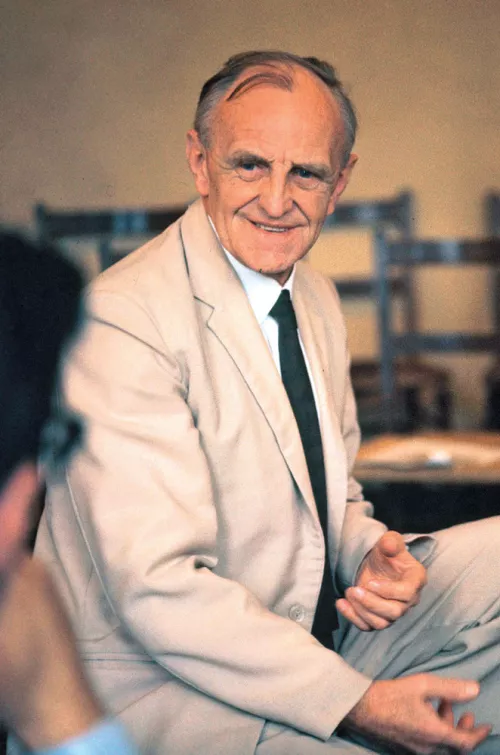Winnicott: creare sé stessi
Non per riparare a lutti derivanti dal distacco originario della nascita, ma per esprimere i nostri potenziali di sviluppo siamo concepiti, nasciamo ed esistiamo. Siamo figli del desiderio e non della necessità, ha sostenuto Gaston Bachelard. E non solo nei processi dinamici e continui in via di possibile riorganizzazione, ma anche nel nostro inconscio da intendersi come una riserva creativa protetta. Si apre così il sentimento di noi stessi, il modo di intendere la nostra esistenza, a un’aria fresca e vitale, a un territorio fertile che non è da bonificare, ma è ricco di potenziali da lavorare ed elaborare per espandere la vita psichica e soggettiva. Siamo nel clima dell’intero percorso di ricerca e applicazione di Donald Winnicott. Uno spessore unico nella storia della psicoanalisi e dell’antropologia umana, ma anche della pediatria e delle anticipazioni della ricerca neuroscientifica. Una conquista inquieta e in parte anche dolorosa, ma condotta con una forza vitale capace di attraversare molteplici contraddizioni, incluso il confronto difficile e generativo con una figura essenziale nella vita del nostro autore, come quello con Melanie Klein. Un conflitto generativo, ben documentato, ad esempio, da F. Robert Rodman [Winnicott. Vita e opere, Raffaello Cortina Editore, 2014]. Esiste un filone prezioso nelle falde della ricerca per individuare cosa significa essere umani e per giungere a una visione più efficace e documentata di noi stessi. Come mostra Vittorio Gallese, con evidenza di riferimenti e risultati di ricerca sperimentale, i neonati e i bambini, ed eventualmente i feti, lungi dall'essere inizialmente ‘normalmente autistici’, esprimono la natura per eccellenza di tutti gli esseri umani: sono creature, in quanto le relazioni interpersonali costituiscono un aspetto fondamentale della natura umana. I contributi di Daniel Stern, Colwyn Trevarthen, Ed Tronick e tanti altri, spesso collettivamente etichettati come esponenti dell'Infant Research, hanno chiaramente dimostrato che gli esseri umani non nascono come singole monadi ma come esseri sociali costantemente alla ricerca di altri con cui confrontarsi nell’imitazione reciproca e nella regolazione emotiva. I bambini e i neonati sono agenti intenzionali con la capacità di eseguire movimenti ben organizzati e sviluppati per stabilire collegamenti significativi con gli altri. Relazionarsi è primario: l'io completo si forma quando viene percepito come un tu, quando il dialogo interpersonale si trasforma in dialogo interiore. In effetti, come ha mostrato la ricerca sui neonati, il ritmo, la sincronicità e gli impegni asincroni che gli esseri umani sperimentano sistematicamente fin dall'inizio delle loro relazioni interpersonali segnalano la nascita dell'intersoggettività [V. Gallese, From pre-natal relations to self-constitution. A neuro-behavioral perspective on primary narcissism. Accepted for publication in International Journal of Psychoanalysis, 2025; per gentile concessione dell’autore]. Non esiste un bambino senza una mamma, sostiene suscitando il nostro stupore Winnicott, e le implicazioni di questa affermazione sono ancora in buona misura da riconoscere nella loro ampia e complessa portata. Non solo, ma il radicamento della vita psichica è nella dimensione creativa inconscia e lo stesso psichico si propone come espressione dell’attività poetica del soggetto.
Nel titolo che avrebbe voluto dare alla propria autobiografia, “Non meno di ogni cosa” (not less than everything), si può riconoscere molto della personalità, dell’ispirazione, del percorso e della rilevanza scientifica e operativa di Donald W. Winnicott. Sia per la forza innovativa del suo contributo, che per la capacità anticipatrice delle sue ipotesi di ricerca e dei suoi metodi applicativi, Winnicott è un riferimento fondamentale nello studio del comportamento umano e nella comprensione della nostra stessa natura. Dalla raccolta di scritti inediti appena pubblicata emerge la complessità della sua ispirazione, combinata con la ricchezza della sua figura di essere umano e di pediatra e psicoanalista, [D. W. Winnicott, Il sentimento del reale. Scritti inediti, Raffaello Cortina Editore, 2025]. La cura di Sara Boffito e Anna Ferruta rende ancora più prezioso un testo di per sé imprescindibile. I saggi introduttivi ad ognuna delle cinque parti del libro, oltre alla presentazione e ad una mirata selezione di frasi dalle opere di Winnicott, distribuita tra le parti e denominata Lampi di intuito. Glimpses, forniscono al lettore una guida di particolare puntualità e rigore sia per avvicinarsi ai testi che per connetterli all’intero lavoro del grande psicoanalista.
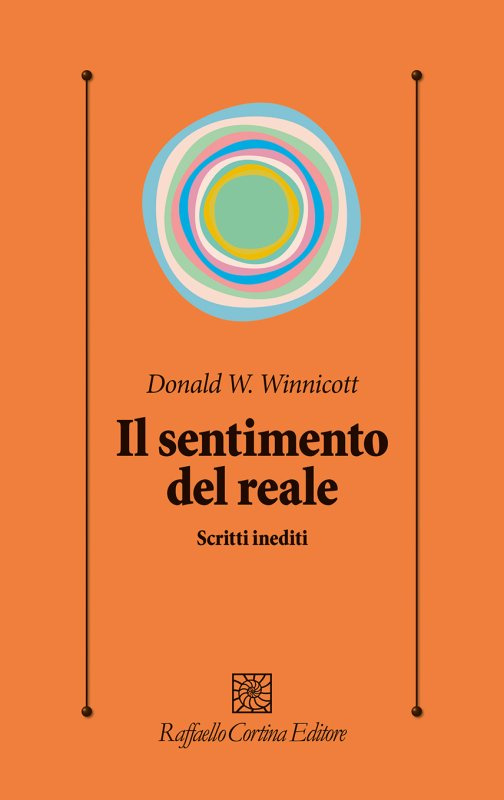
Iniziamo ad assaggiare alcune questioni di particolare importanza per poi percorrere insieme i contenuti del libro. “L’ambiente primitivo è parte dell’individuo, come lo è l’istinto”, scrive Winnicott in un appunto manoscritto del 28 novembre 1945. Qui incontriamo subito due rilevanze molto importanti: il primitivo non è il primario, come spesso abbiamo trovato in traduzioni che confondevano i due concetti. Winnicott non si riferisce, con primitivo, al venire prima o alle relazioni precoci, ma ad una qualità dell’esperienza, ovvero alla persistenza filogenetica che abita in noi mentre diveniamo noi stessi nel qui ed ora. Il primitivo persiste con noi e ritorna sotto svariate forme nelle molteplici esperienze della nostra vita. Così come emerge l’attenzione all’ambiente in quanto contributo fondamentale all’evoluzione della psiche. Sarà proprio nel rapporto tra l’azione del primitivo, l’isolamento essenziale e necessario per individuarsi e il diritto a non comunicare che Winnicott riscontrerà la regressione che porta alla scoperta di sé, a potere sentire: “Per la prima volta esisto, sono me stesso, mi conosco e mi sento reale”. È da questa posizione che il paziente può iniziare a vivere e a creare relazioni oggettuali senza sentirsi annichilito [p. 96]. Questa dimensione del sentirsi vivo, così centrale nel pensiero di Winnicott, è qui colta nel suo naturale sbocciare. Una tale concezione della psicoanalisi come disciplina del vivente, dell’essere in relazione senza correre troppi rischi di annichilimento o di alterazione, costituisce il nucleo profondo del pensiero di Winnicott, da cui attinge la sua teorizzazione dei fenomeni transizionali. È così che la condizione tra creatività primaria e incontro con l’oggetto è riconosciuta come la base essenziale della sanità mentale e, nei saggi contenuti nel libro, viene illustrata con chiarezza concettuale e intensità emotiva. Nell’approfondimento della natura dell’incontro tra intensità emotiva e creatività soggettiva si situa una delle svolte della ricerca di Winnicott, a partire dalla presa di distanza dall’interpretazione della creatività umana come riparazione, propria dell’approccio e dell’orientamento kleiniani. Secondo il nostro autore l’oggetto mette a disposizione un’esperienza, un sentire vivo, e il soggetto crea questa esperienza secondo la propria personale fantasia.
La stessa modalità di pensiero e scrittura che emerge dagli inediti contenuti nel libro, un processo del pensare scrivendo e dello scrivere pensando, mostra la sua efficacia, ad esempio, in un breve scritto nel quale Winnicott si occupa dell’inconscio. Prima di tutto egli individua quattro modi di intendere l’inconscio. Con le prime due forme si riferisce all’inconscio come materiale rimosso e all’inconscio come proprietà degli aspetti profondi della personalità, richiamando concezioni classiche sia freudiane che di altri autori. Nella terza definizione l’inconscio assume le caratteristiche della struttura della personalità e di idee, sentimenti o ricordi conservati all’interno e isolati in modo da essere inaccessibili alle altre proprietà dell’inconscio stesso. È nella quarta dimensione che introduce un neologismo unconsciousness, letteralmente inconscità, o qualità inconscia, intesa come una qualità dell’esperienza che Winnicott ha esplorato tra i primi, quella dell’area del gioco e della fantasia, del sentirsi vivi – una dimensione del vivere che non si conquista con l’intelletto, ma attraverso l’integrazione dello psiche-soma, ossia l’esperienza della vitalità fisica e immaginativa. Quella vitalità che si rileva nel parallelismo tra allucinare e creare e che nella creazione si manifesta attraverso un “deliberato trascinamento nell’elemento cosciente”. Il lavoro dell’artista e la sua creatività sono un’azione deliberata. L’azione dell’artista è preziosa perché è densa di volontà: l’attività inspiegabile che proviene dall’inconscio viene trascinata nella coscienza rimanendo la stessa dell’azione che sarebbe stata determinata inconsciamente. Winnicott riconosce all’artista un grande potere, quello di agire con la propria volontà su ciò che in altri casi sembra inconsciamente determinato. La creatività sembra perciò emergere da un’ambiguità tra un contatto diretto con l’inconscio, ma filtrato dalla volontà e da una sorta di recita inevitabile costituita dall’azione concreta dell’artista (dipingere, scrivere, scolpire, così come tutte le forme di arte performativa).
“L’artista ha la capacità e il coraggio di restare a contatto con i processi primitivi che lo psico-nevrotico non può tollerare di avvicinare, e che le persone sane rischiano di perdere impoverendosi”, scrive Winnicott nel 1959. E così integra, il 21 giugno del 1961: “Non c’è bisogno di aggiungere che nel pensiero creativo la capacità di consentire e di utilizzare una certa quantità di pensiero del processo primario è di fondamentale importanza”. La profondità radicale in base alla quale ogni conoscenza è creazione viene confermata dalla riflessione sull’evidenza che il bambino sviluppa la capacità di accettare un simbolo di unione con l’oggetto, cosicché la questione della appercezione e della percezione dell’oggetto diventa relativamente poco importante, laddove vige il confronto, labile e provvisorio, con la realtà non-me. Come giustamente propone Anna Ferruta, le riflessioni di Winnicott riecheggiano quelle di un fisico come Carlo Rovelli, che in Helgoland (2020; p. 13) afferma che la scienza è uno dei modi per pensare il mondo, ridisegnandolo da zero: “Ma questo è la scienza: un’esplorazione di nuovi modi per pensare il mondo. È la capacità che abbiamo di rimettere costantemente in discussione i nostri concetti. È la forza visionaria di un pensiero ribelle e critico capace di modificare le sue stesse basi concettuali, capace di ridisegnare il mondo da zero. Una realtà fatta di relazioni, prima che di oggetti”. Winnicott ci conduce così a pensare che il compito infinito dell’artista racchiude la possibilità di sviluppare riflessioni centrali sulla natura umana. L’artista si configura come colui che ha trovato un modo di interrogare e rispondere – mai risolvere – la scissione universale e il dilemma che accompagnano il nostro contatto con la realtà. L’artista quindi può incarnare i due opposti dando spazio alla comunicazione con gli oggetti soggettivi. È questo il suo coraggio: scegliere in modo deliberato, di sostare in quell’area che porta con sé il sentimento del reale, quel nucleo centrale che è necessario proteggere e che si sente esposto nella follia; e allo stesso tempo attraverso la sua opera, scegliere di comunicare, dunque cercare un contatto con la realtà. Per questo il lavoro degli artisti aiuta noi, sempre sul crinale di quella perdita, a ritrovare il sentimento del reale. C’è un modo di comunicare che attinge all’immaginazione, un modo di essere in contatto con la realtà sentendosi anche in contatto con sé stessi. Un modo di essere che si rischia di perdere, impoverendosi, quando tendiamo a fuggire nella salute mentale rischiando di soffocare aspetti di noi, invece di permettere a quegli aspetti di noi di entrare nell’essere (come into being) e alla follia di diventare un’esperienza accettabile, un’esperienza che l’arte e la psicoanalisi possono rendere possibile. Nell'ultimo densissimo scritto per il quarto numero postumo di Le Grand Jeu (1932), René Daumal riconosce due tipi di filosofi: quelli «dello status quo», preoccupati di ingabbiare il mondo e l'essere umano in una serie di metodologie e modelli epistemologici, sempre più esatti e in continuo sviluppo (ovvero: le Macchine per Pensare); e quelli, invece, per cui «conoscere un oggetto è creare quest’oggetto; poiché il solo atto creatore che io possa pensare è quello con cui io creo me stesso in ogni istante» [R. Daumal, Il rovescio della testa, Adelphi, 2025; vedi la recensione di Emanuele Dattilo].
Tutto il percorso di ricerca e intervento di Winnicott appare caratterizzato da questa tensione, in cui la propensione creativa di sé stessi e del proprio mondo che può emergere o non emergere dalla natura e qualità delle relazioni assume un carattere costitutivo fondamentale. Il radicamento della vita psichica è collocato nella dimensione creativa inconscia e non nella banalità descrittiva dei comportamenti. L’inconscio non è concepito solo come un aspetto minaccioso da cui difendersi fobicamente nella forma di fantasmi persecutori, ma anche come una riserva preziosa di esperienze personali a cui attingere per avere una vita psichica propria. Lo psichico, insomma, è espressione dell’attività poietica del soggetto.
Emerge così la rilevanza attribuita all’area transizionale. A quell’area, all’esperienza culturale, allo spazio dell’immaginazione, appartiene quello che per l’artista è “un compito infinito. Un compito che naturalmente non può mai finire, perché si tratta di dimostrare allo stesso tempo il positivo e il negativo di qualcosa” [p.103]. Il sentimento del reale si forma in questo gioco senza fine: ha a che fare con l’essere sani ed è uno stato dell’essere che implica allo stesso tempo un contatto con la realtà esterna e con il mondo interno. È da questa dinamica che deriva la capacità di attribuire un significato personale; uno stato in cui la percezione sensoriale non porti a una perdita del senso del reale. Il senso del reale è un passaggio fondamentale affinché il sentimento del reale possa consolidarsi, e il contatto con la realtà possa permettere di sentirsi reali, agendo nell’ambiente con la spontaneità propria del Vero Sé. Come sostengono le curatrici, è proprio da questo orientamento di Winnicott che deriva la scelta del titolo della raccolta di inediti, Il sentimento del reale, appunto. È per quella via che Winnicott è arrivato a illuminare la vitalità quotidiana di ciascuno, quella vitalità che crea mondi.
Leggi anche:
Ugo Morelli | A che gioco giochiamo