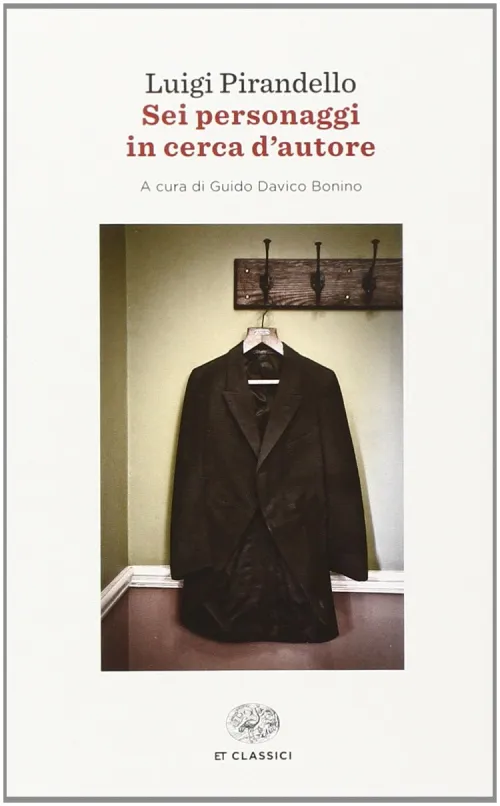Speciale
Sei intelligenze artificiali in cerca d’autore
Ultimamente ci si chiede spesso se l’intelligenza artificiale arriverà un giorno a sostituire anche il teatro. Che domanda interessante! – risponderebbe ChatGPT; ideale per aprire il nuovo anno di questo speciale chiamato Personaggi in cerca d’autore. Perché, in effetti, oltre al problema delle fonti, della loro attendibilità e verificabilità – cioè dell’autorevolezza dell’autore – un chatbot offre numerosi spunti di riflessione sul concetto di “personaggio”. Pensate alla fenomenologia di un algoritmo, a come si presenta, a come vuole apparire umano ai nostri occhi. Siri, Alexa, Cortana, Gemini... il nome ci dà subito l’impressione di parlare a un’entità che se non è ancora antropomorfa, è quantomeno antropofriendly, e che infatti definiamo “assistente virtuale”. Ha una voce, una memoria archivistica e una personalità simulata, che le permette di condire i suoi commenti di osservazioni sagaci e stimoli motivazionali. Ora, al di là del non trascurabile fatto che, come è già stato fatto notare da più parti, attribuire a queste entità nome e voce femminili rinforzi lo stereotipo della donna sempre a disposizione, possiamo porci un’ulteriore domanda, che converte la questione di genere in una ontologica: perché ci sembra così normale attribuire a un algoritmo prerogative umane?
La ricerca scientifica persegue l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale sempre più simile alla (o confondibile con la) nostra. Sarà il delirio di onnipotenza che ci contraddistingue dalla notte dei tempi, sedimentato in tutti i miti della protogenie, da Adamo ed Eva a Deucalione e Pirra, dal Golem a Frankenstein, eccetera, che ci spinge a modellare la creatura a immagine e somiglianza del creatore; come se la sola figura del pensiero accettabile sia quella umana. Non riusciamo proprio a concepire che esistano intelligenze non legate al cervello – quelle delle piante, per esempio; o dei funghi, che vanno tanto di moda – e ci abituiamo sin da piccoli a cartoni animati che umanizzano tutto: animali, vegetali, minerali, oltre a oggetti concreti e sentimenti astratti. La verità è che nulla rende più umano un algoritmo della nostra volontà di pensarlo umano, di interpretare quel miscuglio di dati come se fossero il discorso coerente di un’entità dotata di nome e personalità: gli chiediamo «per favore» di ricercare qualcosa, e all’arrivo dei risultati rispondiamo «grazie». In realtà, davanti a noi ci sono solo parole che non appartengono a chi le enuncia, perché chi le enuncia è semplicemente un simulacro di enunciante virtuale. Ma è sufficiente: interagire con un’intelligenza dalla forma riconoscibile è evidentemente più intuitivo, e più comodo; ma allo stesso tempo ci disabitua a pensare che ci siano altre forme di esistenza. O – cosa ancora più complessa ma interessante – che non tutto ciò che esiste, per esistere, debba passare per una forma.
Nella sua Logica, Aristotele ammette candidamente di poter parlare solo di ciò che ha forma; e nella Poetica si prodiga nel descrivere come il mythos, cioè la composizione drammaturgica, serva a dar forma alle vicende umane – facendo così della mimesis, in sostanza, un processo di formalizzazione. Di conseguenza, il personaggio sarebbe la forma che prende un ethos, un carattere, per manifestarsi davanti al pubblico. Un personaggio esiste solo nella sua fenomenologia scenica, cioè per quello che gli sentiamo dire e gli vediamo fare. Certo che poi può vivere oltre la scena e oltre l’opera, come Antigone, Amleto, Vanja o Hedda Gabler; ma solo in virtù di un supplemento di immaginazione che ricrea per lui quella scena virtuale in cui possiamo farlo agire e parlare, e a cui diamo il nome di “tradizione culturale”. Per sé, un personaggio non esiste: le sue parole sono quelle dell’autore o dell’autrice; che però, per convenzione, devono apparire come se fossero pronunciate da entità “altre”, ognuna con un linguaggio “personale”. E dunque ci si chiede: come parla un’adolescente antisistema, un principe con manie di persecuzione, il gestore di un’azienda agricola stanco della vita, una ragazza che rifiuta il ruolo subalterno a cui la società vorrebbe relegarla...? Che parole usa? Che idioletto? Quel che dice e come lo dice sono la base di una psicologia artificiale, che il pubblico dovrebbe prendere per naturale; se ciò accade, il gioco è fatto: l’ente è esistente. A questo punto, sarà plausibile che il personaggio nasconda segreti e obiettivi, viva conflitti, prenda certe decisioni piuttosto che altre. Il personaggio serve alla storia e, allo stesso tempo, può indirizzare la storia su vie che l’autore o l’autrice non avevano previsto: ha preso vita; e così ha preso vita il suo mondo, che è il mondo inesistente dell’opera di teatro.
È il paradosso che Luigi Pirandello mette in mostra un secolo fa, nel suo testo più celebre. I suoi personaggi in cerca d’autore vagano in un limbo che non permette loro di vivere veramente, finché non trovino un autore che porti in scena il loro dramma. Dramma che poi, in termini di contenuto, è proprio poca cosa: un incontro fortuito tra un padre depresso e un figliastra troppo emancipata, interrotto da una madre in gramaglie, infastidita dai livori di un adolescente arrabbiato con il mondo. Insomma pseudo-trama da telefoni bianchi, melodramma di provincia... No, no, il loro vero dramma, quello che interessa a Pirandello, è un altro; e riguarda proprio la condizione esistenziale di questi esseri che, scrive l’autore siciliano nel suo prologo, «vivono per conto loro; hanno acquistato voce e movimento; (...) possono da soli muoversi e parlare; vedono già se stessi come tali». Insomma, entità frutto della fantasia che pretendono di vivere; e, davanti agli attori e le attrici che dovrebbero interpretarli, si lagnano che «non ci corrispondono affatto». Ovvio: i personaggi, che sono puro ideale, non potranno mai trovare un’incarnazione adeguata alle loro esigenze! – perché l’ideale non è di questo mondo. E infatti lasciano la scena a quegli stessi attori e attrici che invece, nella loro incapacità a interpretare i personaggi, mostrano che la piena umanità del teatro risiede non tanto nella perfezione del gesto attorale, quanto nel suo straziante fallimento nel tentativo di rappresentare il mondo.
Eppure una buona parte della pedagogia attorale ha pedissequamente annichilito questa umanità, per provare a fare di attori e attrici delle macchine infallibili; spingendoli a dimenticarsi di essere le persone che sono, per identificarsi in toto con il personaggio che devono accogliere e restituire. D’altra parte, la grande utopia del teatro naturalista è sempre stata quella di far sì che ciò che accade sul palco sia preso per vita vera; e i suoi protagonisti e le sue protagoniste, per persone reali. Le tecniche sviluppate da Tommaso Salvini, Konstantin Stanislavskij o Lee Strasberg andavano in questa direzione; e ancora oggi in accademia si fanno fare ad alunni e alunne esercizi che li spingono a uscire dall’aula per imitare l’uomo della strada, la donna qualunque; riprodurne i movimenti, i gesti, assumerne il tono della voce, il linguaggio e le parole. Sì, perché le parole di un personaggio devono sembrare quelle di una persona reale; e mai in alcun modo essere percepite come pre-scritte, frutto del pensiero di un autore o un’autrice. Una volta scritte le battute, l’autore o autrice si ritira e scompare, per non rompere la magica illusione che quello da lui o lei creato sia un mondo originale e non originato.
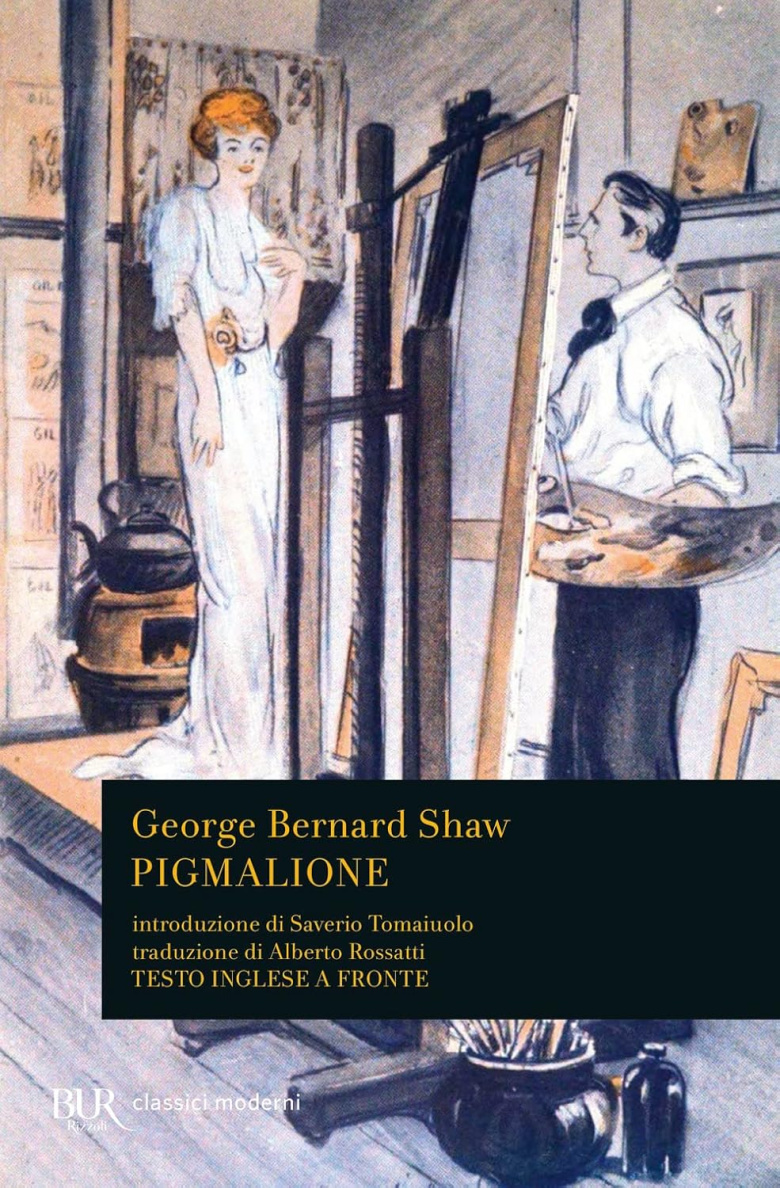
Afferma Voltaire nel suo Candide che la cosa più difficile per chi scrive teatro è «essere grande poeta senza che nessun personaggio dell’opera sembri un poeta». L’affermazione è così bella e così vera, che quasi non ci si crede che un secolo e mezzo dopo Edmond Rostand l’abbia smentita altrettanto bene. Cyrano de Bergerac è poeta come il suo autore, ed è a sua volta “autore” del personaggio di Cristiano, il cadetto bello e scemo a cui scrive e suggerisce le battute, mentre con il suo lungo naso resta invisibile nell’ombra, sotto il balcone dell’amata Roxana. Il problema di Cyrano è il problema di ogni autore o autrice: come creare un personaggio credibile agli occhi (e al cuore) del suo pubblico. Per Roxana, Cristiano è la voce che porta in «questa brezza fragrante, il parlar ne lo stile di un arcade galante»; lei è innamorata di quel parlare, e quando quella voce la delude – quando cioè Cristiano prova a fare da solo – si stufa e la zittisce. Insomma, Cristiano esiste solo perché Cyrano lo riempie di contenuti e Roxana immagina dietro quei contenuti il suo uomo ideale. Non è poi molto diverso da quel che accade nella più fortunata delle commedie di George Bernard Shaw, il Pygmalion – che prende spunto dal mito delle Metamorfosi di Ovidio, in cui l’eponimo scultore plasma nella sua statua la figura di donna di cui si innamora. L’autore irlandese mette in scena gli sforzi del professor Higgins per convertire in poche settimane la rozza fioraia Eliza Doolittle in una Lady dell’alta società inglese. L’educazione che le imparte consiste in una serie di ferree istruzioni: in questi casi, fare così; in questi altri, fare cosà; a domanda tale, risposta tale; e via dicendo. “Programma” il suo linguaggio, ne scrive il prompt, insomma; in modo che somigli sempre di più a quello delle interlocutrici con cui deve interagire, per poter essere infine confusa con una di loro.
Capite allora che il personaggio classico è un po’ una sorta di algoritmo ante-litteram, un’entità inesistente fatta di parole scritte da qualcuno avente come obiettivo che la sua creatura sembri più umana possibile. Da questo punto di vista, dobbiamo ammettere che l’intelligenza artificiale può benissimo sostituire un’autrice o un autore nella sua funzione creatrice; cosa che, tra l’altro, già in parte avviene. Ma la verità è che non siamo neppure troppo lontani dal momento in cui dei robot potranno sostituire attori e attrici nell’interpretazione di un personaggio; esperimenti se ne sono già fatti e se ne continuano a fare. Si realizzerebbe così l’utopia inconfessabile di ogni regista: qualcuno che non sbaglia le battute, che le dice proprio come dovrebbe dirle, che fa sempre quel che gli chiedi di fare, in modo ineccepibile e senza lamentarsi mai. Ma è proprio questo, che vogliamo? Personaggi replicanti, incarnazione loro malgrado dall’ideuzza di qualcuno che sta lì a battere con le dita sulla tastiera di un computer? Che cosa poco umana, e poco teatrale! Forse, come in Pirandello, è proprio necessario che la creatura si emancipi dal suo creatore. Che questo atto di ribellione sia inevitabile, lo dimostra quel romanzo di Philip Dick intitolato Il cacciatore di androidi (su cui Ridley Scott ha girato Blade Runner), in cui sei personaggi provenienti dalle colonie extra-mondo vanno in cerca del loro autore per sbattergli in faccia il loro «Voglio più vita, padre!». Personaggi con una coscienza simulata, una psicologia inventata ad hoc e ricordi innestati; cioè una storia che qualcuno ha scritto per loro. Ma al di là di tutto, ciò che renderà i replicanti tragicamente simili agli umani è la pietà nei confronti di altri esseri viventi, la paura della morte, l’amore impossibile... Deviazioni inaspettate del programma originale. Fallimenti del prompt. Pulsioni che nascono da una sorta di intelligenza emotiva; non certo da quella logica.
Una buona parte della drammaturgia del Novecento, da Brecht a Beckett, da Heiner Müller a Sarah Kane, ha messo in questione, fatto a pezzi e poi fatto fuori il personaggio, in nome di una liberazione dalle gabbie del pensiero logico, e della forma. Per esprimere le proprie idee non è per forza necessario costruire personaggi che simulino persone reali – basta guardare agli ultimi Premi Nobel teatrali: Jon Fosse, Peter Handke e soprattutto Elfriede Jelinek. E forse non è nemmeno necessario scrivere storie che, sulla scia del caro, vecchio Aristotele, diano forma logica all’esistenza. Molto del teatro d’avanguardia del Novecento è un teatro che ha sostituito il concetto di “storia” con quello di “esperienza”; un teatro che propone non una copia della vita, ma una modalità altra di esistenza. Un teatro in cui, per fortuna, mai si potrà compiere il sogno inconfessabile del regista, perché uno spettacolo non è la copia perfetta del precedente e chi è in scena è prima di tutto se stesso, cioè un essere umano, e non la triste replica di un’entità inesistente. Ecco, questo è il teatro che non potrà mai essere sostituito dall’intelligenza artificiale; proprio perché è un teatro che appella non all’intelligenza logico-formale, ma a quella misteriosa forma di esperienza del reale che passa per l’intelligenza emotiva, e che ci rende così unicamente umani.
Per saperne di più
I Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello non ha bisogno di troppe presentazioni, e di edizioni ce ne sono in giro parecchie; stesso discorso per il Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand – di cui però consiglio la storica (1898) traduzione in versi di Mauro Giobbe. Il Pigmalione di Shaw è stato invece rieditato da Rizzoli nel 2022. Per chi volesse addentrarsi nei misteri delle tecniche attorali, l’immortale Il lavoro dell’attore sul personaggio, di Konstantin Stanislavskij, è pubblicato da Laterza. Un altro grande classico di genere è La crise du personnage dans le théâtre moderne, che Robert Abirached ha pubblicato nel 1978 per Gallimard; purtroppo però mai tradotto in italiano.
Leggi anche:
Davide Carnevali, Pasolini: un teatro scomodo
Davide Carnevali | Creonte e la tragedia della politica
Davide Carnevali | Il primo Sosia
Davide Carnevali | Il Ricco Trump e il Povero Zelensky
Davide Carnevali | Amleto: lo schermo e lo specchio
Davide Carnevali | Il dottor Faust al 1° maggio
Davide Carnevali | Orlando decentrato e Angelica furiosa
Davide Carnevali | Alla guerra in nome di Godot
Davide Carnevali | Medea: un caso di cronaca nera
Davide Carnevali | Goldoni dalla villeggiatura alla fashion week
Davide Carnevali | Ibsen: amici e nemici del popolo
Davide Carnevali | Pier Paolo Pilade: la resistenza della minoranza
Davide Carnevali | Un pranzo di Natale lungo una vita
In copertina, opera © Christiane Spangsberg.