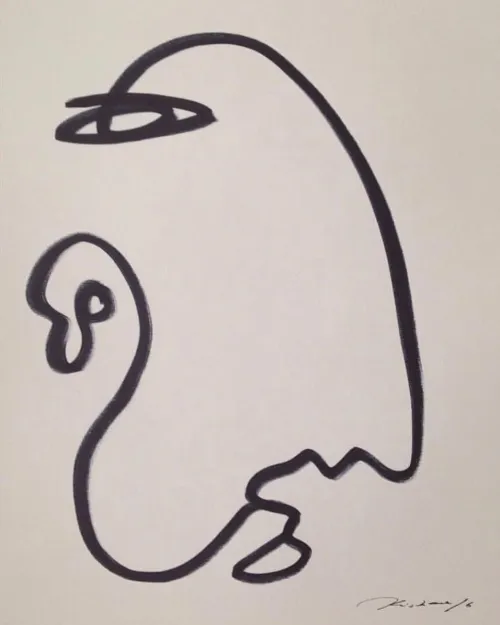Speciale
Il dottor Faust al 1° maggio
Mentre camminavo questo pomeriggio per le vie di Fredrickstad, una tranquilla cittadina della Norvegia meridionale a pochi chilometri dalla frontiera svedese, ho notato che i bar esponevano lavagne e cartelli per ricordare agli avventori l’eccezionalità della serata: oggi è il 30 di aprile e al calar del sole si entrerà nella notte di Valpurga. In realtà la festa non fa propriamente parte delle tradizioni norrene ed è molto più sentita oltre confine, nell’area baltica; ma ogni scusa è buona per invitare la gente a bersi qualche birretta – e pensate che una media alla spina qui costa circa 18 €. Non c’è da stupirsi che la globalizzazione di mercati e culture abbia ingloba(lizza)to anche un fenomeno generalmente dotato di carattere locale come quello della festa; oggi le celebrazioni si esportano e si importano, si moltiplicano e si sfruttano il più possibile, come qualsiasi bene e servizio. Quando ero bambino, per esempio, Halloween era solamente il titolo di un film horror di John Carpenter; ora invece è uno degli innumerevoli eventi brandizzati, che costellano un calendario intasato quasi come quello della UEFA.
La notte di Valpurga deve il suo nome alla monaca Walburg di Heidenheim, che nella cittadina bavarese aveva fondato e retto come badessa un monastero di benedettine. Essendo morta in odore di santità, le sue spoglie vennero deposte in una piccola chiesa a qualche chilometro di distanza, il primo giorno di maggio. Da qui il suo inserimento nel ciclo liturgico e l’occasione per la Romana Chiesa di appropriarsi di una festività pagana già in voga, che celebrava proprio in quei giorni l’inizio della primavera. Metter le mani sulle ricorrenze popolari è stata un’operazione fondamentale nel processo di cristianizzazione della mitteleuropa, dove i culti precedenti, soprattutto quelli celtici, erano difficili da estirpare. La gente non rinuncia mai volentieri a un giorno di riposo, e ancor meno a una celebrazione che dovrebbe propiziare il raccolto; meglio dunque lasciare tutto com’è, ma conferendo alla solennità un nuovo nome e un nuovo inquadramento. Così gli eventi più rilevanti dell’attività agricola, come gli equinozi e i solstizi, l’inizio della semina o il termine del raccolto, l’arrivo della primavera o l’ingresso nell’inverno, sono stati progressivamente posti sotto la rassicurante egida di vegliardi eremiti e pulcre vergini, che in qualche modo ne facessero da garanti e controllori. Intendiamoci: non è certo questa un’esclusività ecclesiastica; da sempre, chi prende il potere impone agli sconfitti le sue forme e i suoi nomi. L’Orestea di Eschilo si chiude quando le Erinni cambiano nome in Eumenidi, e da ancestrali (e incontrollabili) divinità della vendetta, assurgono il nuovo ruolo di benevole garanti della giustizia, sotto la supervisione della razionalissima dea Atena. Friedrich Schelling, nella sua Estetica, faceva notare che gli dèi omerici sono fondamentalmente spiriti della natura che hanno bisogno di una mitografia per essere resi immortali; mentre sante e santi cristiani sono entità immortali che hanno bisogno di appoggiarsi alle cose del mondo per partecipare della nostra quotidianità. C’è un patrono per ogni cosa e ben più di una santa o un beato per ogni giorno del calendario, in modo che il ciclo vitale dell’essere umano e della natura sia coperto in ogni suo aspetto, tutti i giorni di tutto l’anno.
Nel Castello del Buonconsiglio di Trento, all’interno della Torre Aquila, è ancora possibile ammirare un meraviglioso affresco della fine del quattordicesimo secolo che rappresenta il Ciclo dei mesi. Nei tre riquadri dedicati alla primavera, tra aprile e giugno, si osserva un gruppo di giovani prepararsi per la festa, ornandosi di fiori e ghirlande, preceduto da alcuni suonatori; il corteo è aperto da un chierico che va sottobraccio a quella che sembra, per le vesti e il portamento, una dama; ma sotto il cui velo spunta il volto barbuto di un uomo. L’audioguida del museo suggerisce che la barba sia stata dipinta successivamente da una caritatevole mano, per non mettere troppo in imbarazzo il canonico; ma in realtà non c’è nulla di strano in un uomo vestito da donna, perché quella che vediamo rappresentata è in realtà una scena teatrale, e il teatro è stato per molto tempo cosa da uomini (ancora all’epoca di Shakespeare, una donna sul palco sarebbe stato uno scandalo). Che tra festività e teatro ci sia un vincolo primordiale è cosa nota, e ne abbiamo già accennato nelle puntate precedenti; ma è soprattutto nell’età media che certe forme celebrative, certi gesti simbolici, certe formule poetiche iniziano a configurarsi come vere e proprie azioni drammatiche, basate su copioni preparati a tavolino. La composizione e recitazione dei versi avveniva solitamente nell’ambito di una confraternita o associazione; in molti casi si trattava di contadini, come nei bruscelli toscani: un teatro popolare cantato, in cui i bruscellanti andavano in giro di podere in podere con il loro palo o arbusto da piantare nel luogo che si adibiva a scena. Anche i nostri calendimaggio – che derivano dalle calende romane in cui si celebravano le Floralia in onore della dea della vegetazione – gli uomini portavano alla finestra della loro innamorata un ramo a cui erano appesi ornamenti e doni, accompagnandosi con canti e strofe recitate, che costituivano l’essenza di un rituale di corteggiamento. Promesse di fidanzamento e riti nuziali si svolgevano in primavera perché legati alla rinascita della natura, e quindi alla fertilità, ed erano propiziatori di abbondanza e benessere.
La figura del portatore di ramo rimanda a quella di uno spiritello dei boschi dai cristiani identificato con un dispettoso diavoletto, ma che in realtà era chiamato apotropaicamente Robin Goodfellow, o Robin dei boschi, cioè Robin Wood, o Hood; a cui, alla fine del XIII secolo, il poeta e trovatore Adam de la Halle dedica il suo Le jeu de Robin et Marion, che si può considerare uno dei primi esempi di teatro profano. Anche il nostro Arlecchino è, in origine, una creatura infernale della natura, legata probabilmente al solstizio d’inverno, quando nell’emisfero boreale le notti sono più lunghe e l’oscurità più ostile. Il suo nome è germanico e indica il re dell’inferno, l’Hölle König; Dante, che lo chiama già Alichino, si è divertito a inserirlo nella schiera delle Malebranche, nel canto XXI dell’Inferno. È dunque nell’ambito delle celebrazioni agricole, che va ricercata l’origine delle maschere della nostra commedia dell’arte e lo sviluppo di certi tipi fissi che più avanti prenderanno la forma di veri e propri personaggi. Per esempio, quelle figure così spiccatamente comiche che Shakespeare battezzerà come Puck, Ariel, Calibano, Bottom, Feste, Falstaff e intorno a cui costruirà la sua figura prediletta, quella del fool.
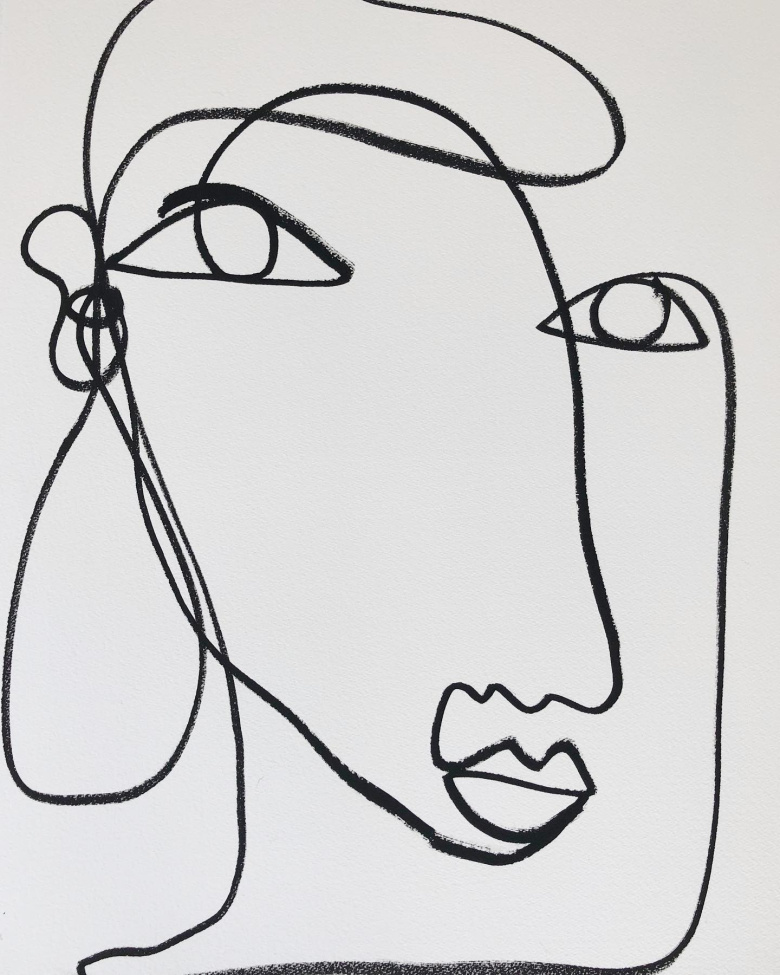
Questo patrimonio folklorico è recuperato ben volentieri dalla letteratura germanica nella seconda metà del ‘700, alla ricerca di un’identità culturale che fondamenti una non ancora raggiunta identità nazionale. È lì che si vivifica quella dialettica tra paganesimo e cristianesimo che troviamo incarnata in una delle coppie più immortali – è proprio il caso di dirlo – della letteratura universale: Faust e Mefistofele. Tutto il Faust di Goethe è popolato da un’infinità di creature e spiritelli, che si muovono loro malgrado all’interno di un universo cristiano che pare star loro sempre un po’ troppo stretto. Un bell’esempio di tutto questo lo troverete nelle meravigliose pagine che il nostro ecletticissimo autore dedica – pensate un po’ – alla notte di Valpurga. Accade quando Mefistofele conduce Faust sul monte Brocken (la più alta vetta dell’Harz, nel centro geografico della Germania), per assistere al gran sabba delle streghe che si celebra a mezzanotte. Certo, un evento di tale portata attira pubblico da ogni dove; così, all’ingresso del valico, i nostri restano intasati in un traffico infernale di stregoni e streghe a cavallo di rumorosissime scrofe. La cosa infastidisce non poco Mefistofele che, a dispetto della sua natura, non ha proprio voglia di mischiarsi con quella marmaglia chiassosa. È un diavolo, sì; ma pur sempre un diavolo colto, e la massa non fa per lui: «Stiamocene qui un attimo in pace – intima a Faust – che da sempre l’uomo prova piacere a ricavarsi nel gran mondo il suo piccolo mondo». Il che ci dice forse poco della vera natura del demonio, ma molto della vera natura dell’intellettuale.
Faust e Mefistofele non sono però gli unici, quella notte, a starsene in disparte. Tra le prime persone che i nostri incontrano sulla vetta, c’è un piccolo gruppetto di anziani: un generale, un ministro, un nuovo ricco e un autore. Se la composizione del gruppo non vi sembra emblematica, non so che dirvi... Ma ancor più emblematico è il fatto che tutti e quattro si lamentano di come vada male il mondo ai tempi loro. Il generale piange l’oblio in cui è caduto chi una volta ha combattuto per la patria; il ministro è stizzito per l’ingratitudine verso chi ha fatto, con la sua politica, la ricchezza del paese; il ricco si lagna della fortuna che va e viene troppo rapidamente; e l’autore... beh, indovinate un po’ per cosa potrebbe mai frignare un autore...? Ecco la prevedibile risposta: i giovani d’oggi non leggono più libri! – e vi faccio notare che la prima parte del Faust esce nel 1808. Di fronte a queste sconcertanti banalità, anche Mefistofele vorrebbe passare oltre; ma viene tosto arpionato da una pulzella che cerca disperatamente di vendergli un pugnale insanguinato con cui è stato commesso un efferato assassinio, una tazza in cui è stato somministrato un veleno, e altre cianfrusaglie a guisa di souvenir. Al che Faust, dotato di un certo guizzo intuitivo, inizia a realizzare che tutto quello che circonda il grande sabba infernale non è altro che una grande fiera; e siccome i nostri due non hanno proprio l’aria di stregoni locali, devono essere evidentemente dei visitatori... Insomma, Faust si rende conto che il Brocken si sta gentrificando, e la notte di Valpurga è diventata né più né meno che un’attrazione per turisti.
E infatti, a riprova indiscutibile di questa depravata commercializzazione delle cose sacre, sulla vetta del Brocken compare addirittura un teatro, manco fossimo al Prater di Vienna. Va in scena quella sera, come in una visione onirica, una rappresentazione delle nozze di Oberon e Titania, re e regina delle fate e degli spiriti del bosco. È una fantasmagoria che ricorda molto il Sogno di una notte di mezza estate shakespeariano, e infatti ci troviamo Puck, ma pure l’Ariel di La tempesta, e tutta una serie di figure di cui avete letto prima. E lì, in mezzo a questo calderone di personaggi, Faust vedrà anche Margherita in catene: l’oggetto del suo amore che lui, per soddisfare il suo desiderio, ha condannato alla perdizione. Da vero uomo qual è, evitando di assumersi la sua responsabilità, Faust subito incolpa Mefistofele della sorte di lei. Al che, il povero diavolo, ben conscio dell’incapacità umana di sostenere l’insostenibile peso del desiderio irrazionale, rinfaccia al dottore di volersi immischiare con le forze demoniache senza accettarne le conseguenze: «Pretendi di volare e quando vai su ti gira la testa». Come a dire: perché cerchi una logica in ciò che logico non è? Eppure noi, come Faust, ci prodighiamo spesso in questo vano tentativo.
Per i servitori di Lucifero, il vero peccato è razionalizzare l’irrazionale. Ce lo fa notare ancora un gruppetto di fantasmi (del passato) che deplora il modo in cui le streghe danzano oggidì: passi contati e cadenzati, movimento studiato e coreografato... Ma come?! Un sabba non dovrebbe essere, al contrario, un andirivieni sfrenato senza capo né coda...? Un’estasi orgiastica o qualcosa di simile...? Già, la festa dovrebbe essere quel momento extra-ordinario che si inserisce all’interno del calendario come una deroga, permettendo di recuperare un’esperienza della vita che non sia condizionata dal quotidiano ritmo dell’economia. Nel momento in cui diventa essa stessa parte di quel ciclo economico, qualcosa della sua natura si snatura: la festa dev’essere un’eccezione alla regola, non una regolamentazione dell’eccezionalità. Ecco perché forse l’unica vera festa che ancora oggi mantiene realmente la sua carica rivoluzionaria, presentandosi come un’anomalia alla norma, è quella solennità laica che santifica il lavoro proprio attraverso la sua astensione. La festa che i lavoratori festeggiano non lavorando, smettendo per un giorno di essere ciò che consacrano; quella che in quasi tutto il mondo si celebra notoriamente dopo la notte di Valpurga, e cioè il 1° maggio.
Per saperne di più
Il filologo e folklorista Paolo Toschi ha scritto delle cose molto interessanti sul rapporto tra festa e rappresentazione, in particolare in Le origini del teatro italiano, che trovate edito prima da Einaudi e poi da Bollati Boringhieri. Appena avete un po’ di tempo, il Faust di Goethe merita di essere letto tutto, anche perché la seconda parte, che è quella meno nota, è anche la più sorprendente. Se invece vi interessano streghe e stregoni, non sarò certo io a dirvi dove andare a pescarle; ma potrei consigliarvi di dare un occhio ai disegni di Goya e un orecchio a Johannes Brahms, che nel 1878 ha musicato il poemetto Walpurgisnacht, di Willibald Alexis.
Leggi anche:
Davide Carnevali | Creonte e la tragedia della politica
Davide Carnevali | Il primo Sosia
Davide Carnevali | Il Ricco Trump e il Povero Zelensky
Davide Carnevali | Amleto: lo schermo e lo specchio
In copertina, opera © Christiane Spangsberg.