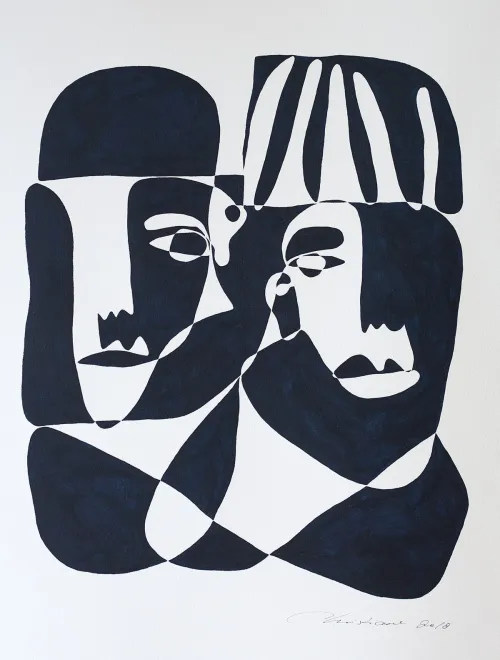Speciale
Goldoni dalla villeggiatura alla fashion week
In quest’estate orfana di tormentoni musicali e grandi colpi di calciomercato, la vera hit del mese d’agosto è stata una lamentatio collettiva che manco il coro dei Persiani di Eschilo. Quella sugli stabilimenti balneari ha visto intonare canto e controcanto di utenti e proprietari: i primi che si lagnavano del drastico aumento dei prezzi, e i secondi della diminuzione drastica di clienti nei loro piccoli ma preziosi fazzoletti di sabbia. Una vera tragedia, insomma, che smaschera tutte le miserie di un’economia dello svago balneare che non si sostiene più. La verità è che quello della privatizzazione delle spiagge è un sistema che fa più pena di un pianto funebre; e che, proprio come un pianto funebre, accompagna tristemente la morte di un qualcosa di amato e caro (anzi, ormai carissimo): le gioie della villeggiatura. Che siano diventate un privilegio per pochi, non dovrebbe stupirci più di tanto: tutto era iniziato con quella pratica così genuinamente aristocratica dell’abbandonare la mondanità estenuante dell’urbe per recarsi in villa, cioè in campagna. Un’arcadia che in tempi più moderni inizierà a competere con i pittoreschi promontori costieri, dove si respira un’aria più salubre che nell’industrializzata città. Con la diffusione dell’auto nel secondo dopoguerra, dai bagni di mare ai bagni di folla il passo è breve; e così, per distinguersi dal popolino, l’aristocrazia cittadina ha dovuto rinnovare di volta in volta la favola del turismo di lusso in destinazioni esclusive. E il popolo, che non vuol mai essere da meno, ne ha seguito la scia, in una rincorsa inflazionistica che ci porta oggi a pagare prezzi milanesi per due metri quadri di lido, o occupare il bagnasciuga salvo poi essere sgomberati come il Leoncavallo, oppure impazzire per trovare una spiaggia libera: il relax provoca strex (con la x, perché il senso di tutto questo resta un’incognita). Ma anche questa non è una novità dell’estate 2025: niente di nuovo sotto il sole.
È il 1761, quando Carlo Goldoni consegna al Teatro San Luca Le smanie per la villeggiatura, prima parte di quella Trilogia che chiude la bella stagione veneziana prima dell’espatrio in Francia, che sarà invece l’autunno e l’inverno della sua movimentata vita. In scena, i preparativi pre-partenza di due esponenti della buona borghesia livornese (vuoi mica che nella Serenissima qualcuno si offenda?); preparativi che, come suggerisce il titolo, sono contraddistinti da una certa dose di affanni e preoccupazioni, quasi tutte di ordine economico. Leonardo e Vittoria, fratello e sorella, si indebitano costantemente per mantenere un tenore di vita al di sopra delle loro possibilità; e con l’arrivo dell’estate devono ora trovare il modo e i soldi per villeggiare nell’esclusiva località di Montenero. Qui soggiorna anche il ricco signor Filippo, di cui Leonardo vorrebbe impalmare la figlia Giacinta, dotata di una cospicua dote. Per Vittoria sarà invece l’occasione di mostrarsi in pubblico indossando un vestito nuovo, perché «la mancanza di un abito alla moda può far perder il credito [notate il fine doppiosenso goldoniano] a chi ha fama di essere di buon gusto». Il buon senso, invece, incarnato dal servo Paolo, suggerirebbe loro di lasciar perdere, che non sono obbligati a far quel che fanno i grandi marchesi, che hanno tenute e grandi ricchezze... Ma che senso avrebbe seguire il senso comune, se si vuol apparire fuori dal comune? Per cui i nostri si preparano ad aumentare il loro “credito”, spendendo anche quei pochi soldi che non hanno, pur di partire e farsi il vestito.
I personaggi che affollano la commedia – chiosa l’autore nella sua introduzione – «sono di quell’ordine di persone che ho voluto prendere precisamente di mira; cioè di un rango civile, non nobile e non ricco [...]. L’ambizione de’ piccioli vuol figurare coi grandi, e questo è il ridicolo ch’io ho cercato di porre in veduta, per correggerlo, se fia possibile». Al di là della pia vocazione pedagogica di stampo illuministico, Goldoni mette alla berlina l’ambizione di quei piccoloborghesi che non hanno i mezzi per fare quello che fanno “i grandi”; e che però si comportano come se grandi lo fossero, sulla scorta di un furore mimetico che sembra suggerire loro che essere equivale ad apparire. Ma quelle brevi righe sono interessanti anche perché, oltre alle intenzioni dell’autore, ci aiutano a capire la mentalità del suo pubblico. La prima cosa che salta all’occhio è che i ricchi esponenti della grande borghesia sono equiparati ai nobili; anzi: sono la ormai vera classe nobiliare. In una Repubblica amministrata da grandi famiglie dell’oligarchia finanziaria, in cui la libertà di azione è garantita dal liberalismo mercantile, la nobiltà è effettivamente quella degli schei, degli zecchini. In tal modo ragiona quel patriziato veneziano che forse non sarà più quello dei bei tempi andati (Campoformio è alle porte), ma che mantiene comunque un certo status; o, almeno, vuole credere e far credere di mantenerlo. Per esempio, sovvenzionando generosamente quei teatri privati per cui Goldoni scrive; perché questa borghesia ha – so che vi sembrerà strano – un estremo bisogno del teatro. Il teatro era un momento fondamentale della vita pubblica: lì si incontravano l’amata o l’amante o il partner commerciale, si facevano affari, si stipulavano accordi politici, si congiurava... e, soprattutto, si appariva. L’edificio teatrale, per l’alta borghesia, era un unico grande scenario. Per cui, ciò che si presentava in commedia non era solo uno specchio della vita quotidiana; era anche uno specchio del teatro stesso, di ciò che stava accadendo nei palchi e in platea in quel preciso momento: a teatro, la borghesia vedeva se stessa in diretta.
Il pubblico goldoniano è un pubblico che gode della propria immagine, perché il borghese del secolo XVIII è affetto non solo da smanie, ma anche e soprattutto da manie di protagonismo. Comprensibile, per una classe sociale la cui identità è ancora in via di definizione, e che brama fino allo struggimento quel riconoscimento che ancora non le è concesso. D’altra parte la tragedia metteva in scena le imprese di grandi eroi ed eroine, apoteosiche saghe di re e regine, mentre la commedia restituiva il popolo al popolo; ma il facoltoso mercante e il bottegaio arricchito non si riconoscevano né nella nobiltà di cappa e spada, né nel volgo volgare che brulica nelle campagne. E dunque la grande aspirazione della borghesia del Settecento, dopo aver consolidato il controllo sui mezzi di produzione, è quella di controllare anche i mezzi di rappresentazione estetica; che poi è il primo passo per il controllo dei mezzi di rappresentazione politica: proprio come vorrebbe qualcuno che la rappresentasse degnamente in parlamento, così vorrebbe qualcuno che la rappresentasse degnamente a teatro. Goldoni, che quella borghesia la conosce bene, perché ci sguazza dentro, ci riesce brillantemente. Anche se forse la dolce vita veneziana lo mantiene ancorato, un po’ anacronisticamente, a una visione ancien régime della società: ai suoi occhi la grande borghesia appare ancora come una piccola nobiltà. Non si è del tutto reso conto che quei benestanti di rango civile, su cui paternalisticamente satireggia, in Europa stanno crescendo e accrescendo il loro peso politico; fino a diventare protagonisti di quella grande rivoluzione che, qualche anno dopo, nel 1789, lo coglierà a Parigi totalmente impreparato. Nemesi storica: saranno proprio loro a sospendergli la pensione che Luigi XV gli aveva concesso, lasciandolo negli ultimi anni di vita in precarie condizioni economiche, e facendolo morire pressoché in miseria.
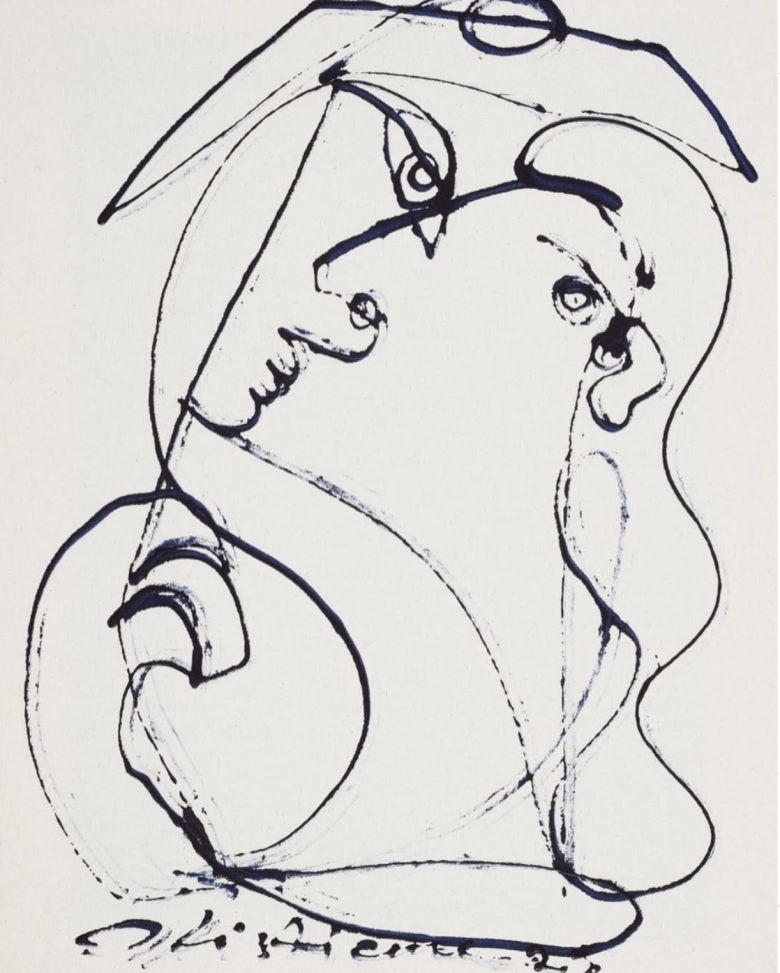
Così, mentre in Germania Lessing e Schiller provano a borghesizzare la tragedia, aprendo la strada al dramma moderno, Goldoni segue ancora le tracce di Molière, scegliendo la commedia per mettere in scena il modus vivendi del ceto medio; da qui, la naturale esigenza di rinnovare il genere, innalzando il comico a strumento di critica sociale. Quando si parla di “riforma goldoniana”, ci si riferisce al cambio radicale che il nostro impone alla Commedia dell’Arte, trasformandola in commedia di carattere. È quel processo per cui le maschere (Arlecchino, Colombina, Brighella, Pantalone e compagnia), che erano fondamentalmente tipi – cioè stereotipi – comici, cominciano a lasciare spazio a personaggi con una psicologia propria. Cos’è la psicologia di un personaggio? Il pensiero che sta dietro le sue decisioni, le sue azioni e le sue parole: perché fa questa cosa, perché pronuncia proprio queste parole, quali aspetti della sua personalità giustificano che si comporti in un certo modo...? Aristotele sosteneva che i caratteri sono la concretizzazione delle loro scelte e propositi; Goldoni, nel prologo sopracitato, parla più propriamente di “ambizioni”, desideri. Volere di più: è questo moto dell’animo verso un futuro che si promette carico di benessere, ciò che per secoli ha reso la borghesia il propulsore del progresso e dell’economia europei. Desiderare, progettare, investire... spendere; perché l’economia funziona quando circola denaro, i prezzi salgono e si sborsa abbondantemente – o, meglio ancora, ci si indebita. Spendere permette di illudere se stessi e gli altri che il proprio desiderio è realizzabile, sempre e in qualsiasi momento; ecco il significato profondo di quello stare “al passo con i tempi” che trova nella moda la sua espressione più appariscente e alienante – spingendo la nostra fashion victim Vittoria a fare dell’esigenza di un vestito nuovo una questione identitaria. Ora: non dobbiamo certo aspettare Marx (che nascerà di lì a poco), per capire che quel “volere di più” ha i suoi risvolti perversi. Volere più cose, fama, denaro significa volere sempre più cose, fama, denaro... E, se è vero che quella della crescita infinita è solo una favola con cui il capitalismo addormenta le coscienze, allora quell’ambizione che Goldoni mette in scena non è solo ridicola, ma anche terribilmente autodistruttiva. Perché implica, per il soggetto, non solo il desiderio di avere sempre più di quel che ha; ma anche la necessità di essere sempre altro da quello che è. La borghesia si contraddistingue dunque per questa sorta di dissociazione, che costituisce la base della sua caratterizzazione comica; e, al contempo, tragica.
Ecco dove ha origine l’indole schizofrenica di una classe che, se da un lato vorrebbe poter fissare il suo valore in una congrua rappresentazione di sé (a volte basta un selfie), dall’altro vorrebbe costantemente rinnovare quella rappresentazione (no, un selfie non basta mai); se da un lato ha l’obiettivo di accumulare ricchezza per scalare le classifiche, dall’altro ha l’obbligo di dissiparla per mantenersi al top. Così il desiderio del nuovo, mentre attizzava la fiamma del progresso, alimentava anche il fuoco dell’insoddisfazione e della frustrazione personali. La Trilogia della villeggiatura è la storia di come Leonardo e Vittoria ne fanno le spese, vittime di quel crudele miraggio per cui l’oggetto del desiderio, che è tale proprio perché appartenente alla sfera dell’irraggiungibile, deve però apparire sempre “alla nostra portata”. Che poi – viene in mente in questi giorni – non è forse la stessa ambigua promessa con cui il prêt-à-porter milanese degli anni ’80 rivoluzionò il mondo della moda...? In fondo, il sogno della democratizzazione della haute couture è in qualche modo il rovescio di una medaglia il cui diritto è quell’assurdo fenomeno per cui oggi lettino, ombrellone e fritto misto al chiringuito sono proposti come un bene di lusso, nel miraggio paradossale che il lusso sia appunto alla portata di tutti: ma se diventa alla portata di tutti, che lusso è?! Qualcosa è andato storto quando abbiamo cominciato a confondere un mondo senza povertà con un mondo in cui tutti possono essere ricchi, dimenticando che il ricco è ricco proprio perché esiste un povero. È un po’ la contraddizione con cui dobbiamo fare i conti quando, alla ricerca di una meta esclusiva per il fine settimana o le ferie, ci ritroviamo inclusi in una massa abnorme di persone che si erano messe alla ricerca della medesima esclusività. Se oggi abbiamo l’impressione – è solo un’impressione – di vivere in una società senza classi, non è perché il proletariato, come profetizzava il filosofo tedesco, abbia preso definitivamente il potere; ma perché, come suggeriva il nostro commediografo veneziano, volendo a tutti costi apparire altro da quello che è, il proletariato preferisce assumere dovunque le attraenti sembianze della borghesia.
Sì, lo so, viene quasi da piangere; ma questo unhappy end non si addice al nostro mood goldoniano. E allora torniamo alla spensieratezza della Trilogia, che si chiude con il ritorno in città, in attesa della prossima fuga vacanziera. A proiettarci oltre l’insostenibile pesantezza del rientro, sarà l’imminente Fashion Week (la prima senza il più alto rappresentante della borgaristocrazia milanese, il Cittadino Re Giorgio), che settimana prossima ci renderà edotti su come dovremo vestirci per la villeggiatura del 2026. Lasciamoci così, con il fremente desiderio di un futuro che anticipa il presente non ancora consumato; e anche se non ci è dato sapere quanto costerà esattamente il vestito nuovo per l’anno prossimo, possiamo almeno consolarci con una certezza: come constata il sagace signor Filippo alla fine del primo atto delle Smanie, «lo spendere è sempre stato alla moda».
Per saperne di più
La Trilogia della villeggiatura, pubblicata a iosa e trovabilissima dovunque, si legge in un’oretta e mezza, il tempo di un viaggio in treno per un weekend fuori porta. Più impegnativa è la lettura dei corposi Mémoires nei Meridiani Mondadori; ma ne esiste anche un’agile versione in forma di copione, firmata da Giorgio Strehler negli anni ’70 per uno sceneggiato RAI che mai si fece, edita da Marsilio. Io consiglierei però soprattutto le Memorie italiane, scritti autobiografici che Goldoni aveva pensato come prologo delle edizioni dei suoi testi, in cui emerge chiaramente come la vita privata dell’autore sia da spunto alle sue situazioni comiche. Per chiudere: sempre bello quello che dice Roland Barthes riguardo Il senso della moda: articoli, saggi, ritagli e scampoli, raccolti e cuciti insieme da Einaudi.
Leggi anche:
Davide Carnevali | Creonte e la tragedia della politica
Davide Carnevali | Il primo Sosia
Davide Carnevali | Il Ricco Trump e il Povero Zelensky
Davide Carnevali | Amleto: lo schermo e lo specchio
Davide Carnevali | Il dottor Faust al 1° maggio
Davide Carnevali | Orlando decentrato e Angelica furiosa
Davide Carnevali | Alla guerra in nome di Godot
Davide Carnevali | Medea: un caso di cronaca nera
In copertina, opera © Christiane Spangsberg.