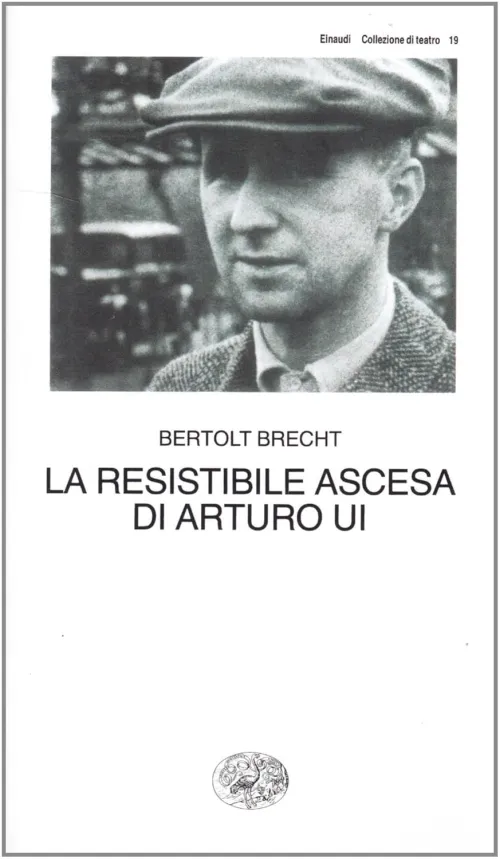Speciale
Brecht e la resistibile ascesa di ogni fascismo
«C’è un quadro di Paul Klee che si intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della Storia deve avere questo aspetto». Così inizia la più celebre delle Tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin, la numero 9. Siamo nel 1939, i fascismi europei sono al loro auge e il filosofo tedesco prende sorprendentemente a prestito dalla teologia la figura del messaggero divino, per costruire la sua immagine ideale dello storico materialista. Ora, se date un occhio all’acquarello del pittore svizzero, noterete che l’angelo non ha per nulla l’apparenza di un angelo. Il suo aspetto è terribile, lontano anni luce da quello di uno sbarazzino putto raffaellesco, un cherubino rubensiano paffutello o un rassicurante profilo meloniano con i biondi capelli al vento. Quello di Klee sembra piuttosto un mostro; con questi occhi spalancati che ricordano quelli di Alex DeLarge in Arancia meccanica, quando con le pinze sulle palpebre è costretto ad assistere senza batter ciglio a una serie inenarrabile di violenze. Un’immagine non poi così distante da quella che si riflette nelle pupille del nostro angelo, che infatti appare piuttosto turbato da quel che vede: una catastrofe dietro l’altra. È questa l’immagine del passato che dovrebbe fissarsi nella mente di ogni buon storico: il percorso che ci ha portato fino a qui si è costruito solo al prezzo di accumulare dietro di noi un cumulo di rovine.

La Storia non è una logica catena di avvenimenti tutti volti a un avvenire luminoso, né il dispiegarsi caparbio di una Provvidenza che ci chiede spazio per fare il suo corso; ma il risultato concreto di azioni umane: le nostre azioni, di cui non possiamo non essere responsabili. Un percorso a ostacoli costellato di conflitti, che lasciano sul terreno vittime; la nostra responsabilità si dà proprio nei confronti di queste vittime, che i vincitori tendono a bollare come “necessarie” e quindi “dimenticabili” – perché la Storia altro non è se non la narrazione che i vincitori fanno del passato. Osservare con sguardo critico il passato, perché non cada preda dell’uso interessato che ne fanno i vincitori nel presente: è questa la scandalosa richiesta dell’angelo, che ci invita a mettere in discussione ogni narrazione che si erge come egemonica e si pretende come unica, per salvare la memoria dei vinti e ridare voce agli esclusi. L’interesse per la Storia come oggetto di indagine, così come l’idea che non possiamo essere meri spettatori passivi degli accadimenti, ma dobbiamo farli oggetto di un’analisi storico-scientifica eticamente responsabile, sono inquietudini legittime che Benjamin condivide con un altro giovane intellettuale marxista conosciuto qualche anno prima a Berlino, e che ha finito per farsi amico: Bertolt Brecht.

Il drammaturgo di Augsburg mira a fare del suo pubblico un critico; perché se la Storia è un fatto umano e non trascendente, io essere umano ho sempre la possibilità di comprendere come funziona, e quindi di cambiare il suo corso. Nel mostrare al pubblico una storia, occorre pertanto mostrare anche il suo funzionamento: perché le cose stanno andando così? Cosa ha spinto un personaggio a fare quel che ha fatto? Cosa vogliono veramente dire le sue parole? La drammaturgia brechtiana è in fin dei conti un’indagine sui meccanismi che regolano lo sviluppo della Storia e delle storie; e, naturalmente, sui conseguenti effetti sul pubblico che le riceve. Perché, in fondo, a chi non piace perdersi in una buona storia? Oggi più di allora siamo assuefatti a narrazioni, macro e micro: dalle serie pluristagionali su Netflix, ai brevi slogan pubblicitari nella metro; dal romanzo che leggiamo prima di addormentarci, agli highlights della serie A su Dazn (avete notato come i primi quindici secondi siano dedicati a presentare la partita come una sorta di combattimento epico?); per non parlare dei reel e, appunto, delle stories sui social – scontatissimo, lo so. Le storie generano emozioni, e quindi identificazione: ci sentiamo un po’ anche noi come i protagonisti e le protagoniste delle finzioni che assumiamo nella nostra vita reale e virtuale – che è poi lo stesso principio che provoca il godimento del follower nel seguire l’influencer. Aristotele la chiamava “catarsi”; noi oggi sappiamo che molto dipende dai neuroni specchio; in ogni caso, la mimesis implica sempre un’empatia legata a un impulso imitativo. Ma se ogni storia è sempre una narrazione soggettiva, allora immedesimarsi in una storia significa aderire alla visione di chi la racconta; cioè: di chi ha il potere di raccontarla; e tutto l’interesse a raccontarla in un determinato modo.
Ogni totalitarismo giustifica il proprio potere autoproclamandosi come necessario alla Storia: è il mito del salvatore o salvatrice della patria, senza il cui intervento (autoritario) “questo paese andrebbe a rotoli”. I fascismi del secolo scorso vedevano se stessi come gli attesi restauratori di un passato glorioso, il cui splendore andava recuperato a ogni costo – soprattutto in tempi oscuri di caos politico e miseria economica, contro i quali si ergevano come l’unico rimedio possibile. È questa la narrazione interessata di un potere che dipende intimamente dall’immagine che di sé offre, e per la cui costruzione non lesina a impiegare gli strumenti classici della drammaturgia. Pensate all’uso della teatralità che hanno fatto i fascismi: l’organizzazione di grandi manifestazioni di massa, in cui il pubblico, incantato dalla magnificenza dell’apparato scenografico, si sente parte integrante di una coreografia del potere; la manipolazione dell’informazione, con il fine di celebrare le proprie gesta e denigrare le malefatte dell’avversario; e, soprattutto, la costruzione di personaggi degni di ammirazione e imitazione, intorno ai quali si crea un culto messianico dell’eletto, della guida, del comandante in capo. Di un dux, un Führer, un caudillo... Non è poi così strano, se ci pensate: venivamo dalla prima guerra mondiale, dal sacrificio per la patria e il buon soldato che segue ciecamente gli ordini del suo generale. E di capetti militari che si mettono a fare politica, è piena la Storia; lo dimostrano ancora le dittature sudamericane della seconda metà del Novecento e le più recenti velleità degli expats leghisti.
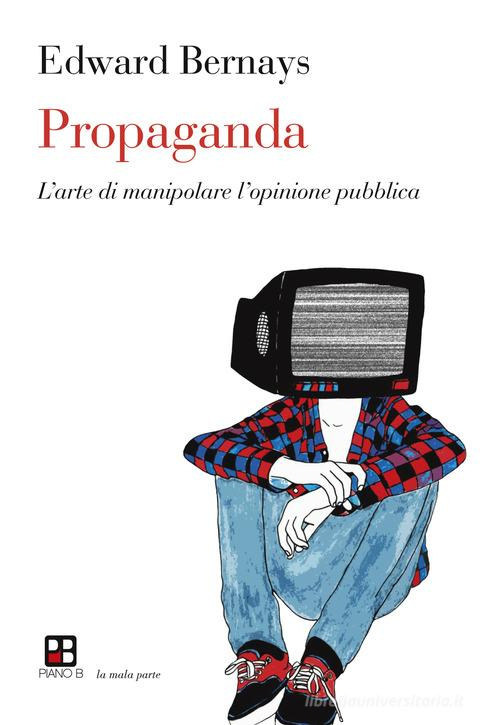
Affinché intorno a questi personaggi si generi un’aura di sacralità, l’esposizione pubblica, cioè al pubblico, è fondamentale. Dopotutto il personaggio – dicevamo il mese scorso – non è forse pura fenomenologia scenica? Un’entità che è come appare; o meglio è perché appare – e, più appare, più è. Il culto della personalità nei totalitarismi del Novecento, da Mussolini a Hitler, da Franco a Stalin, non si spiega senza l’importanza che ha assunto il concetto di persuasione, intimamente legato agli studi sulla pubblicità che andavano proliferando con l’espansione del modello economico capitalista. Nel 1928 era uscito un celebre saggio dal titolo Propaganda, di Edward Bernays (un nipote di Freud – pensate un po’!), sulle tecniche di manipolazione del desiderio delle masse. E per convincere le masse, ogni grande personaggio ha bisogno di una grande storia. Sarà pertanto necessario avere una grande influenza, o direttamente un grande controllo, dei media a disposizione. Una volta era la stampa, il cinema, la radio; poi è stata la televisione, poi internet; oggi con l’intelligenza artificiale possiamo riprodurre artificialmente la voce di qualcuno, oppure modificare fotografie, per giustificare un intervento dell’esercito. Ora come allora, è evidente che per fare politica bisogna essere dotati di una grande capacità comunicativa e un grande dipartimento di comunicazione. E sappiamo bene che la miglior pubblicità è quella che riesce a ottenere il suo scopo senza rivelare la propria presenza.
In un altro celebre saggio, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Benjamin parla della perdita dell’aura in relazione al nuovo modo di produzione e consumo dell’arte nell’era industriale. L’opera d’arte diventa prodotto artistico; e il guizzo del genio romantico, semplicemente un sapere tecnico: l’artista non è un essere super-umano staccato dal mondo e dai suoi simili, ma un buon artigiano esperto nel suo campo. Anche l’attore, l’attrice – si premura di ricordarci Brecht – non sono che bravi tecnici, e i loro personaggi sono in qualche modo il mero prodotto artigianale di una pratica ben affinata. Idem, quindi, per il personaggio pubblico, il politico; la cui aura può venir meno quando la sua origine è strappata al terreno prima inviolabile della sacralità, per essere ricondotta al più profano campo del marketing. Questa la chiave di lettura dell’operazione che Brecht compie nel 1941, quando con La resistibile ascesa di Arturo Ui mette in scena una parodia della presa di potere di Hitler, spostando l’azione da Berlino a Chicago e metaforizzando l’ascesa del partito nazionalsocialista nella sanguinosa guerra dei gangster per il controllo del racket dei cavolfiori. Nella scena VII, Arturo Ui si sincera con i suoi scagnozzi: «Mi hanno fatto capire che la mia pronuncia lascia a desiderare. E giacché non potrò evitare una volta o l’altra di dire qualche parola, specie in periodo di politica, voglio prendere lezioni. Anche di portamento». Convocano così un vecchio attore shakespeariano fallito, perché insegni al boss come si interpreta il personaggio del boss. Occorre infatti che le masse vedano in lui quel che l’Ui aspira a essere: «non ha importanza quel che pensa il professore e questo o quel saccente: importa come l’uomo della strada s’immagina il padrone. E basta». E basta – ripeterei qui.

Che Hitler sia un attore molto ben costruito è evidente a tutti, soprattutto dopo l’uscita negli Stati Uniti di quel capolavoro che è Il grande dittatore. Con la sua peculiare recitazione, Charlie Chaplin non solo ridicolizza la persona del Führer, ma – cosa alquanto più dannosa per i fascismi dell’epoca – mette allo scoperto come il suo personaggio sia tutta una messa in scena. Da questo punto di vista, la poesia che scaturisce dalla pellicola sarebbe in qualche modo il contraltare dell’orrore che ha invaso la vita reale; il che lascia trasparire un’intuizione importante: che l’aura di un personaggio dipende intimamente dalla narrazione all’interno della quale si inserisce. La recitazione chapliniana, come quella brechtiana, serviva appunto a mettere in risalto il lato tecnico di ogni interpretazione, cioè la sua artificialità. Questo distacco antinaturalista era già praticato nelle avanguardie teatrali espressioniste, dai formalisti russi e nel cinema muto, ovviamente – altro campo su cui Benjamin scrive un interessante saggio. Brecht ne ha un’ulteriore conferma dopo il viaggio a Mosca del 1935, quando vede un attore cinese recitare nello spazio teatrale spoglio, con luce naturale e senza scenografie, costumi, trucco; l’attore pareva staccarsi dal suo personaggio e «lasciar chiaramente capire che sapeva di essere osservato». È il Verfremdungseffekt, lo straniamento, il distacco che raffredda l’empatia, rompe l’immedesimazione e permette alla coscienza di riattivarsi. Raffredda, non elimina! Brecht non chiude affatto la porta alla possibilità che ciò che accade sul palco generi emozione in platea: sa perfettamente che il pubblico non smetterà mai di empatizzare e identificarsi. Se però non può smettere di vedere se stesso in un altro, che almeno veda se stesso non in quel simulacro di realtà che è il personaggio, ma in un altro essere umano vero, reale, materiale: l’attore, l’attrice. Se l’attore e l’attrice si presentano in scena come scientifici analizzatori del loro personaggio e della storia che interpretano, allora, identificandosi con essi, spettatori e spettatrici divengono a loro volta critici analisti dei personaggi e della storia che hanno davanti. Il teatro epico è una palestra per allenarsi alla vita; soprattutto alla vita politica cui, come cittadini e cittadine, siamo chiamati a partecipare.

Nell’Arturo Ui, ogni scena è accompagnata da un cartello che ne spiega la corrispondenza con l’attualità; mostrando l’ascesa del protagonista come “resistibile”, l’autore mette l’accento sul fatto che la storia e la Storia avrebbero potuto andare diversamente, e potranno andare diversamente. Non c’è alcun evento che sia inevitabile, all’interno del processo storico: tutto può essere modificato, se vogliamo modificarlo. Ciò che ricorda lo scienziato pisano al giovane Andrea nel primo quadro della Vita di Galileo (1939) è il messaggio che Brecht riserva a tutto il suo pubblico: «Ma noi ora diciamo; visto che così è, così non deve rimanere. Perché ogni cosa si muove, amico mio». Non c’è possibilità di cambiamento senza critica; non c’è futuro che si possa svincolare da un tener presente il passato – solo così possiamo concepire il tempo come un tempo redento, cioè completamente salvato. L’angelo della Storia di Benjamin ci ha messi sull’avviso: «una tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo “progresso” è questa tempesta». Senza una visione critica del passato, il futuro è un miraggio, un tempo omogeneo e vuoto, una parola svuotata di significato, messa lì per abbindolare le masse con la sua allettante promessa di miglioramento. Attenzione dunque a quei personaggi che si proclamano portatori di un meraviglioso progresso, garanti di un futuro splendente. Sia questo futuro il futuro globale; o, più modestamente, un futuro nazionale.
Per saperne di più
Di Walter Benjamin – la cui lettura è sconvolgente e faticosa, proprio come dev’essere – trovate l’opera omnia pubblicata in italiano da Einaudi. Stesso discorso per gli scritti teorici e le opere di Brecht, che però si rivelano molto più agevoli e divertenti, soprattutto l’Arturo Ui – non ve l’aspettavate, eh? Ebbene sì: Brecht sa anche essere comico. Sul rapporto tra il filosofo e il drammaturgo potete consultare comodamente l’utilissimo Benjamin e Brecht. Storia di un’amicizia, di Erdmut Wizisla, uscito un annetto fa per Kaiak Edizioni (qui la recensione di Roberto Gilodi). L’inquietante Propaganda, di Edward Bernays, è invece disponibile per Shake Edizioni.
Leggi anche:
Davide Carnevali | Pasolini: un teatro scomodo
Davide Carnevali | Creonte e la tragedia della politica
Davide Carnevali | Il primo Sosia
Davide Carnevali | Il Ricco Trump e il Povero Zelensky
Davide Carnevali | Amleto: lo schermo e lo specchio
Davide Carnevali | Il dottor Faust al 1° maggio
Davide Carnevali | Orlando decentrato e Angelica furiosa
Davide Carnevali | Alla guerra in nome di Godot
Davide Carnevali | Medea: un caso di cronaca nera
Davide Carnevali | Goldoni dalla villeggiatura alla fashion week
Davide Carnevali | Ibsen: amici e nemici del popolo
Davide Carnevali | Pier Paolo Pilade: la resistenza della minoranza
Davide Carnevali | Un pranzo di Natale lungo una vita
Davide Carnevali | Sei intelligenze artificiali in cerca d’autore