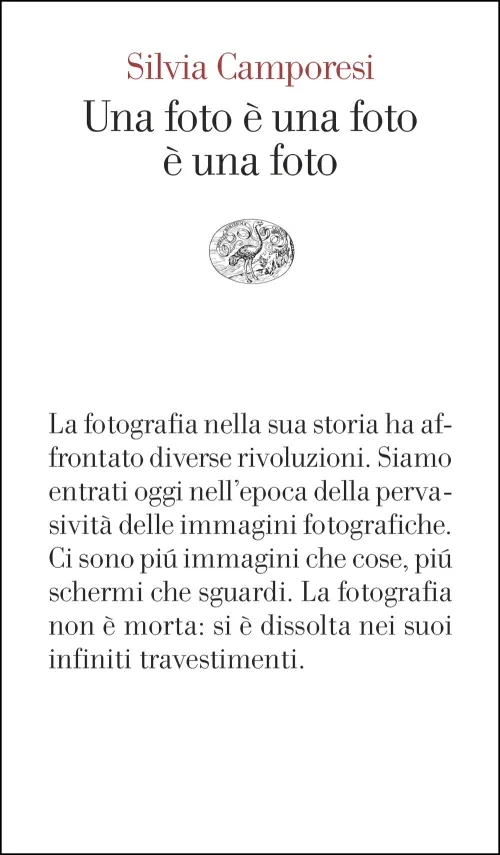Silvia Camporesi e la bulimia fotografica
Di cosa parliamo quando parliamo di fotografia? Siamo sicuri di poter dare risposte così semplici e chiare da sgomberare il campo da fraintendimenti?
Se infatti sulle questioni di carattere generale ci si può trovare spesso d’accordo, le nostre opinioni, quando vengono applicate nella pratica, si divaricano fino a toccare posizioni inconciliabili. Per questo ogni definizione scarna ed essenziale della fotografia deve essere completata con altre definizioni, che girino intorno all’essenza e all’aspetto di questo strumento e intorno alle immagini che esso produce.
Non è forse un caso allora che Silvia Camporesi abbia scelto di intitolare il suo libro, da poco edito da Einaudi nella collana Vele, con una tautologia: Una foto è una foto è una foto, che riprende, parafrasandolo, il verso di una poesia di Gertrude Stein. Un volume agile, e ben scritto, nel quale l’artista-fotografa ha riunito le sue riflessioni sulla fotografia, o meglio sull’atto fotografico, il cui codice genetico negli ultimi anni, con algoritmi e intelligenza artificiale che hanno definitivamente aperto la strada alla produzione di immagini di sintesi, è profondamente e repentinamente mutato.
La fotografia è analizzata dall’autrice come un fatto linguistico che non può essere mai pienamente definito, poiché è pieno di falsi indizi che inducono al dubbio, un medium complesso e strutturato. Camporesi, attraverso la lente della letteratura e della filosofia, ma anche del pensiero di grandi maestri del passato, indaga, con lucidità e precisione, il mutamento di identità della fotografia nel momento contemporaneo, la sua collocazione fra le arti e le sue trasformazioni tecnologiche.
«La parola “fotografia” – scrive –, senza un aggettivo che la connoti, rischia di essere qualcosa di generico che non ne definisce l’orizzonte d’uso. Dire “fotografia”, senza far seguire la parola da un aggettivo che ne classifichi il campo di applicazione, equivale a non dire nulla […]. La mancanza di specificità della fotografia ha dato a questo strumento ampiezza e duttilità, l’ha reso disponibile agli usi più disparati, da quelli dilettanteschi a quelli professionali e artistici, dando vita a un’infinità di discussioni, che spaziano dai problemi puramente tecnici a questioni concettuali e filosofiche complesse».
L’autrice si confronta anche con il problema della gestione delle immagini che la fotografia digitale offre. Questa è divenuta rapidamente uno strumento popolare e lo è sempre di più: si calcola che duecento milioni di fotografie vengono realizzate ogni ora. Scattare fotografie, recuperare immagini in rete, generarle da intelligenze artificiali, sono operazioni alla disponibilità di tutti. Qualcuno ha giustamente parlato di “magma che si espande in modo incontrollabile”. Non senza conseguenze sul nostro modo di osservare e dunque di abitare e di conoscere il mondo. «Produciamo innumerevoli immagini e altrettante ne guardiamo – ammonisce Silvia Camporesi –, senza soffermarci su nulla, senza sentire il bisogno di giustificarle, di commentarle. Così facendo mettiamo in atto una forma di arrendevolezza a questo debordare di fotografie, video, Gif, flussi visivi che saturano la nostra percezione, al punto da rendere sempre più difficile distinguere tra “guardare” e “comprendere”».

È un dato di fatto che la fotografia oggi agisce su una piattaforma mediale sulla quale si muovono molte tecnologie dell’immagine che danno luogo a una produzione estremamente mobile e variegata, con notevole perdita di specificità dei singoli medium: come campo specifico di lavoro essa tende dunque a non esistere più di per sé. Esiste naturalmente come pratica professionale e popolare, ma perde sempre di più la sua autonomia come forma creativa specifica e “autosufficiente”, condizione per la quale aveva a lungo lottato già a partire dall’Ottocento.
Perché, di fronte all’«inevitabile cacofonia delle immagini dei nostri giorni», allora sentiamo il bisogno di fotografare?, si chiede l’autrice, interrogandosi sull’“ossessione fotografica” (nelle sue varie forme) che sembra affliggere il nostro tempo. «Fotografare – scrive – è incastrare qualcosa in un eterno presente, per poi guardarlo a una distanza temporale che lo ha già modificato, reso diverso. Fotografare mette in gioco il tempo nella sua espressione più profonda, inscrivendo sulla superficie dell’immagine un rimbalzo continuo di passato e presente. […] Le immagini hanno implicazioni, sempre e comunque, sebbene la vastità della costante produzione fotografica in cui siamo recentemente precipitati sembri aver reso banale il concetto stesso di fotografare».
La prima conseguenza di un uso popolare dell’immagine digitale è la scomparsa o la riduzione delle tracce fisiche della registrazione delle immagini. Di conseguenza nella nuova forma di fotografia o di fotografia digitale e sintetica si può parlare di una “fotografia che non c’è”, che non esiste in primo luogo come oggetto materiale, che risulta ancora più fragile, per quanto tecnicamente precisa e ben costruita, di quelle fotografie ingiallite, incurvate o mal trattate, che si possono ritrovare negli archivi di famiglia. E che non esiste perché può essere un’immagine lontana dalla realtà, completamente costruita a tavolino.
I problemi teorici che stanno alla base della registrazione fotografica, quello del suo valore di memoria di qualcosa che non è più nel momento stesso in cui viene impressa, poiché ripresa di quell’attimo trascorso, tentativo velleitario di conservare una temporalità inserita nel divenire, e quello della sua veridicità, risultano ancora più accentuati nel presente, tanto per il moltiplicarsi delle possibilità di visione e manipolazione della singola situazione, quanto per il sospetto che ogni immagine possa essere stata composta e modificata, anziché essere una naturale “presa” d’atto di un momento, di una cosa, di un’espressione. Per questa ragione, Camporesi nella sulla riflessione evidenzia, giustamente, come una fotografia che dichiaratamente ripensa l’irrappresentabile, l’invisibile, l’“impercepibile”, è oggi adottata da alcuni in forme nuove, rispetto alle posizioni autoriflessive di qualche decennio fa, ma con relazioni imprescindibili con quelle strade, aperte dalle “Verifiche” di Mulas e dalle proposte che subordinavano l’immagine al significato del fare fotografico stesso, come, per citare alcuni autori italiani attivi in quegli anni, è visibile nel lavoro di Aldo Tagliaferro, Franco Vaccari, Nino Migliori, Luigi Ghirri e altri ancora.
“Una foto è una foto è una foto” è un libro non solo per “addetti ai lavori”, ma rivolto a un grande pubblico, in fondo chi non può dirsi immerso nella bulimia fotografica, nella cosiddetta iconosfera di questo tempo, che influenza profondamente la nostra percezione della realtà e la nostra esperienza quotidiana. Queste pagine sono una riflessione dell’autrice anche sul proprio fare artistico (come, in fondo, ogni autore dovrebbe fare), sulle potenzialità e sui limiti della fotografia stessa. Camporesi porta il lettore all’interno del proprio pensiero anche evocando esperienze personali e aneddoti, che rendono ancora più leggibili queste pagine. Come quando, per spiegare “l’infotografabile”, ricorda quando alla fine degli anni Novanta, mentre muoveva i primi passi come fotografa, un’amica le regala “Sulla fotografia” di Susan Sontag, con la dedica: «Il mare è il mare, non si può fotografare». Racconta: «Tutte le volte che guardo il mare penso a quella frase, al non-rappresentabile fotografico. Il mare è il mare, come “una rosa è una rosa”, ma riguardo il “non si può fotografare”, perché quella impossibilità? Non si tratta tanto di un limite tecnico, quanto della distanza tra ciò che percepiamo nell’esperienza visiva e ciò che l’immagine riesce effettivamente a restituire. Non tutto è fotografabile, nel senso che non sempre la fotografia può contenere nel migliore dei modi l’esperienza visiva nella sua complessità».
Insomma, non un manuale di fotografia e non un libro (necessariamente) per fotografi, ma per chiunque voglia rendere più consapevole il proprio sguardo, perché da come vediamo e guardiamo dipende il nostro modo di comprendere e di stare nel mondo.