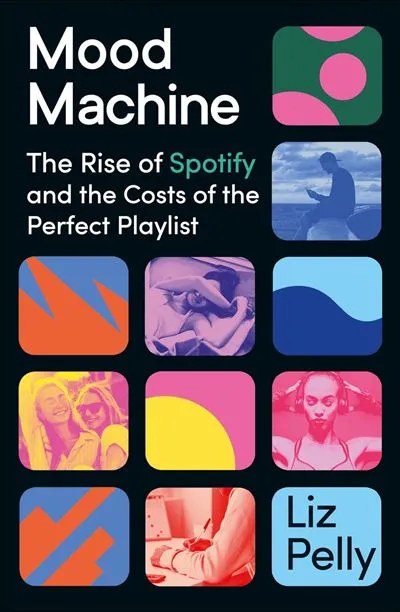Spotify, la macchina dell'umore
Spotify, la popolare piattaforma di ascolto musicale in modalità streaming, deve molto del suo successo a una constatazione in apparenza paradossale, e cioè che la maggior parte di chi ascolta musica non è interessato alla musica. Lo svedese Daniel Ek, CEO di Spotify, si convinse presto che non era vantaggioso investire sugli appassionati di musica, quanto piuttosto su chi ascolta musica per fare altro: esercitarsi in palestra, fare yoga, cucinare, viaggiare, stirare, studiare, prendere sonno. Al netto dei proclami, Spotify non è una piattaforma che punta a offrirci un’esperienza dove la musica è al cuore di quell’esperienza, è piuttosto una piattaforma che vende degli abbonamenti a degli utenti in cerca di una colonna sonora per accompagnare opportunamente il proprio fare (compreso il non fare, quando ci si appresta a una seduta di meditazione o ci si appisola in veranda). È uno strumento che attualizza un’ipotesi già indagata in passato ma tutt’ora altamente suggestiva, quella cioè che un dato mood musicale sia in grado di offrire del valore aggiunto se non proprio maggior pregnanza al nostro stare al mondo. Non la musica come nutrimento dello spirito, la musica per sé, ma la musica come carburante o come stimolo, la musica, diciamo così, funzionale. Qualcuno forse ricorda le mucche del Wisconsin di cui scrisse Alessandro Baricco (L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, ed. Feltrinelli), un saggio che prendeva le mosse da uno studio di un’università americana secondo cui certi bovini del Wisconsin erano in grado di produrre il 7,5% in più di latte quando il loro ruminare era accompagnato dalla musica classica. In altre parole: ascolto un certo tipo di musica perché questa musica mi aiuta a meglio richiamare o godere di una data attività – fosse soltanto riposare o dormire – apparecchiando questa attività dentro una cornice che immagino la accresca o la renda più plausibile: faccio meditazione, ma con un flauto shakuhachi e dei campanelli in sottofondo; trascorro una serata a lume di candela, ma la potenzio con Memo Remigi; studio Schopenhauer, ma lo penetro più a fondo se accompagno la lettura con l’adagio di Barber.
Un ex dipendente di Spotify ricorda come durante una riunione di lavoro Daniel Ek se ne sia uscito con questo slogan motivazionale: “a farci concorrenza non sono Apple Music o Amazon, ma il silenzio”. Per sconfiggere il silenzio non è necessario scomodare Bach o John Coltrane, basta della musica d’ascensore. La sfida consiste dunque nel trovare della musica capace di ancorare l’utente alla piattaforma, nell’offrirgli un servizio che vada oltre la ricerca del brano perfetto o dell’artista sconosciuto, nel sottoporgli la miglior sequenza possibile di brani per accompagnarlo sull’arco della giornata. L’utente medio di Spotify non è chiamato a produrre altro sforzo se non quello di schiacciare il pulsante play o il pulsante skip quando il brano proposto non è di suo gradimento. Esagerando, ma appena un po’, l’utente medio di Spotify è l’equivalente di una scimmia da laboratorio o, per dirla con Baricco, di una mucca del Wisconsin. Nel corso degli anni Spotify ha messo a punto una sofisticata rete di ancoraggio e di mappatura degli utenti sulla base di playlist costruite ad hoc e di una raccolta dati a tutto campo. Una playlist è l’equivalente di una scaletta musicale in radio: brani selezionati da un curatore nel rispetto di un criterio dato (il DJ o un gestore del software di programmazione musicale in radio; un editor responsabile a Spotify). Daniel Ek, avendo determinato come la maggior parte degli utenti di Spotify sia in cerca di (o si adegua presto a) un’esperienza passiva, ha messo a punto una serie di playlist o di pacchetti d’ascolto che si presentano come una ricetta di cui solo Spotify detiene il segreto e che ci si dice sono il frutto di un accurato lavoro editoriale. Tutte illustrate da un titolo descrittivo e accattivante: “Ambient relaxation”, “Deep focus”, “Chill vibes”, “Ibiza lounge”, “Sunset chill”, “Driving at night”, “Chilling with your friends”. Sono solo alcuni dei titoli delle playlist più amate, playlist che vantano milioni di utenti abbonati e che vengono rinnovate di continuo. Non dimentichiamo la constatazione controintuitiva che motivò Daniel Ek in principio: l’utente medio di Spotify è anzitutto in cerca di una cornice, l’equivalente di un mood. E questo è diventato per l’appunto Spotify negli anni, una mood machine, una macchina al servizio del nostro umore o qualcosa che, nella peggiore delle ipotesi, finisce con l’imporre a noi l’umore scelto dall’algoritmo.

Mood machine. The rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist (La macchina dell’umore. L’ascesa di Spotify e il prezzo della playlist perfetta) è il titolo di un libro scritto da Liz Pelly, pubblicato da Simon & Schuster negli Stati Uniti e da Hodder & Stoughton nel Regno Unito. Liz Pelly è una giornalista, saggista e docente americana che conosce la materia come pochi altri. Si tratta di un libro importante, uno dei primi in grado di ricostruire il travolgente e problematico arco della rivoluzione dello streaming, collegandolo agli albori della pirateria digitale, da Napster passando per Piratbyrån (gli eredi della pirateria analogica del bel tempo che fu, a suon di bootleg e di musicassette), al punto che chi scrive l’ha già posto sullo scaffale accanto a opere recenti quali Come funziona la musica di David Byrne e Il resto è rumore di Alex Ross. È un libro necessario per capire l’ecosistema musicale nel quale viviamo, un testo che non solo spiega al profano che cosa sia e come funzioni una piattaforma digitale come Spotify, ma che ne valuta anche l’impatto culturale ed economico, il drastico cambio di paradigma che ha imposto agli addetti ai lavori e agli ascoltatori, e come il suo avvento abbia di fatto contribuito a ridisegnare non solo la mappa dell’ascolto musicale a livello globale, ma a riconfigurare l’industria nel suo insieme, ridefinendo le posizioni di forza e accentuando i disequilibri, col rischio neanche tanto remoto di trasformare e svilire il fatto musicale a mero appendino delle nostre vite, e fare questo attraverso una disinvolta strategia di mercato che ha un impatto diretto su molti musicisti e si sta sostituendo, con la forza dei numeri, al fare musica come necessità di cultura e di tradizione.
Lo streaming rappresenta oggi l’84% dei guadagni sulla musica registrata. Spotify è il leader del settore e controlla il 30% del mercato, con più di 615 milioni di utenti e 239 milioni di sottoscrizioni a pagamento. In questi anni molto si è letto di come Spotify e le altre piattaforme di streaming abbiano trasformato il mercato musicale e le abitudini di ascolto di tutti noi, con un cenno particolarmente preoccupato alla questione del riconoscimento del diritto d’autore a compositori, musicisti e addetti ai lavori, case discografiche comprese (si noti, en passant, come la voce Spotify su Wikipedia si premuri di specificare i nomi di sole quattro case discografiche: Sony, EMI, Warner Music e Universal, ovvero i colossi del mercato musicale odierno che con Spotify hanno stipulato dei contratti miliardari). Le cifre, da questo punto di vista, sono impietose. L’ascolto di un brano in modalità streaming genera per il singolo musicista un guadagno di 0.0035 dollari. Dopo più di 15 anni dall’avvento dello streaming nessuno è in grado di spiegare o di capire come Spotify calcoli il valore di un singolo passaggio in modalità streaming. Rashida Tlaib, membro della Camera dei rappresentanti per lo Stato del Michigan, ha determinato che un musicista necessiterebbe di più di 800'000 stream al mese per intascare l’equivalente di un lavoro pagato 15 dollari all’ora. Non essere pagati per il proprio lavoro o ricevere poco più di un’elemosina è un bel problema, ma il non sapere come e su quale base Spotify determini il compenso destinato agli artisti lascia gli stessi artisti e chi si batte per essi in una situazione di impotenza. Quanti di loro, dietro precisa richiesta, si sono sentiti rispondere it is all just too hard to explain (è tutto troppo complicato da spiegare)?

Sono, questi, aspetti problematici che hanno costretto molti a cercarsi un altro lavoro o ad abbandonare il sogno di una carriera musicale. È una responsabilità non da poco, e non sorprende che Spotify l’abbia sempre respinta, minimizzando il proprio ruolo di game changer laddove questo presenta delle ombre. Attraverso numerose testimonianze dirette, fra cui quelle di ex dipendenti di Spotify, il libro della Pelly porta alla luce le disinvolte strategie adottate da Spotify nel corso degli anni, come la piattaforma abbia sfruttato al meglio e con spettacolare cinismo la posizione di forza in cui s’è venuta a trovare, mettendo in atto una serie di programmi e di procedure che ne rafforzassero da un lato la posizione sul mercato e dall’altro la capacità di attrarre utenti, in particolare grazie a un programma denominato PFC (Perfect Fit Content), che in breve consiste in questo: mettere a disposizione dell’utente della musica appositamente commissionata per richiamare o suggerire un determinato umore, con l’obiettivo di migliorare il margine di profitto dell’azienda. Come migliorare questo margine? Semplice: ricorrendo a degli artisti fantasma. O meglio, chiedendo a delle aziende (Firefly, Epidemic, Hush Hush LLC, Catfarm Music AB, Audiowell, Industrial Works, Mood Works – quest’ultima in affari anche con Apple Music e Amazon, quindi il fenomeno è noto e diffuso ben oltre Spotify) di produrre della musica a basso costo con dei criteri basati sull’umore, musiche sprovviste delle benché minima ambizione artistica e il cui unico scopo è quello di nutrire l’incessante flusso di streaming senza l’obbligo del riconoscimento del diritto d’autore, o pagando una cifra irrisoria rispetto agli standard previsti dalla legge. Peggio ancora, scrive la Pelly: “Spotify ha manipolato la programmazione algoritmica per favorire del contenuto musicale con margini di profitto maggiori, senza dichiararlo agli utenti”.
Va sottolineato che dietro queste tracce create su misura per Spotify (alcune playlist sono composte al 90% da brani realizzati grazie al programma PFC) non si celano degli anonimi smanettoni che mai hanno suonato uno strumento o venduto un disco in vita loro. Si tratta di una ben oliata macchina produttiva promossa da Spotify con il concorso di musicisti veri e di case di produzione legalmente registrate. Non siamo di fronte a dei pirati informatici che puntano ad arricchirsi o a destabilizzare il sistema come succedeva all’epoca di Pirate Bay o di Napster, né siamo di fronte a degli hacker barricati nelle loro camere alla periferia di Stoccolma o di Göteborg, ma a delle società con cui Spotify collabora di comune accordo entro un quadro legale al fine di realizzare del contenuto a esclusivo vantaggio del committente. Fra questi, uno stuolo di musicisti senz’altra prospettiva professionale che il fornire al sistema il contenuto di cui necessita (ma il cui lavoro, nel frattempo, è già stato in buona parte sostituito da brani realizzati a costo zero grazie ai software di intelligenza artificiale). Il catalogo di Epidemic Sound, l’azienda con base a Stoccolma oggi leader nella creazione di brani fantasma e di musica di sottofondo per catene di negozi, genera qualcosa come 40 milioni di stream al giorno. Nel 2022 il giornale svedese Dagens Nyheter pubblicò un’inchiesta da cui emergeva che dietro più di 500 artisti presenti su Spotify si celavano 20 persone soltanto: 20 persone che, sotto diversi pseudonimi, producevano decine di migliaia di brani tutti uguali, ascoltati milioni di volte in modalità streaming (il caso limite è quello dello sconosciuto compositore svedese Johan Röhr, autore di 2700 brani con 650 pseudonimi, brani che gli sono valsi qualcosa come 15 miliardi di stream, più di Britney Spears o degli ABBA).
“Se osservi Spotify in termini di azienda di pubblicità anziché come azienda di cultura, le cose assumono senso”, scrive la Pelly. Le playlist sono un modo efficace per controllare chi ascolta che cosa, un modo di profilare l’utente e le sue abitudini di consumo. Qualcosa che viene poi dato in pasto agli algoritmi per generare delle playlist mirate. Alla questione della raccolta dei dati Liz Pelly dedica uno dei capitoli più inquietanti del libro, suggerendo che Spotify è “un ambiente musicale che riflette la musica solo ed esclusivamente in un contesto di metadati: viene mappata, elaborata, gestita e venduta all’interno di quest’unico paradigma”. In questo ambiente dove l’unica cosa che conta sono i dati, la musica viene pensata e organizzata in funzione di essi. Fu intorno al 2017 che i giornalisti musicali cominciarono a rendersi conto di come lo streaming stesse alterando il pop, soprattutto in termini di struttura delle canzoni, e ancor più in particolare nel fatto di porre il ritornello all’inizio della canzone, così da colpire l’ascoltatore prima che lo stesso avesse facoltà di schiacciare il tasto skip o di fare scroll nel caso di altre piattaforme. Si veda la canzone rockstar di Post Malone, pubblicata nel 2017, che attacca proprio sul ritornello (la casa discografica pubblicò anche una versione alternativa su YouTube dove il ritornello veniva messo in loop per tre minuti e mezzo). Fu un successo clamoroso. O si veda ancora la canzone Location di Khalid, costruita in modo diremmo scientifico per adattarsi alle playlist più diverse, da quella intitolata “Fresh & Chill” a “Soul Lounge”, da “Mellow Bars” a “Chill hits”, un perfetto esempio di come, realizzando della musica in funzione dell’ascolto in modalità streaming e delle playlist, si riescano ad avere in catalogo, come successe allo stesso Khalid, ben nove diversi brani capaci di raggiungere un miliardo di ascolti ciascuno. A determinare il successo della tua canzone è oggi l’adattabilità nel fluire da una playlist all’altra, garantendo un più alto numero di stream. Questo nuovo pop nato su Spotify è ormai assurto a genere musicale tout court, lo Spotify Sound o, per dirla con il New York Times, lo spotifycore (qui un approfondimento sul tema a cura della stessa Liz Pelly).

Riguardo ai dati raccolti sulla piattaforma, come scrive il professore e ricercatore Eric Drott nel libro Streaming music, streaming capital, oggi sappiamo che Spotify condivide questi dati con altri attori quali Facebook, Uber, Tesla, Tinder, Virgin Airlines oltre che con i siti Ancestry.com e 23andMe, in quello che in termini tecnici viene definito ID syncing, la sincronizzazione dei profili. Nel libro della Pelly scopriamo pure che grazie a uno dei suoi più recenti programmi di analisi dei dati, Spotify sostiene di essere ormai in grado di ricavare preziose indicazioni sui comportamenti offline degli utenti (the more they stream, the more we learn è quanto si legge in una pubblicità di Spotify: quanto più l’utente ascolta in modalità streaming, tanto più impariamo – su di lui, è sottinteso; sorprende, invero, la schiettezza con cui si pubblicizza all’utente un prodotto che genera del profitto grazie ai suoi comportamenti). Come scrive Liz Pelly, i servizi di streaming sono sempre meno interessati a connettere utenti diversi al mondo della musica, e sempre più a trattare il gusto personale come un mondo a sé, un mondo da studiare e da elaborare, per poi rivendertelo, quel tuo mondo (ciò che a Spotify chiamano la “customer retention zone”) diversamente confezionato. Perché fare lo sforzo di consigliarti della musica nuova o solleticare la tua curiosità oltre la tua comfort zone, quando è possibile rivenderti la musica che già conosci, confezionata dentro altre scatole? A fine 2023 a Spotify c’erano meno di 200 persone impiegate nel dipartimento “editoriale”, mentre ce n’erano più di 700 impiegate nei cosiddetti “personalisation teams” (ovvero i team che raccolgono ed elaborano i dati degli utenti).
In questo presente orwelliano di streaming intelligence – a detta della Pelly un’espressione che accanto all’ancor più ricorrente intelligenza artificiale è soltanto un modo trendy per incorniciare diversamente la sorveglianza – si dirà che in fondo Spotify non è niente più di una piattaforma che offre la possibilità di ascoltare della musica a pagamento. Se non fosse che in tempi passati, come sottolinea la stessa Liz Pelly, le comunità musicali sono sovente state oggetto di sorveglianza. Si pensi soltanto, limitandoci agli Stati Uniti, a come i musicisti folk di protesta venissero schedati quando non addirittura arrestati per il contenuto delle loro canzoni negli anni del maccartismo, si pensi alle infiltrazioni del Programma di Controspionaggio dell’FBI nell’ambiente del jazz, o alla fissa del Dipartimento di Polizia di New York nei confronti della scena hip-hop fra gli anni ’80 e ’90. Non da ultimo è fatto rilevante che Daniel Ek di recente abbia investito 100 milioni di euro nella startup tedesca Helsing, una società che si presenta con lo slogan l’IA al servizio delle democrazie, e che produce del software al fine di “assistere operazioni militari sul terreno”. Ek siede nel board direttivo della società e si è pubblicamente espresso a favore di maggiori investimenti per la diffusione della sua tecnologia. Nel 2022 firmò a quattro mani un editoriale su Politico in cui promuoveva il concetto di “new defense”, sostenendo la necessità di maggiori investimenti a favore di compagnie che lavorano con l’intelligenza artificiale a scopo bellico. Spotify sarà soltanto una piattaforma che offre della musica a pagamento, ma leggendo queste notizie mi è tornato in mente quel tale che sessant’anni fa o giù di lì cantava dei padroni della guerra.

Tornando a questioni più frivole ma non meno rilevanti, fa pure riflettere come gli artisti pop abbiano ormai cominciato a riordinare il proprio catalogo a immagine delle playlist di Spotify. Su tutte, la regina del pop contemporaneo, Taylor Swift, la quale fece precedere la pubblicazione del suo ultimo disco The Tortured Poets Department dalla pubblicazione, sempre su Spotify, di cinque playlist che miravano a descrivere i cinque stati del mal d’amore: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione, riorganizzando di fatto il suo catalogo in ossequio al principio delle playlist nell’era di Spotify, musica funzionale, delle playlist il cui scopo è riflettere o indurre un dato stato umorale. Siamo entrati in un’epoca in cui, musicalmente parlando, non sono più io a cercare me stesso nella musica, ma è semmai la musica che mi intercetta attraverso le briciole di informazioni che lascio dietro di me, restituendomi un simulacro di me stesso. L’iper-personalizzazione su cui si basa una piattaforma come Spotify sta di fatto orientando in modo diverso l’ascolto musicale. Avvicinare la musica attraverso un’immagine di sé distorta da un algoritmo ha un che di alienante se non proprio di autistico. Come scrive la Pelly, le playlist di Spotify sono delle “raccomandazioni musicali che non creano delle connessioni, ma dei silos”, dei luoghi dove i nostri desideri si riassumono in stringhe di dati rifratti e restituiti allo scopo primario di farci restare sulla piattaforma e di trasformarci in qualcosa di non molto dissimile dalle sventurate mucche del Wisconsin (le quali, magari, avrebbero preferito i Beatles a Mozart).
In chiusura la parola a chi, di tutto questo, paga il prezzo più alto, ovvero i musicisti. Scegliamo Taja Cheek, della band newyorchese L’Rain, una fra le tante musiciste interpellate da Liz Pelly: “lasciare che le grandi aziende creino cultura o determinino la cultura al solo scopo di trarne del profitto, è una brutta cosa. E ciò che la rende ancora più brutta è che tutto si esprime con questo linguaggio all’insegna dell’individualismo che la gente accetta e in cui finisce col riconoscersi. È un’epoca in cui non riusciamo a metterci d’accordo su eventi storici di base, e poi consegniamo alle aziende il potere di creare la loro versione della cultura e della storia. E ci fanno pure un sacco di soldi, mentre le persone che creano il lavoro e l’arte che rende possibile questa truffa, non vengono neppure pagate. I dati ci vengono presentati come una fonte pura, incontaminata dalla cultura, dalle opinioni, da dove ti trovi nel mondo e cose del genere. Ma non è vero. Gli algoritmi sono creati dalle persone e le persone hanno dei pregiudizi. Non c'è nulla di puro nei dati. Sono solo un modo di descrivere qualcosa da un punto di vista particolare.”.