Yoko Ono, una artista speciale
“Mio padre voleva che diventassi una pianista classica. Meglio, una concertista. Mia madre replicò sostenendo che non vi era alcuna donna Beethoven. Mi guardai attorno e mi accorsi che aveva ragione. Al tempo stesso continuava a criticarmi perché ero femmina: “Yoko, tu sei diversa, Yoko tu sei speciale”.
E, in effetti, speciale lo sarebbe stata sempre, da quando mosse i primi passi nel mondo dell’arte contemporanea. Artista concettuale, performer e musicista, in-uno.
Stiamo parlando di una figura davvero speciale, che avrebbe continuamente arrecato ‘disturbo’; alimentando polemiche a non finire.
Un critico ebbe addirittura il coraggio di affermare, a proposito delle sue “opere” (ammesso che si trattasse di “opere”), che “promettevano di essere artistiche quanto un pezzo di tubo arrugginito in mezzo ai detriti bagnati e ai rifiuti cittadini”.
Ci stiamo riferendo a Yoko Ono, famosissima e riconoscibilissima, anche per i non addetti ai lavori (ossia, anche per coloro che non sono soliti frequentare le Biennali, le Triennali, le Quadriennali, i grandi Musei di arte contemporanea, le Gallerie d’arte) in quanto ‘compagna’, e poi moglie, di John Lennon, il mitico beatle morto per mano di Mark David Chapman, un “ragazzo con vistosi occhiali, in evidente sovrappeso e leggermente autistico”, l’8 dicembre del 1980.
Ad ogni modo, Yoko Ono – artista giapponese trapiantata, ancora giovane, negli Stati Uniti – era già nota, prima di incontrare Lennon, nell’ambiente delle avanguardie. Ci stiamo riferendo ai primi anni Sessanta, quando la “figlia dell’oceano” (questo significa infatti “Yoko”) aveva già cominciato a frequentare i protagonisti di Fluxus – un nuovo movimento artistico, radicale e sperimentale come pochi altri, sostenuto da personalità del calibro di John Cage e George Maciunas (artista, architetto e musicologo di origine lituana).
Come gli amici di questa nuova importante e dirompente compagine, anche Yoko Ono appare sin da subito convinta che l’arte non possa più essere concepita come attività volta alla produzione di manufatti, più o meno seducenti, ma che vada piuttosto risolta in una pratica performativa volta a contrassegnare, più che una tipologia di oggetti, un “atteggiamento”; ovvero, una semplice disposizione esistenziale. Animata, peraltro, da un unico intento: “integrare l’espressione artistica nella vita di ogni singolo”.

L’artista, insomma, avrebbe dovuto impegnarsi ad alimentare un “flusso” vitale destinato a modificare l’esistenza dei suoi spettatori, oltre che degli artisti – spettatori che sarebbero stati sempre più esplicitamente chiamati a farsi parte integrante dell’opera.
Ecco, è proprio di questa artista che riescono a tratteggiare un gran bel ritratto (in modo quasi complementare) due volumi usciti in libreria da poco; uno firmato da Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti (intitolato Yoko Ono. Brucia questo libro dopo averlo letto, per i tipi di shake edizioni) e un altro di Dario Salvatori (intitolato invece: La figlia dell’oceano. Vita di Yoko Ono, ed edito da il Saggiatore).
Due gran bei libri, diciamolo subito; anche se molto diversi, l’uno dall’altro. Che ci conducono per mano – per quanto mossi da intenzioni non del tutto identiche – in un entusiasmante viaggio alla scoperta della vera anima di un personaggio alquanto controverso e fin troppo ‘discusso’… accusato addirittura di esser stato il primario responsabile dello scioglimento dei Beatles.
Un viaggio in entrambi i casi intenso, ricco di sfumature, che molto ci fa capire di quella piccola donna che molti hanno conosciuto solo per l’uso sgraziato di una voce stridula simile a quella “di un bambino sottoposto a torture” (forse una manifestazione dell’Urlo originario di cui scriveva lo psicoterapeuta Artur Janov), che non di rado si sarebbe esibita al fianco di mostri sacri del calibro di Lennon, ovviamente, ma anche di Eric Clapton, Alan White, Ringo Starr e altri importanti protagonisti del rock di quegli anni.
Mi piace ricordare, tra le molteplici collaborazioni musicali di cui la spregiudicata artista giapponese seppe farsi protagonista, anche quella con Ornette Coleman, uno dei più grandi innovatori del linguaggio jazzistico contemporaneo. Verso la fine degli anni Cinquanta, infatti, Ornette, insieme a Don Cherry, aveva elaborato quello che poi sarebbe passato alla storia come il linguaggio del “free jazz”. Una vera e propria rivoluzione, che non poteva non appassionare e quindi essere convintamente supportata dalla giovane artista giapponese; che si impegnò ad aiutare, anche economicamente, il giovane sassofonista, chiedendogli poi di prender parte all’incisione di Yoko Ono/Plastic Ono Band – il suo primo album da solista, alla cui messa a punto contribuirono, comunque, anche Ringo Starr e Klaus Voormann.
Certo, i due libri sono utilissimi, in quanto ci aiutano, con grande cognizione di causa, a ripercorrere la carriera e la vita di Yoko Ono; facendo finalmente luce sulla complessità di una donna che, già nei primi anni trascorsi in Giappone (ricordiamo che in Giappone la nostra si iscrisse anche alla facoltà di filosofia), si fece notare per un comportamento sregolato ed assolutamente fuori dalle righe. Faceva sesso con tutti; e, anche quando si legava a un uomo, lo tradiva in continuazione. Era un periodo di amore libero, ci ricorda Salvatori; e l’inquieta artista nipponica si dedicò ad una sfrenata attività sessuale, che la costrinse a ricorrere più di una volta all’aborto. Ogni volta che faceva sesso con un uomo, avrebbe voluto partorire un bambino; ma subito dopo se ne pentiva, e quindi abortiva.
A un certo punto si unì a Toshi Ichiyanagi, astro nascente della nuova musica; fu allora che iniziò a cimentarsi sul serio con l’arte dei suoni. Ma importante fu per lei soprattutto il rapporto con un altro validissimo compositore d’avanguardia: La Monte Young.
Ed è infatti sulla sua scia che, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, riuscì ad entrare dall’ingresso principale nel gruppo Fluxus.
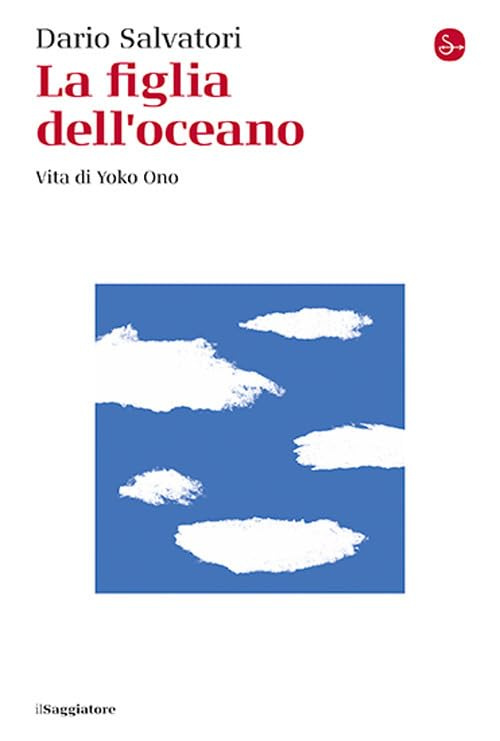
Lennon, invece, lo conobbe a Londra, dove si recò per partecipare ad un Convegno sull’arte contemporanea. Lo conobbe negli spazi dell’Indica Gallery, la sera del 9 novembre del 1966 (l’anno in cui i Beatles pubblicarono il disco della svolta: Revolver). Da quel momento, i due divennero una coppia indissolubile, per quanto non di rado minata da conflittualità e momenti tutt’altro che facili (si pensi solo alla parentesi, peraltro supportata dalla stessa Ono, che vede Lennon fare coppia con May Pang – già loro assistente di produzione).
Dal 1971, comunque, si trasferiscono stabilmente a New York; dove avranno modo di frequentare gli ambienti più vivaci dell’universo artistico di quegli anni; stabilendo proficui contatti con diversi movimenti di rivolta, dalle Black Panters ai protagonisti del movimento antipsichiatrico, come David Cooper (con cui pare che Yoko ebbe anche un flirt) e Michel Foucault.
In ogni caso, ad occuparsi di Yoko Ono in quanto artista di prima qualità, a prescindere dal suo pur importantissimo rapporto con John Lennon, è soprattutto il volume di Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti. Che analizza nel dettaglio tutta la produzione performativa ed espositiva dell’artista nipponica.
E cerca (riuscendovi alla grande!) di restituirci il nocciolo di una vicenda creativa tutta imperniata su un’idea di arte concepita come pratica proficuamente “partecipativa”, e ossessivamente volta a far interagire emozioni e istanze tra loro assolutamente contraddittorie. Yoko Ono ne emerge quale agitatrice di emozioni che sono sempre insieme di umiltà e di aggressività, di vergogna e di perversione, di bontà e di cattiveria… etc etc. In quanto dichiaratamente convinta del fatto che non si potesse e non ci si dovesse mai identificare con uno solo dei poli di tali opposizioni assolute.
Schierata sempre per la ‘pace’, Yoko Ono ha infatti sempre rifiutato il principio dell’esclusione (dell’aut-aut).
Insomma, come viene giustamente sottolineato da Francesca Alfano Miglietti, la Musa di Lennon rimarrà sempre convinta che l’arte “sia, per sua natura, relazionale”; e che dunque debba realizzarsi come vera e propria esperienza – anche costitutivamente “politica”, quindi – di condivisione.
Ma, come Maciunas, anche Yoko Ono si dimostra risolutamente refrattaria ad ogni tentativo di definizione. Ai suoi occhi, infatti, l’arte sembra avere un solo compito: quello di modificare la vita. Anzi, di “farsi vita” – come avrebbe voluto, in quegli stessi anni, anche il tedesco Joseph Beuys.
Sempre con questo scopo, la minuta artista giapponese pubblica anche un volume intitolato Grapefruit. La prima edizione del quale risale al 1964. Un volume che la rappresenta davvero alla perfezione.
Una raccolta di schizzi e pagine di ‘istruzioni’, peraltro non sempre realizzabili. Progetti di “incertezza”, li definisce infatti Francesca Alfano Miglietti; pubblicati con il solo scopo di invitare il lettore a credere nell’impossibile e ad agire di conseguenza.
D’altro canto, la nostra “figlia dell’oceano” ha sempre concepito l’arte come evento totale, che può manifestarsi nelle forme più diverse (in forma poetica, in forma musicale, in forma teatrale o in forma cinematografica…); quasi a voler dimostrare che le classiche distinzioni categoriali o disciplinari sono del tutto aleatorie e di fatto insostenibili.
Non a caso, si è sempre impegnata a dar vita a delle vere e proprie “partiture di eventi”; capaci di farci riconoscere la bellezza e l’arte in ogni attività quotidiana. Istruzioni per la pittura, istruzioni per la poesia, istruzioni per l’evento… etc.
Delle vere e proprie “infrastrutture”, precisa Alfano Miglietti; concepite quali “punti di partenza che non vengono mai costruiti in modo definitivo”. D’altronde, non v’è nulla di definitivo, nella vita. Nonostante le ben note pretese avanzate da un’arte che avrebbe troppo a lungo voluto accompagnarci verso le regioni dell’eterno. Liberandoci dalla precarietà e dalla singolare contingenza cui sembra destinata ogni esistenza individuale.
Per questo, sottolinea con ammirevole cognizione di causa Alfano Miglietti, nell’opera di Yoko Ono l’oggetto evapora, scompare, cioè, con l’aiuto delle parole.
Insomma, la realtà viene “decostruita” e resa sempre più evasiva, sino a svanire completamente. Perché nulla deve ‘restare’, o permanere, e tanto meno mostrarsi immune dall’opera distruttrice del tempo.
Da cui l’esigenza di costruire un mondo assolutamente evanescente – precisa ancora la nostra storica dell’arte e critica militante. Un mondo evanescente e irreale, insomma; costituito da immagini vocate a restituirci il semplice flusso dell’esistere. Come se volesse portare a compimento un’intuizione risalente addirittura al 1962, quando, in occasione della mostra giapponese Instructions for paintings, la nostra ‘eroina’ invitò gli spettatori a farsi parte attiva del processo creativo.
Un’opera che costituisce uno dei primissimi esempi di Arte Concettuale, precisa Alfano Miglietti; e in cui, dunque, a venire messe radicalmente in discussione sono anzitutto l’unicità e la sacralità dell’oggetto d’arte, a favore di una indefinita estensione dell’azione – che ogni oggetto sembra destinato a risolvere in una risolutamente irredimibile contingenza, vocata a sancire, da ultimo, il radicale trionfo dell’effimero.







