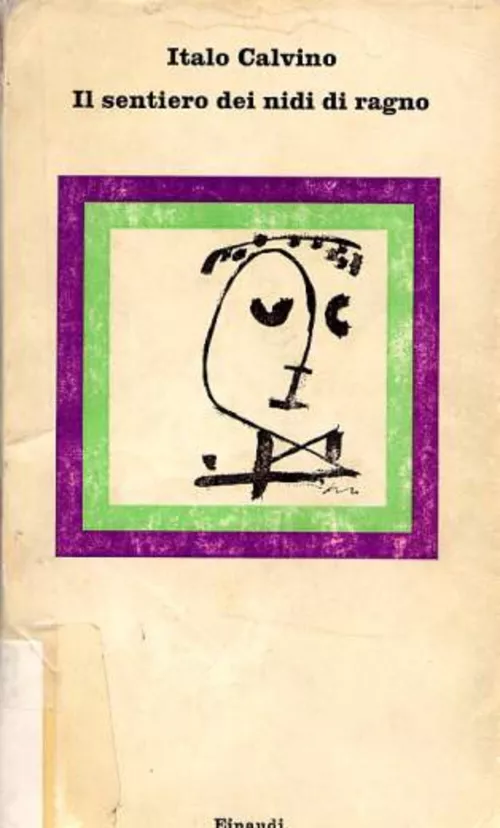Antologia del grigio
La mia storia è piena di buchi come un romanzo, ma in un comune romanzo è il romanziere a decidere come distribuire i buchi, un diritto che a me è negato perché sono schiavo dei miei scrupoli.
Laurent Binet, HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich, 2010
Quando ci chiediamo cosa, quanto e come leggono di Resistenza “i giovani” – gli studenti – troviamo sul campo due rischi: uno di merito e uno di metodo. E sono convinto che sia necessario provare a individuare alcuni antidoti per entrambi. La “vulgata” revisionista ha seminato molto negli ultimi anni, mettendo in crisi la complessità e le varie stratificazioni della vicenda resistenziale e delle sue narrazioni. Come si può cercare di ridare tridimensionalità agli eventi e ai processi storici che in questi giorni sono al centro del dibattito pubblico, partendo dal fatto che non solo la narrativa, ma la narrativa resistenziale tout court ha perso sicuramente gran parte del suo fascino? Utilizzando gli stessi espedienti narrativi di questa vulgata, credo.
Il presunto multitasking e l'attenzione “a singhiozzo” hanno creato un culto del frammento che è spesso additato come un pericolo ma che è anche una grande opportunità educativa. La rete, a guardarla in profondità, è zeppa di citazioni e brandelli di brani letterari, come fossero ipotetiche quarte di copertina, ipotetici risvolti di copertina, esergo: si tratta di frammenti che – se catturano la nostra attenzione – possono portare il navigante a spegnere il pc e leggere, semplicemente, un libro. È necessario partire dall'immaginario degli studenti, dall'assunto che la Resistenza spesso non è un tema affascinante per i nati negli anni Novanta, al massimo è, appunto, un aforisma o è uno scorcio intimamente connesso ai racconti dei racconti famigliari o di qualche ex partigiano incontrato a scuola. Oppure interessa i ragazzi anche a partire dal successo quantitativo dei libri di Pansa (in quante case italiane sono i pochi o gli unici libri di storia presenti?) e dalla colonizzazione dell’immaginario che ha contribuito a forgiare un'immagine della Resistenza schiacciata sulle vendette del post-25 aprile. Su Wikiquote, per esempio, al terzo posto dopo Italo Calvino e Sandro Pertini troviamo proprio una citazione di Pansa (tratta da I gendarmi della memoria. Chi imprigiona la verità sulla guerra civile, Sperling&Kupfer 2010):
È indubbio che senza il PCI non ci sarebbe stata nessuna guerra partigiana. E la Resistenza si sarebbe rivelata un'impresa modesta. Ma con il PCI la guerra di liberazione è diventata anche una guerra rivoluzionaria, per la conquista del potere in Italia.
(Vedi qui)
Come si può provare a dare un'immagine articolata della Resistenza, lontana dalle pulsioni di un irritante “uso pubblico”? Non penso che professori e formatori debbano porsi come “iconoclasti” e dunque “cestinare” la storiografia e tanto meno i “classici”, anche perché proprio i classici, mentre mettevano su carta la «primordiale dialettica di morte e felicità» (così Calvino nella prefazione del 1964 a Il sentiero dei nidi di ragno) dei protagonisti della vicenda resistenziale, anticipavano di decenni riflessioni storiografiche come quelle che Claudio Pavone avrebbe proposto in Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza (1991). Come spesso accade, il romanzo riesce a scavare in profondità, ad andare con passo visionario al cuore delle questioni. Pensiamo al brano conclusivo di Una questione privata di Fenoglio, la scena della morte di Milton, che ci restituisce la caducità della vita in tempo di guerra, l'idea del sacrificio forse inutile, del “privato” sommerso dalla sfera pubblica di una guerra civile che travolge tutto e tutti (non sembra di sentire La guerra di Piero di Fabrizio De André?):
Correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della pace, ma ancora correva, facilmente, irreversibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi parvero serrare e far muro e a un metro da quel muro crollò.

Una rapida periodizzazione può aiutarci, per incominciare. La dialettica «di morte e felicità» in gran parte “reducistica” ed epica dei primi anni dell'immediato dopoguerra – come Uomini e no di Elio Vittorini, 1945, e L'Agnese va a morire di Renata Viganò, 1949, ma anche l'incalcolabile numero di memorie e diari pubblicati fin dall'immediato dopoguerra – presto si trova a essere sulla difensiva nell'Italia della DC, e viene seguita da un'esplosione narrativa che parte negli anni Sessanta (con i testi di Beppe Fenoglio, Luigi Meneghello e Nuto Revelli) e che per due decenni vede protagonista una generazione di autori per la quale la storia della Resistenza è anche via via lo specchio delle lotte contemporanee. Non è un caso che siano anche gli anni in cui viene riedita la Storia della Resistenza italiana – pubblicata inizialmente nel 1953 – di Roberto Battaglia, uno degli “storici-protagonisti” della prima fase. Quello di Battaglia è un testo che, fatta eccezione per il tentativo di Giorgio Bocca nel 1966 (Storia dell'Italia partigiana) e altri di scarso successo, rimarrà di fatto l'unica storia della Resistenza per decenni. Nel passaggio tra gli anni Ottanta e la Seconda Repubblica la lettura epica/agiografica diventa via via più residuale, e negli ultimi anni la fortuna pubblica del revisionismo ha creato una dimensione frammentata nella quale la Resistenza è diventata sempre di più un fatto privatistico-individualistico e questo si rispecchia anche nella letteratura (si pensi a Dove finisce Roma di Paola Soriga e I nostri occhi sporchi di terra di Dario Bruzzolan). La distanza dai fatti narrati è sempre più incolmabile, la dimensione epica sfuma nettamente anche a causa di oltre cinquant'anni di retorica, e appaiono nuove urgenze. Innanzitutto quella di capire, di interrogarsi sulla complessità della storia, sulla spesso inestricabile relazione tra luci e ombre.
L'ultimo quarto di secolo ha visto anche la storiografia cambiare di passo. Come auspicato da tempo (dalla fase in cui dalle memorie si era passati ai documenti) si è allargata definitivamente la prospettiva e anche l'interesse su altri temi, tra cui la deportazione e l'internamento militare. Tra Una guerra civile di Claudio Pavone nel 1991 – «opera decisiva per molteplici aspetti, tra i quali non ultimo il fatto che con essa si afferma autorevolmente l'emancipazione della storiografia resistenziale da ogni pratica di autocensura», così la definisce Santo Peli – e l'ottima sintesi dello stesso Peli (Storia della Resistenza in Italia, 2006) sono apparse numerose ricerche su temi che nel mondo bipolare erano di fatto ignorati, ricerche concentrate sul vasto contesto più che sulla Resistenza armata, e in particolare sulla categoria della Resistenza senza armi, la “resistenza civile”. Un tratto comune è l'impatto che guerra e partigianato hanno avuto sulla popolazione civile, e sono dunque estremamente attuali per quanto riguarda la sensibilità pubblica e storiografica sul tema. Credo che noi, che viviamo in tempo di pace e abbiamo il compito di porre le giuste domande, dobbiamo entrare in un'ottica di costruzione di un'antologia del grigio, e non «nell’accezione, per certi versi abusiva rispetto al pensiero di Levi, diffusa in tutto il campo della storiografia della Resistenza da De Felice» come sintetizza Robert Gordon, che definisce il grigio «non tanto o non soltanto quella dell’attendismo e della scelta di non scegliere, quanto il concetto originario di Levi dei Sommersi: il concetto della situazione storica che impone all’individuo scelte necessarie e impossibili, moralmente compromesse a priori» (Shoah, letteratura e zona grigia in Partigia). Per confrontarsi, appunto, con la storiografia e il discorso pubblico così attuale sulla Resistenza, penso che sia estremamente utile affidarsi al concetto leviano di “zona grigia”, che venne fin da subito distorto – osserva ancora Gordon –, come «categoria storica anti-ideologica invece che etico-politica», e che invece ritengo debba servire per fotografare, per immortalare nelle sue varie articolazioni un sottobosco sfuggente, che rifugge dalle facili categorizzazioni. Con onestà intellettuale, e con un po' di metodo.
 Romain Gary
Romain Gary
Possiamo salvare qualcosa del Pansa “letterario”, dei suoi testi che assomigliano molto a libri di storia senza note? Se leggiamo Il sangue dei vinti vediamo che il meccanismo narrativo – abbastanza rudimentale – mette il sé dell'autore al centro della pagina, e produce un effetto di autenticità e scorrevolezza che Sergio Luzzatto ha riproposto, certo con maggior efficacia, in Partigia. Una storia della Resistenza (vedi anche qui, ndr), libro che di fatto si pone nei confronti dell'oggetto Resistenza (condito di Shoah) con un approccio “laterale”, che si pone come anti-mainstream (con il malcelato obiettivo di diventare lui stesso mainstream).
Libri come quelli di Pansa, pur non essendo romanzi, affollano per molte ragioni le case degli italiani in quanto sono i libri di storia più venduti: non è da escludere che siano per gli studenti più visibili e facili da reperire (in casa o altrove) che le Lettere dei condannati a morte, o i romanzi di Calvino o Fenoglio. Stiamo parlando di libri che hanno avuto uno straordinario successo non solo per l'operazione revisionista che li ha sorretti, ma anche per ragioni di fruibilità. E perché si pongono come contro-storie che espongono sulla pagina – almeno apparentemente – anche il percorso di ricerca dell'autore, “mettono in scena” la ricerca, in alcuni casi con innesti finzionali, come l'eccezionale narrative non fiction di Laurent Binet, HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich, che racconta l'attentato a Reynard Heydrich, nel maggio del 1942, a opera di due partigiani. In questo ultimo caso, l'onestà intellettuale del narratore rende il libro un'entusiasmante operazione a cuore aperto: la letteratura si rende non solo strumento per raccontare la storia e fonte che ci racconta l'epoca in cui è stata creata (in questo caso il nostro presente), ma diventa un attrezzo per mettere a fuoco la complessità del reale, le esitazioni e le oscillazioni – anche etiche – dei personaggi narrati e del loro narratore.
Per questo è necessario stimolare la curiosità dei ragazzi che difficilmente sentono propria la storia della Resistenza: renderla umana credo sia il primo dovere di chi, per lavoro e/o per passione, deve mediare tra loro e le migliaia di pagine che ci si auspica prima o poi leggano. Credo che sia prioritario mettere in relazione le loro (presunte, anche errate) pre-conoscenze con le conoscenze da acquisire, anche attraverso una cultura del frammento. Non forniamo loro una visione preordinata, ma cerchiamo delle immagini forti a partire da quello che loro stessi possono trovare in rete. E, anche a partire dalla letteratura, mettiamo a frutto il loro stupore, valorizziamo il loro sguardo “spettatoriale”, facendo esplodere questo sguardo attraverso punti di vista che sappiano coinvolgerli.
A fronte della difficoltà di trasmettere la storia della Resistenza muovendo dalle ragioni ideali e dalle motivazioni politiche che l’hanno innervata – l'ha fatto recentemente Giovanni De Luna con La Resistenza perfetta –, la scommessa è allora che partire dall’esistenza sperimentata possa rappresentare un canale di comunicazione efficace, cercando di far capire le ricadute (e anche il prezzo) della scelta partigiana nella vita dei singoli. Partire dalla vita delle persone, dai colori, dalla letteratura e creare uno scenario mentale nel quale i ragazzi si sappiano muovere agilmente, si possano emozionare, e al quale si possa attingere in futuro. E da qui poi ricostruire, per cerchi concentrici e con loro, il contesto. In questo sono cruciali gli sguardi laterali, quelli che lasciano «affiorare una molteplicità di percorsi esistenziali difficilmente riconducibili a uniformità segnata dalle grandi sintesi politiche e ideologiche» (come ha scritto lo stesso De Luna a proposito della trilogia di Fenoglio). Alcuni testi possono appartenere allo “spirito del tempo” per decenni (penso ancora a Calvino e Fenoglio), altri meno: Uomini e no di Vittorini, pur essendo contemporaneo di Educazione europea di Romain Gary, difficilmente cattura un ragazzo nato degli anni Novanta. A differenza di quest'ultimo.
Le pagine dei narratori hanno anticipato e possono ancora oggi gettare luce – come scrive ancora Santo Peli citando Pavone – sui «“più intricati nodi politici ed etici della lotta resistenziale”, soprattutto quelli connessi all'uso, e anche agli abusi, della violenza, da cui nemmeno i partigiani erano al sicuro», dovendo misurarsi quotidianamente con la necessità della violenza (e non con la violenza come valore, rivendicata dall'altra parte). A degli studenti proporrei proprio Educazione europea, che è un saldo antidoto contro le interpretazioni ideologiche della Resistenza. In questo passaggio sul nemico-amico, in cui Dobranski, lo studente-partigiano-narratore polacco si rivolge a Janek, il protagonista del romanzo, credo ci sia tutto quello che vogliamo dire:
«Allora mi domandavo: come può il popolo tedesco accettare tutto ciò? Perché non si ribella? Perché si sottomette e accetta questo ruolo di boia? Certo, coscienze tedesche ferite, oltraggiate in ciò che hanno di più semplicemente umano, si ribellano e si rifiutano di obbedire. Quando, però, vedremo i segni della loro ribellione? Ebbene, a quel tempo un giovane soldato tedesco venne qui, in questa foresta. Aveva disertato. Veniva a unirsi a noi, a mettersi al nostro fianco, sinceramente, coraggiosamente. Non vi erano dubbi: era un puro. Non si trattava d'un membro del Herrenvolk, si trattava di un uomo. Aveva sentito il richiamo di ciò che in lui vi era di più semplicemente umano, e aveva voluto togliersi di dosso l'etichetta di soldato tedesco. Ma noi avevamo occhi soltanto per questo, per l'etichetta. Tutti sapevamo che era un puro. La purezza la senti, quando ti capita di trovarla. Ti acceca, in mezzo a questo buio. Quel ragazzo era uno dei nostri. Ma aveva l'etichetta».
«E allora?»
«E allora noi lo abbiamo fucilato. Perché aveva addosso l'etichetta: tedesco. Perché noi ne avevamo un'altra: polacchi. E perché l'odio era nei nostri cuori... Qualcuno, a mo' di spiegazione, o di scusa, non so, gli aveva detto: “È troppo tardi”. Ma sbagliava. Non era affatto troppo tardi. Era troppo presto...».
Questo testo è la rivisitazione di un intervento fatto in occasione della formazione docenti che si è svolta al Santuario di Oropa (BI) tra il 14 e il 16 novembre 2013 in occasione del seminario per insegnanti sul tema della Resistenza, all'interno del progetto coordinato da Giovanni De Luna I linguaggi della contemporaneità, della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.