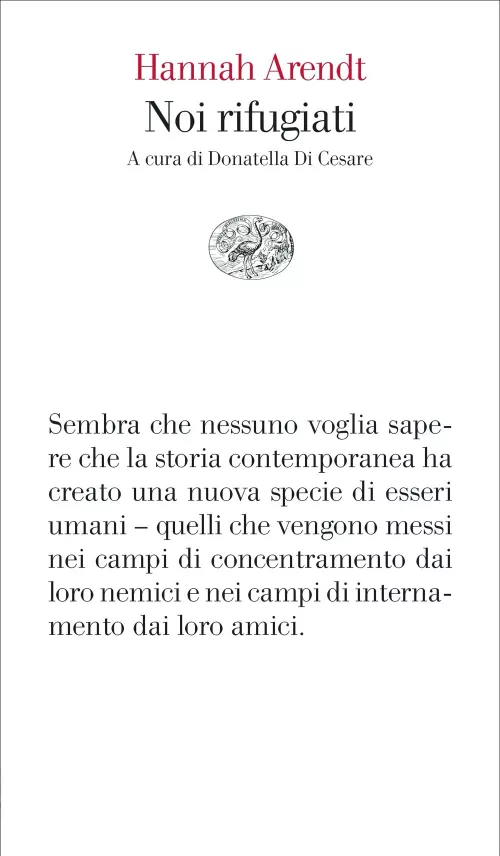Arendt: non sentirsi mai a casa
Nella Russia zarista di inizio XX secolo, il tuttofare ebreo Yakov Bok si vota al più certo dei destini: abbandona la sua terra, gravida delle passioni tristi di un matrimonio fallito e di una vita senza promesse, per cercare fortuna a Kiev, e trova invece un sacrificio individuale che, suo malgrado, è chiamato a redimere le sorti di un intero popolo. Bok incarna una figura tragica dell’umano: l’attimo di follia che porta a lasciare i confini di una forma di vita, prima che di un territorio, si risolve in una catastrofe cosmica. Bok, che di sé nutre l’immagine di taumaturgo delle cose, finisce per essere il rabdomante di un dramma collettivo che non smette di ripetersi, come se la storia umana non potesse rinunciarvi: nella terra che non è sua, ogni sua azione, ancorché ispirata alla più pia delle virtù, agli occhi degli astanti tradisce solo empietà e perversione. Ed è così che, quando la polizia e le istituzioni russe, per tenere a bada le noie della vita e dar requie gli affanni mondani, vanno in cerca di pretesti per scatenare un pogrom, imprigionano l’innocente Bok perché faccia loro il piacere di imputarsi crimini che egli non saprebbe neppure concepire.
Nella spirale di sevizie tutte tese a iscrivere su un corpo la propensione psichica alla soggezione, Bok adotta invece la postura del martire laico, che rifiuta di barattare l’ignominia con la libertà. Resiste, sopporta l’isolamento, le catene che gli consumano le carni, le ispezioni più intime e umilianti, le percosse sistematiche, eppure non confessa una colpa che non ha. Ma tutto questo, Bok, lo fa con deliberato spirito impolitico: sebbene di fatto sia lì a rappresentare l’intero popolo ebraico, egli rifiuta di farsi interprete di una riscossa millenaria e non si fa carico di alcuna missione che non sia volta alla difesa della sua onorabilità. La sua è una tragedia collettiva che da sempre sa trovare solo eroi individuali.
Viene alla mente questa raffinata figura letteraria – che in L’uomo di Kiev (minimum fax 2017) Bernard Malamud ricalca sul resoconto autobiografico di Menahem Mendel Beilis – quando si leggono le splendide pagine di Noi rifugiati, saggio di Hannah Arendt del 1943, tradotto e curato da Donatella Di Cesare per i tipi di Einaudi. Come Bok, gli ebrei che in terra straniera cercano scampo dalle perversioni del nazionalsocialismo sono “i primi ebrei non religiosi a essere perseguitati” (Hannah Arendt, Noi rifugiati, Einaudi 2022, p. 13), in una dimensione sacrificale, però, che si apre e si chiude entro l’umile recinto di una biografia al singolare: “Era opinione comune che fosse necessario essere asociali in modo abnorme, nonché indifferenti alle circostanze generali, per aver ancora la capacità di interpretare tutto quel che era accaduto come una disgrazia personale e individuale mettendo perciò fine ai propri giorni in modo altrettanto personale e individuale” (p. 13). E proprio come nel caso di Bok, a dispetto della vistosa follia pubblica dei persecutori, la maniera tipica “di scomparire è silenziosa e modesta”.
Gli ebrei “sembrano volersi scusare per la soluzione violenta che hanno trovato ai loro problemi personali. In genere ritengono che gli avvenimenti politici non abbiano nulla a che vedere con il loro destino individuale” (p. 14). Il riferimento, manifesto al punto di far male, è al crescente tasso di suicidio come forma ultimativa di fuoriuscita da una vita non più vivibile. Ma benché un riferimento tanto sentito lasci intuire un che di autobiografico (cfr. Donatella Di Cesare, Hannah Arendt e i diritti dei rifugiati, in Arendt, Noi rifugiati, pp. 33-89, alle pp. 54-55), a me pare che qui Arendt si riferisca piuttosto a quel genere di suicida che, come per Albert Camus, è l’opposto del condannato a morte: suicida è chi con la rivolta restituisce un senso alla vita senza cedere alla sbornia egotica di una redenzione collettiva. Il suicida ebreo, scrive Arendt, è convinto che “gli avvenimenti politici non abbiano nulla a che vedere con il loro destino individuale” (p. 14).
E non insisterei troppo sulla dimensione a un tempo sacrificale, individuale e redentiva, di cui Arendt a mio avviso tesse amarissime lodi, se non si rischiasse di perdere l’opportunità unica di trarre qualcosa di vitale dalla figura del rifugiato ebreo – qualcosa che nel saggio risuona con una forza che unisce il vigore dell’idea al brio dello stile. In effetti, in una fase storica, come l’attuale, in cui sulla pelle dei migranti si combatte una battaglia di propaganda, la polarizzazione è inevitabile, e quindi capace di un danno più serio e duplice. Per un verso, dell’afflusso di rifugiati si eccita il carattere di minaccia per farne facile prebenda politica presso chi, tra l’elettorato, ama procacciarsi capri espiatori à la carte. Che questo sia male, non c’è dubbio – o, quantomeno, dubbi lo scrivente non ne ha. Per altro verso, però, i rifugiati sono vittima di un trattamento speculare da parte di chi, in una coscienza la cui bontà qui non s’intende mettere in questione, cerca di difenderne le sorti in un modo che non è esente da rischi: i rifugiati vengono troppo spesso – e certo non senza motivo – ritratti come vittime, soggetti vulnerabili; dai loro volti traumatizzati si estrae il dramma del dolore, mentre costruzioni simboliche improntate a una panoplia di sentimenti compassionevoli ne fanno persone in una perpetua condizione di debito.
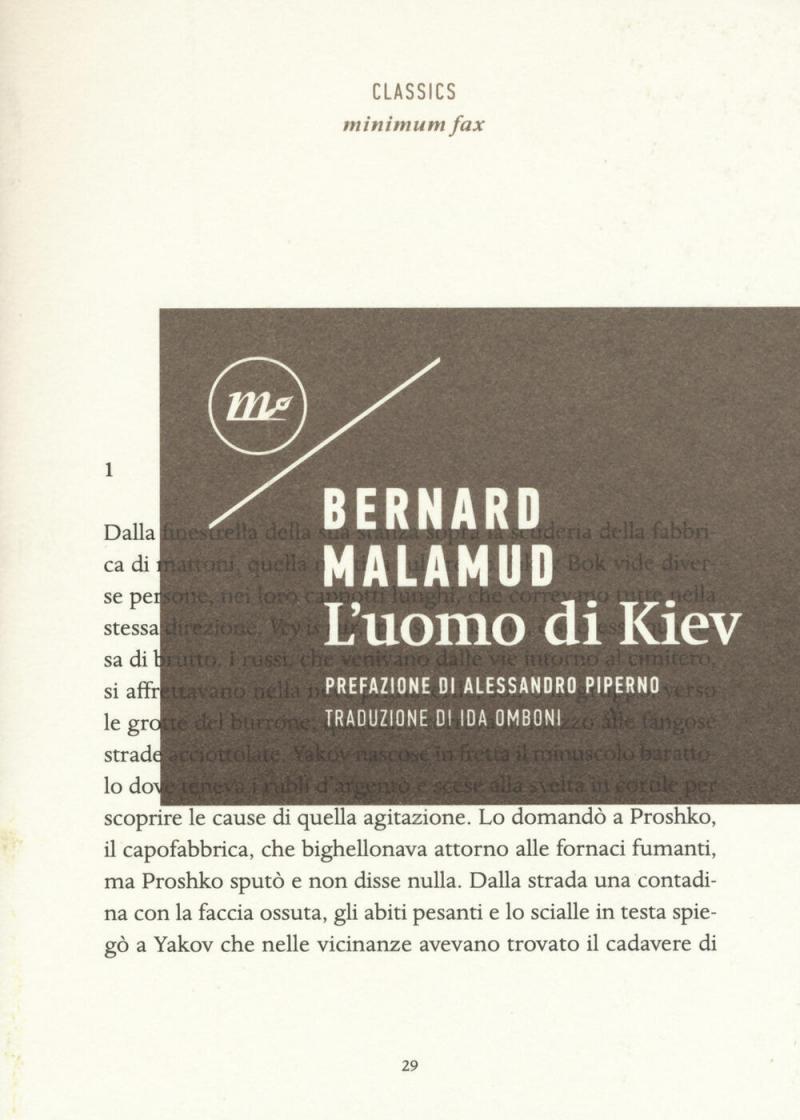
Torniamo allora a Noi rifugiati per capire come si tratti di un invito anzitempo a sfuggire da una tale morsa. L’appello arendtiano in apertura – “anzitutto non vorremmo essere definiti ‘rifugiati’” (p. 3) – è la celebrazione di un’impossibilità linguistica che rigetta tanto l’esclusione quanto l’assimilazione. Dinanzi a chi è costretto a trovare riparo in terra straniera, perché le condizioni di vita in terra natia si sono fatte impossibili, è già sempre impermeabile a qualsiasi intento definitorio o di categorizzazione politica. Questo perché la condizione del rifugiato ha una capacità di linguaggio che potrebbe dirsi negativa: una condizione che non ha nome e forse non lo avrà mai; una condizione che a chi rifugiato non è rimarrà sempre inaccessibile. Ed è così che, per chi rifugiato non è, la presenza di una vita destinata a non avere più mondo (quel mondo di vita che la cultura d’origine solo permette) dà accesso a qualcosa che non ha sinonimi nel nostro linguaggio. Qualcosa che Edward Said nota in Nel segno dell’esilio (Feltrinelli 2008), quando si oppone alla coloritura romantica della figura dell’esiliato e al suo svilimento pietoso: il dolore individuale, proprio perché intriso di inaggirabile solitudine, si staglia come plastica alternativa alle forme famigliari e spontanee di declinare l’esistenza: il rifugiato, il migrante, l’esiliato, per il più noto critico dell’orientalismo, sono un invito permanente a non sentirsi mai a casa propria. E se egli esorta a trovare nella scrittura l’unica vera casa, questo non è tanto per la proclività di un intellettuale al lavoro intellettuale, che comunque rimane riservato a pochi, ma per un’intuizione cui Arendt dà intensità unica nelle poche pagine del suo saggio: il rifugiato consente in primo luogo un’operazione linguistica (che per il “parlessere” lacaniano, in fondo, è immancabilmente politica) quale l’invito ad abbandonare la lingua per trovare l’unica possibile linea di contatto (non linguale) in un doloroso senso di sradicamento. Un senso che dà il capogiro anche quando ce lo si figura come puro esperimento mentale.
Con parole che fanno da epitome a un secolo intero di sociolinguistica, Arendt scrive: “Abbiamo perso la nostra lingua, ossia la naturalezza delle reazioni, la semplicità dei gesti, l’espressione spontanea dei sentimenti” (pp. 4-5). E descrive con abilità quasi caricaturale gli sforzi vani e le illusioni compiaciute di chi crede di poter essere pienamente sé in una lingua che non sia quella nativa: “Già dopo un solo anno gli ottimisti tra noi sono convinti di parlare l’inglese come la propria lingua materna; e dopo due anni giurano solennemente di parlare l’inglese meglio di ogni altra lingua” (p. 6); e ancora: “Ci spacciamo per parlanti di lingua inglese, perché gli immigrati tedeschi degli ultimi anni sono marchiati come ebrei” (p. 23). L’esperienza di dislocamento in altra lingua si esercita sotto forma di un triplice strappo: dalla propria cultura, dalla propria gente, dal proprio senso della misura. Ed è pregevole la notazione di Di Cesare, che rileva come Arendt abbia inteso scrivere il testo in inglese perché voleva “far sentire la voce dei rifugiati” (Di Cesare, Hannah Arendt e i diritti dei rifugiati, p. 64) – una voce che costitutivamente manca di una lingua propria e che quindi sceglie una lingua franca.
Sacrificio individuale, innanzitutto come rinuncia al proprio mondo linguistico (quindi vitale), e redenzione di chi un mondo ce l’ha ancora (i cittadini del Paese ospite) ma riceve il dono, nella figura concretissima del rifugiato, di un’esperienza radicale, non escludono certo la chiave adottata da Giorgio Agamben qualche anno addietro (We Refugees, in 49 “Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures” 2 (1995), pp 114-119) e Di Cesare nel bel testo che correda il saggio di Arendt. Agamben legge Noi rifugiati come ciò che rompe l’identità tra natività e nazionalità, là dove il rifugiato mette in crisi la “finzione originaria della sovranità”. Il rifugiato è l’eccezione che denuncia l’impostura del confine e scardina la triade reificata, se non santificata, di Stato/nazione/territorio. Di Cesare richiama la celeberrima formula arendtiana del “diritto ad avere diritti” come ciò che svela, e a un tempo smentisce quale paralogismo, il “paradosso dei diritti umani che si è rivelato il paradosso stesso della democrazia” (p. 84). L’idea che la democrazia possa stabilire un al di qua e un al di là del diritto, e che chi abbia la tragica sfortuna di stare più là che qua non possa godere di alcuna protezione, è per Agamben e Di Cesare la meno nobile delle finzioni fondative dei regimi liberali nati entro la cornice statuale.
E si potrebbe qui sciorinare una bibliografia che conta migliaia di titoli sul tema, che a ragione potrebbero esser letti come involontarie glosse al saggio di Arendt, se qualcosa in me non tendesse a ritrovarvi Bok più che Hans Kelsen o Lelio Basso. Il rifiuto di Arendt di rappresentare un dramma collettivo è il rifiuto – beninteso: mai capriccioso, ma ponderato e sofferto – di costruirsi un’altra lingua e un’altra cultura nella lingua e nella cultura degli ospiti. Arendt mette in scena chi non ha altra opzione che farsi carico di una condizione di alterità che non ammette vie d’uscita se non l’autoeliminazione in sordina – là dove l’atto estremo del suicidio non fa che rappresentare con strepito e clamore quanto la mera permanenza in vita del rifugiato fa già di suo. Certo, questa è una chiamata a ripensare l’intero assetto politico della modernità, di cui il rifugiato si fa inconsapevole vettore. Ma ben più che questo, sciocca lo scacco cui la sua pura presenza ci mette innanzi: quello di una vita senza mondo, che rimane pura biologia, come per le adorabili bestiole di Jakob von Uexküll, dotate certo dell’ambiente (Umwelt) che l’istintività permette loro, ma prive di quel mondo (Welt) in cui si può dire ciò che si fa. Il rifugiato di Arendt rifiuta il “privilegio dei non-ebrei” (p. 30) per vantare il marchio di “fuorilegge”, in un mondo in cui la prima e più incisiva legge è quella veicolata dal linguaggio e dalla sua capacità impareggiata, e forse impareggiabile, di cosmopoiesi.
Il rifugiato mostra che c’è un fuori che è ancora vita, che resiste alla presa del linguaggio e però mantiene una sua leggibilità piena. Come la poesia per Luciano Anceschi, il rifugiato è un “barocco senza implicazioni religiose e senza sacralità”, è vita “dissacrata, estroversa, che si ritrova in un mondo di oggetti reali, […] tale che si è resa conto della propria temporalità, e può farsi capace di una critica di vita, di un’azione per la trasformazione dell’uomo” (Luciano Anceschi, Poetiche del Novecento in Italia, Marsilio 1990, p. 297). Se c’è un pregio del saggio di Arendt, e ce ne sono molti, è che non si rifiuta mai di farsi carico di questo, che rimane sempre un dramma di singoli individui. A costoro non si può certo chiedere di ripensare l’intero assetto delle istituzioni mondiali, ma si deve piuttosto riconoscere il merito (costosissimo) di una resistenza che, noi privilegiati abitanti di mondo, dovremmo saper fare nostra, almeno in parte – quella parte almeno che ci parla nei sogni più inquietanti, quando rimaniamo sgomenti dinanzi a qualcuno che ci parla e le cui parole ci rimangono indecifrabili.