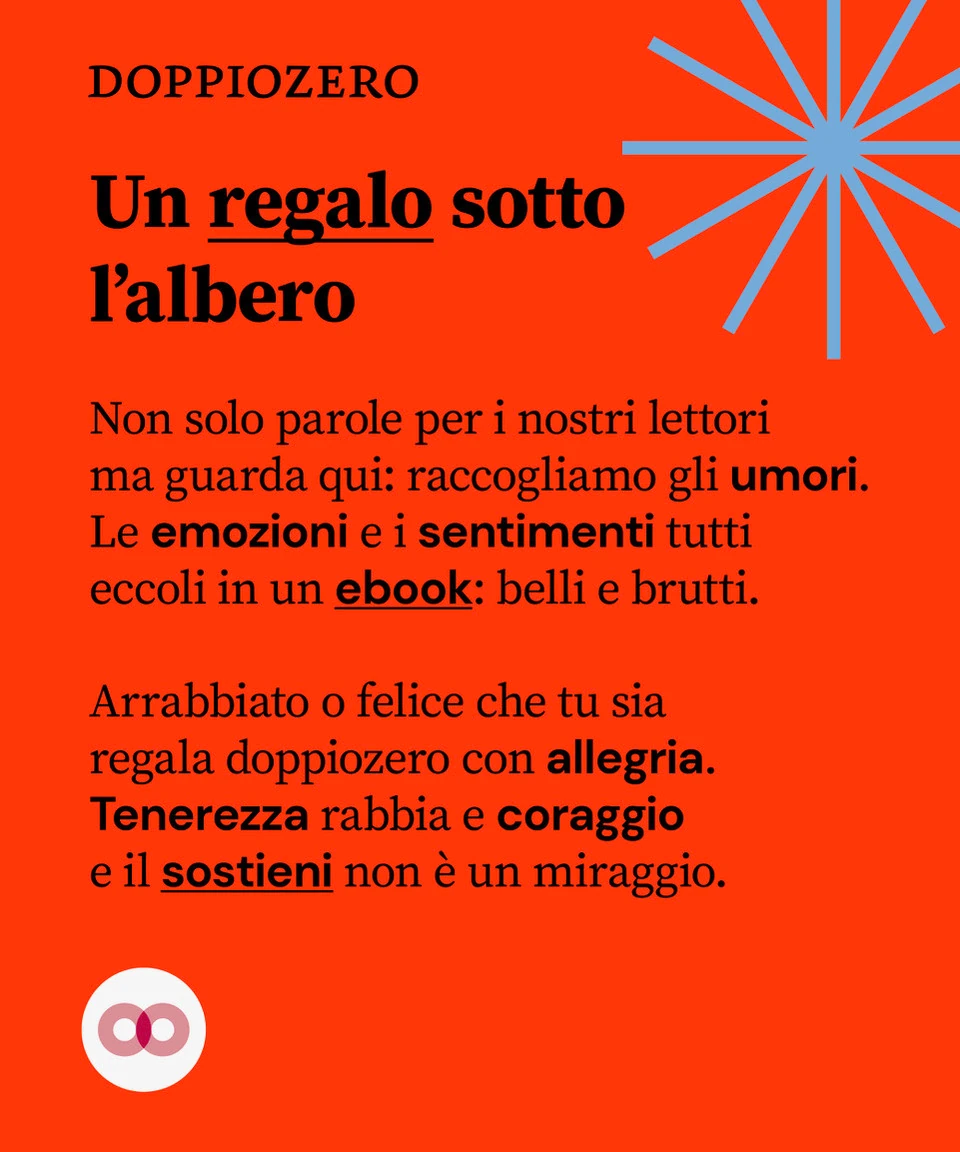L’estate dei festival: Castiglioncello / Di padri e di belle bestie
Sono in tre, padre, figlia, figlio, così nella vita, come sulla scena di Padre nostro di Enrico Castellani e Valeria Raimondi; si chiamano con i loro nomi, Maurizio Bercini, Olga Bercini, Zeno Bercini, appaiono schierati uno accanto all’altro con il pater familias al centro, un sessantenne fuori forma, che sembra piuttosto orgoglioso del suo aspetto né canuto né giovanile, da reduce imbolsito di guerre perdute al quale i favoriti e il pizzo bianco danno un’aria da biker o da folksinger americano. D’altronde li accompagna la voce di Tom Waits, che, impastata di tutta l’umanità di questo mondo, canta Anywhere I Lay My Haed, come all’inizio di una funzione religiosa celebrata da un pastore con la pistola nascosta dentro la Bibbia. Davanti a loro, uno di quei set di candele elettriche che sempre più spesso nelle chiese sostituiscono le candele di cera. I figli tendono la mano al padre e lui consegna a ciascuno di loro una moneta. I ragazzi la inseriscono nella feritoia di ferro e non succede nulla. Perché qui non siamo in un teatro, ma praticamente in mezzo al mare, il palco su cui si alza il terzetto è uno scoglio piatto che affiora a pochi metri dalla spiaggia del Cardellino, a Castiglioncello, sono le sette e mezzo del mattino – l’ora più inadatta per uno spettacolo – fa già caldo e gli spettatori della XXII edizione del festival Inequilibrio attendono, seduti sulle stuoie, tutto quello che si può aspettare, temere, immaginare, da un dramma familiare firmato Babilonia Teatri.

Attendono che si apra il fuoco con quel mitragliamento serrato di parole che non ammette ripensamenti tipico delle drammaturgie del duo veneto. E non attendono invano, Zeno e Olga, assediano il vecchio con un martellante elenco di recriminazioni, dove la più gentile recita: “Quando mio padre mi ha partorito ce l’ha messa tutta / ma sinceramente quando mi ha partorito mia madre mi sono trovata meglio.” Per un verso Padre nostro rientra a pieno titolo nelle liturgie di Babilonia Teatri, nella loro percussione recitativa dove poesia e invettiva sono inseparabili come il grano e il loglio della parabola evangelica, con quella pointe ironica che, puntualmente, rimesta nel torbido disordine del simbolico: “Che bello il padre – salmodia il testo di Castellani nella bocca di Maurizio – che belle le sue dimissioni / le dimissioni del padre da padre che bello /…/ che bella la fine del padre / che bello il suo funerale che bello / la morte del padre che bello / che bello il paradosso del padre / che bello quel che resta del padre (…)”.
Ma per un altro verso è il contrappunto dei corpi, qui ritagliati sull’orizzonte aperto e infinito del mare, che rompe e ridefinisce il ritmo autoritario della litania: è nel gesto del padre che ghermisce la nuca dei figli affondando le loro teste nell’acqua, e in quello dei figli che poi lo affogano insieme, con altrettanta spietatezza, che si condensano secoli e secoli di tragedie e di sacrifici rituali, di vendette e di ritorni, di parricidi e di infanticidi. È il carattere cerimoniale – o ludico e cioè profano, il che è lo stesso, dal momento che sono i medesimi gli effetti prodotti – della messinscena dei Babilonia a provocare nello spettatore una ricapitolazione emotiva devastante, una specie di ricordo di tutti e di nessuno, dove chiunque riconosce il padre che ha avuto, la sua crudeltà, la sua assenza, la sua violenza, la sua reticenza, il suo fallimento, il desiderio inesausto di ricomporre la distanza con il suo corpo (di tornare a riposare nel “nulla del padre” come dice un verso di René Char) o, con un processo ancora più lancinante, le stimmate ambigue dei padri che siamo nell’era della dimissione del padre: la stessa sofferenza unita allo stesso narcisismo ferito, poiché, ancora e di nuovo – come esclamava Roland Barthes – soltanto il figlio è vivo in questa estenuante decostruzione e ricostruzione del corpo del padre che sugli scogli affioranti del mare di Castiglioncello assume l’aspetto di una deposizione (un momento che notoriamente non esiste nel testo biblico, è stato direttamente inventato nel teatro dell’iconografia).

Babilonia Teatri, Inequilibrio, ph Antonio Ficai.
E se è il mare, nel suo instancabile andare e venire, che lava e lenisce le ferite plurime inflitte dalla rappresentazione a un corpo che a un certo punto diviene quello disteso di una dissezione anatomica, con tanto di cerotti apposti per indicare gli organi vitali, sono i gesti con cui Zeno e Olga, i figli, rivestono il padre a rischiarare con una pietas minuta e piena di amore la scena di un sacrificio necessario non perché esso sia inscritto nella vita, come una legge o un destino, ma perché tale è nel dispositivo implacabile di una cultura, nel nostro retaggio (ne abbiamo uno, infatti, e sta proprio nell’attraversarlo facendo risuonare le pareti di un immaginario apparentemente senza memoria che consiste la forza critica del teatro dei Babilonia).
Al vertice dell’inno corporale di Padre nostro precipita una preghiera parodistica, pronunciata dai figli in coro, di una tale potenza derisoria – padre nostro che sei in cucina… ricorda i tuoi obblighi e i tuoi doveri / ma non invocare diritti – dal fare impallidire tutta la sociologia spicciola a cui il naufragio del padre ha finito per dar luogo nel tentativo di imbastire una morale par provision della paternità senza il patriarcato, ma è proprio perché il re è più che mai nudo – è addirittura scorticato – che possono ricadere, limpide e quasi inaudite, le parole del padre nostro originario pronunciate da un esausto Maurizio Bercini. Da questo spossante corto-circuito tra il padre simbolico e quello reale, alla fine sarà quest’ultimo (come è giusto) a sopravvivere, perché nella lotta tra la vita e la forma – che sono poco più di due idee – è sempre ciò che è vivo a svincolarsi e a riemergere, grondante, tagliuzzato, e non si sa come, d’ora in poi, Enrico Castellani e Valeria Raimondi potranno fare a meno del sesto atto di questo mare in cui i tre, dopo essere apparsi in un’ultima immagine con una coppa alzata, si tuffano, sguazzano, e si allontanano nuotando sotto lo sguardo commosso di un manipolo di spettatori che non applaude il loro ritorno, ma la loro felice sparizione.

Sarteanesi e Bosi, Inequilibrio, ph Antonio Ficai.
C’è una provincia carnale, profonda, che insiste negli spettacoli di Babilonia Teatri, a cui il teatro consente di trasformarsi senza grandi sforzi, con un leggero scarto d’umore, imboccando le scorciatoie analogiche dell’immaginario, in altre province che, per quanto lontane nello spazio, esprimono la medesima, rabbiosa distanza dai rispettivi centri metropolitani. Ma, a pensarci bene, c’è nel teatro che si fa e si vede al festival Inequilibrio, che quest’anno dedica un’attenzione particolare alla sovversione – Tre stanze – I sovversivi si intitola lo spettacolo di Garbuggino-Ventriglia, recensito la scorsa settimana da Massimo Marino, che ha aperto la rassegna – una vocazione a strappare dalla minorità le lingue periferiche dell’espressione artistica, a rovesciare il piatto dei valori più o meno (sempre meno) costituiti, e costituiti ovunque tranne che sulla scena.
In fondo, Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi, non hanno fatto altro con Bella Bestia, andato in scena all’auditorium del Castello Pasquini, che portare sul palco il proprio mondo, che è un mondo di toscanità senza compiacenza, ironica, amara, a tratti persino arcigna, dove si sentono ancora i riverberi delle campagne isolate e spaccate dal sole dei romanzi di Federigo Tozzi. Ma è il come l’hanno fatto a depurarlo di colpo dei suoi idioletti e delle sue possibili derive espressive: senza rinunciare alla musica dei propri accenti ma scavando nelle proprie identità biografiche fino a recuperare un dialogo scarnificato e a tratti arieggiato dal non sense tra due donne sole, sedute su due sedie da giardino, circondate da niente, se non dal beffardo moltiplicarsi, a ogni cambio di luce, del simulacro di un cane – un doberman in vetroresina, la metaforica bella bestia del titolo pronta a mutarsi da morboso oggetto di fascinazione in ossessione senza uscita, da custode in carnefice.

Sarteanesi e Bosi, Inequilibrio, ph Antonio Ficai.
Sarteanesi e Bosi parlano ascoltandosi, anche quando sulla scena le loro proiezioni figurali, visibilmente, non si ascoltano, la prima sporgendosi di più oltre il bordo del proscenio, ma, facendo vagare lo sguardo su un interlocutore inafferrabile, e perennemente assente – come i tanti improponibili partner conosciuti in rete, scartati uno dopo l’altro con un esilarante catalogo dongiovannesco al contrario – la seconda cullandosi nella propria intimità e in una stoica, quanto irrisolta, relazione con il male (fisico) che l’ha contagiata. Tra loro, il ricamo di reticenze dell’amicizia, e gli improvvisi salti in avanti di una sincerità tutta femminile, pronta a svegliare l’altra, ma incapace di applicare la medesima cura a sé stessa, e, soprattutto, il rimpallo continuo ed elusivo con cui ciascuno (donna o uomo) pensa di sedare le proprie angosce, di tenere a bada le proprie nevrosi, carezzandole e vezzeggiandole come un innocuo cagnolino da compagnia.
In questa trama piena di vuoti, scolpita da accurate zone d’ombra, potrebbe passare di tutto – persino un trattato morale sull’insondabilità del male – ma le due attrici hanno l’intelligenza di saggiare il confine tra il pianto e il riso senza mai travalicarlo, di tenersi al di qua del dire smanioso per gettare il cuore, cioè l’interpretazione, oltre l’ostacolo. Ed è in questa progressione, dapprima timida, che arrivano, colpiscono, toccano, e finalmente sono.