I filosofi di Hitler
«L’uomo “germanico”, l’uomo “nordico” viene eretto a canone in confronto al quale si misura la validità delle opinioni sul mondo».
Walther Schulze-Sölde, professore di filosofia a Innsbruck e militante nazista
Con I filosofi di Hitler (Bollati Boirnghieri), Yvonne Sherratt ha scritto il libro di sintesi che mancava nello scaffale del cultore italiano di studi filosofici: la storia di come la filosofia tedesca, la filosofia per il ruolo che per lungo tempo ha ricoperto nella storia della cultura europea, sia stata coinvolta in tutte la vicende di violenze e violazioni dell'umano che iniziano con l'esaltazione nazionalista e attraverso il razzismo sfociano nel genocidio. La storia a cui ha girato intorno chiunque si sia formato dal dopoguerra in ambiti filosofici, con livelli di rimozione più o meno inversamente proporzionali al proprio livello di impegno politico in senso antifascista.
(Nota bene: ho avuto una formazione filosofica, in una scuola che della rilettura della tradizione idealistica e post-idealistica tedesca ha fatto uno dei suoi punti di forza, e quindi parlo soprattutto di me.)
Ignorando di avere scheletri sepolti nel giardino ci siamo difesi da quella storia, a volte usando l'interpretazione come alibi, altre volte distinguendo gli uomini dai testi, in ogni caso ignorando alcuni dati fattuali incontrovertibili. Benché queste possano essere operazioni talvolta legittime se fatte con accortezza, consapevolezza e dichiarate in ambiti di ricognizione teorica ben circoscritti, non si può ignorare il radicamento del nazismo in determinato ambienti culturali; e viceversa all'interno di un sistema totalitario non si può non pensare alle pratiche politiche e agli atti di rilevanza istituzionale di studiosi intenti a opere di ingegno, che tendenzialmente aspirino ad avere risonanze esistenziale ed etiche.
Sherratt scrive che ancora oggi «alcuni dei concetti insegnati nelle aule universitarie ebbero origine dalla mente dei collaboratori di Hitler». Se la collaborazione di un intero popolo a un totalitarismo è un enorme problema, lo è a maggior ragione se riguarda i filosofi, un gruppo «particolarmente schivo e tranquillo» che godeva (e ha goduto nel dopoguerra) di un enorme prestigio.
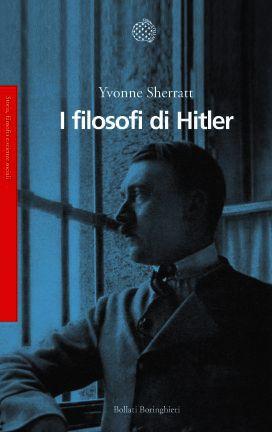
Hitler diede vita a una potente macchina mitologica, all'interno della quale la filosofia ricopriva un ruolo importante per il valore culturale che la tradizione tedesca era in grado di capitalizzare, realizzando fin dal tardo Settecento una (inesistente) continuità ideale tra la Grecia e la Germania. Persino l'illuminismo di Kant era screziato di antisemitismo – in quanto gli ebrei erano rappresentati come una riserva di selvaggio irrazionale da civilizzare: a posteriori l'autorità dell'autore del «cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me» poteva dunque avallare l'antisemitismo di matrice scientifico-positivista e quello della tradizione teologica, persino diventare un argomento di difesa giudiziaria: Heichmann a Gerusalemme potrà sostenere il dovere di obbedire agli ordini richiamandosi a un'interpretazione, davvero sfacciata, dell'imperativo categorico.
Anche senza contare le interpolazioni e le reinterpretazioni ideologiche del nazionalismo, diverse ad esempio in Fichte o in Hegel, Nietzsche non avrebbe avuto bisogno del lavoro di riedizione della sorella per diventare un punto di riferimento antimoderno e reazionario. Durante la Grande guerra 150.000 copie di Also spracht Zarathustra vennero distribuite ai soldati tedeschi al fronte, in contesto e con effetti diversi comprensibilmente diversi da quelli che ha avuto sui post-strutturalisti francesi (o sugli allievi dei corsi di Teoretica della stagione 1992/96 che ho seguito).
Scrive Sherratt: «il passato della nazione brulicava di teorie riguardanti lo Stato forte, la guerra, il Superuomo, l’antisemitismo e, infine, il razzismo biologico. Al di sotto del nobile retaggio tedesco si celava questo lato oscuro. Dimentichi dei principi morali e senza alcuna preoccupazione concreta, i filosofi tedeschi avevano porto alla civiltà europea un calice avvelenato che Hitler avrebbe presto sfruttato a suo vantaggio».
Rosenberg, Bäumler, Krieck furono «i maggiori artefici dell’infiltrazione nazista nelle università» dal 1933 e gli esponenti di spicco di una metafisica identitaria a sfondo razziale: più che di filosofia si trattava di una «religione del sangue», una riscrittura fantastica della storia in chiave di mitografia della razza ariana. L'antisemitismo, dalla rimozione della matrice giudaica dal cristianesimo alla teoria dell'incrocio degenerativo delle razze alla critica economico-politica del complotto pluto-giudaico-massonico, fu il plesso fondamentale di una rete discorsiva che si presentava plausibile proprio a partire dal suo radicamento nella cultura pregressa per finire con il sostegno che ad essa veniva dato da uomini colti che ricoprivano cariche di prestigio.
Odio per le idee liberali, pacifiste e individualiste si accompagnava alla promozione del fervore militaristico e di una comunità «organica» costruita su base etnica e nazionale, organizzata in chiave pedagogica attorno all’importanza della razza e della stirpe. La pubblicazione più influente in tal senso fu il Manuale per il lavoro formativo nella Gioventù Hitleriana (1936), distribuita a sette milioni di giovani: rivolto alla fascia di età tra i quattordici e i diciotto anni, era obbligatorio in tutte le scuole.
«Oltre milleseicento studiosi furono allontanati dai loro incarichi. Si trattava soprattutto di accademici ebrei, costretti a ritirarsi a vita privata o ad andare in esilio, ma presto anche coloro che avevano legami ebraici di qualsiasi tipo – come il filosofo e psichiatra Karl Jaspers, sposato con un’ebrea – subirono la stessa sorte». I filosofi della germanità guidarono la crociata contro i libri degenerati, contro «la letteratura dell’Asfalto» e «del Nichilismo intellettuale» accusato di sradicare i tedeschi dal Volk e dalla comunità: dalle biblioteche e dalla librerie sparirono autori politici, Marx, Engels e Lukács; gli psicoanalisti, soprattutto Sigmund e Anna Freud; filosofi di origine ebraica come Husserl, Benjamin e i francofortesi; teologi dissidenti come Paul Tillich. Scrittori come Tucholsky, romanziere e militante socialista, o Schnitzler, medico e scrittore austriaco; i fratelli Heinrich e Thomas Mann, comunista il primo e liberale conservatore ma antinazista il secondo (che si troverà a essere, da premio nobel in esilio, il simbolo della cultura tedesca dell'emigrazione). E poi icone democratiche come Heinrich Heine o stranieri, come Hemingway.
A portare i libri tra le fiamme nel maggio 1933 furono professori e studenti universitari, non le SS o le SA. A Berlino partecipò al rito lo stesso Joseph Goebbels, ministro nazista della Propaganda, che esaltò la «purificazione della cultura tedesca» di fronte a circa 40.000 persone: a officiare, Bäumler, titolare di una cattedra di Pedagogia nazista e autore della monografia nazisteggiante più importante su Nietzsche.
La promozione del nazionalsocialismo fu condotta attraverso la censura e la manipolazione dei programmi di ricerca, con strategie di cooptazione, promozione e finanziamento, da enti di ricerca come l'Istituto del Reich per la storia della nuova Germania, che includeva un Dipartimento di ricerca sulla questione ebraica: i progetti mostravano l’influenza negativa di Spinoza sulla storia della filosofia e criticavano l'«appropriazione ebraica» dell'hegelismo. Mentre il sistema concentrazionario entrava in funzione e ampliava il suo raggio d'azione, la ricerca antisemita procedeva con le inevitabili contese per le risorse e per il rango delle Università.
Hitler desiderava ardentemente una legittimazione giuridica e auspicava l'affermazione del genio tedesco contemporaneo di rilevanza internazionale: Carl Schmitt e Martin Heidegger gli permisero di realizzare questi obiettivi. Il primo avallò la presa del potere nazista, giustificando la legge dei pieni poteri del 24 marzo 1933 che sanciva la «dittatura sovrana»; arrivò perfino a definire l'omicidio politico come la «forma più alta del diritto amministrativo» (era il suo commento alla Notte dei lunghi coltelli).
Il secondo, aderendo al Partito e assumendo ruoli cruciali nell'Università, rese indistinguibile la sua ontologia dall'adesione al nazismo, che avveniva anche prendendo le distanze dalla fenomenologia del suo maestro, di origini ebraiche, Husserl, che non si riprese più dal suo allontanamento e che non si spiegò mai il comportamento dell'allievo diletto. Ma è qui il caso di aggiungere troppe poche parole a un dibattito interminabile. Saltando deliberatamente il discorso sull'ermeneutica che da Essere e tempo prende avvio, che necessiterebbe di una trattazione a parte, mi limito a citare due fatti sintomatici che testimoniano il fascino che il nazismo ha esercitato su Heidegger.
«Quando Jaspers, uno dei colleghi a lui più vicini [caduto in disgrazia per aver sposato un'ebrea], gli chiese: “Come può pensare che una persona priva di cultura come Hitler possa governare la Germania?”, Heidegger, con gli occhi che scintillavano, rispose: “La cultura non ha importanza. Osservi le sue meravigliose mani!”».
Nell'assumere il rettorato, il professore aveva fatto stampare sul programma della cerimonia l’inno del partito nazista con l’indicazione che venisse cantato dopo il discorso del Führer; queste le parole: «Alzate le bandiere, serrate le file! Il reparto d’assalto marcia con passo fermo e coraggioso, i camerati, assassinati dal fronte rosso e dalla reazione, marciano con noi tra le nostre file».
Sono alcuni segni inquietanti che mostrano alla nostra sensibilità post-totalitaria la vacuità etica di un uomo per cui, a dispetto degli interessi ontologici, l’estetizzazione del vivente e del politico e il loro precipitato di potere accademico paiono irresistibili. Ci sono anche buone ragioni per sostenere che il nazionalsocialismo del maestro dei maestri di molti maestri «non fosse affatto estemporaneo, bensì che si trattasse di una devozione profonda e anzi fondamentale per la sua stessa filosofia». Il concetto heideggeriano di «essere», nell’arco di una produzione teoretica che va dall'«essere-per-la-morte» al linguaggio come «casa dell'essere», sottenderebbe una forma metafisica di nazismo; la stessa differenza tra ontico e ontologico mi sembra oggi problematica da un punto di vista teorico e gravida di ipoteche teologiche; e inoltre la nozione di «inautenticità» era per lui una critica della modernità e una apologia della comunità di destino: se Löwith e Arendt o altri sono riusciti trarre qualcosa di buono da un'impostazione effettivamente innovativa e da un linguaggio tanto affascinante quanto ambiguo e suscettibile di letture differenti, è perché hanno lavorato molto e in senso originale sul concetto di Mit-sein, «con essere» o hanno saputo reinterpretare l’autenticità come un rifiuto della reificazione capitalistica.
Dopo la guerra la reputazione di Heidegger è stato graziata dal fatto che molti suoi ex-allievi, Sartre e molti altri, perfino Marcuse e Adorno, hanno voluto distinguere l'uomo dal testo; Gadamer, poi, urbanizzandone il lavoro ha salvato il maestro dal punto di vista teorico; in Italia, Pietro Chiodi, partigiano combattente in una Brigata Garibaldi, lo ha tradotto e usato 'da sinistra', permettendo lo sviluppo di un heideggerianesimo italiano molto interessante. In breve, la mia impressione è che sia stata soprattutto la produzione del commentario cresciuto intorno alle opere di Heidegger, di sviluppi e contaminazioni con altro che arrivano a fino a Derrida e Foucault, a rendere feconda e utile la sua produzione teoretica, più che non la sua instabile lettera.
Il punto debole del libro di Sherratt sta forse nell’approccio storico, molto anglosassone che riduce ogni discorso di filosofia alla sua sintesi, alla lettura immediata e agli effetti concreti che alcune idee chiave ebbero nel tempo, senza lasciare spazio al cammino e alla produzione di significati nella storia culturale: ma questo è anche la sua forza perché affronta direttamente il discorso che riguarda status e potere dei professori universitari. Sherratt scrive ad esempio che Heidegger ha usato il tema della scarsa militanza nazista per fare mobbing ai colleghi e regolare conti di bottega. Mostra come i posti resi liberi dai provvedimenti razziali hanno fatto gola a molti; sottolinea come piaggerie e opportunismo mal si addicono a figure che ambivano a una statura morale superiore ed esemplare.
Resta il fatto che tra il 1940 e il 1944 Heidegger continuò ad appoggiare il regime hitleriano e in particolare la guerra d’aggressione. La recente pubblicazione in Germania dei Quaderni neri, 1931-1941 mostrerebbe inoltre quale ruolo teorico avesse il suo antisemitismo. Ma colpiscono proprio i dettagli umani se, dopo la guerra, Heidegger «che non si era tirato indietro all’idea dell’omicidio di massa in nome del Volk ebbe un crollo emotivo quando vide minacciato il proprio prestigio accademico»: nonostante le conseguenze delle denazificazione sulla carriera fossero stati assolutamente miti, non ci sarebbero state parole di ripensamento.
La pagine più dolorose del libro di Sherratt, che sceglie apertamente di scrivere un docudrama, sono quelle dedicate alle vittime, ai filosofi che patirono le conseguenze della loro condizione. Di ebrei, intellettuali, dissidenti, emarginati. Le conseguenze furono tanto più gravi quanto fu per loro difficile emigrare e salvare loro stessi e le loro famiglie. Benjamin, Arendt, Adorno e Kurt Huber, il professore animatore della Rosa Bianca e per questo giustiziato, emergono con tratti personali e intimi che stridono dolorosamente con le storie dei colleghi dei capitoli precedenti: vincitori sul mercato delle idee e carrieristi accademici le cui vicende paiono di rara meschinità e squallore.
L'amarezza più forte giunge al capitolo sulla denazificazione e sul ritorno degli emigrati sopravvissuti. Ed è ben riassunto dalle parole che Adorno rivolse al collega Hofstätter, ex nazista, che lo accusava di voler opprimere la nazione con il senso di colpa. «L’orrore di Auschwitz, se lo sono dovuto assumere le vittime, non coloro che non lo vogliono ammettere». Dopo la guerra il gruppo degli accademici si è tutelato salvando i giganti come Heidegger e Schmitt per salvaguardare tutti e rimuovere sistematicamente il passato.
A settant’anni di distanza dalla guerra, saltando fuori dal cerchio dell’indignazione o da una difesa istintiva del proprio canone formativo, in presenza di una documentazione molto vasta e articolata, è auspicabile anche in altri campi disciplinari l'apertura di ragionamenti seri sulla validità di teorie intrecciate a biografie intellettuali moralmente inaccettabili nei loro presupposti. Ne va della capacità di distinguere il senso delle parole delle vittime da quelle dei persecutori.







