Speciale
intervista a Mugendi M’Rithaa / Design africano
“Finché i leoni non avranno i loro scrittori, i racconti di caccia continueranno a glorificare il cacciatore”.
Proverbio nigeriano
lettera27 e Mugendi M’Rithaa si sono incontrati a Milano in occasione della sua presentazione a Meet the Media Guru - Future Ways of Living, in collaborazione con la Triennale di Milano che si è tenuta alla Fabbrica di Vapore. L’intervista che segue è il risultato di un'appassionante conversazione tra Mugendi M’Rithaa, Elena Korzhenevich, Adama Sanneh e Tania Gianesin. Ringraziamo in particolare Anna Barbara e Luca Poncellini per aver contribuito "da remoto", con spunti e domande stimolanti che ci hanno guidato nell'intervista.
Elena Korzhenevich: In qualità di curatore di Design Indaba, uno dei più importanti festival africani dedicati alla creatività, può dirci qual è l’idea di fondo che anima quest’iniziativa?
Mugendi M’Rithaa: Design Indaba si tiene ogni anno da ventidue anni. Mi occupo in particolare della sezione dedicata al design industriale. Alla base di Indaba, organizzazione per la quale nutro un profondo rispetto, vi è la consapevolezza che il potenziale creativo dell’Africa è ancora del tutto inesplorato. L’idea non è soltanto quella di portare il talento creativo in Africa, a beneficio delle industrie creative africane, ma anche di mettere in mostra le pratiche creative emergenti nel continente. In questo senso, Design Indaba è una piattaforma molto importante che mette a confronto in uno spazio dialogico designer internazionali e locali (e quando dico “locali” intendo “africani”, non solo di Città del Capo o sudafricani). Design Indaba è anche una piattaforma online volta a promuovere i migliori prodotti di design, attraverso il progetto “The most beautiful object in South Africa”: può trattarsi di un’app, di una sedia o perfino di un lavoro a maglia ispirato alla cultura locale. L’idea di fondo è quella di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su ciò che accade nel continente africano dal punto di vista creativo.
 Mugendi K. M'Rithaa.
Mugendi K. M'Rithaa.
E.K.: Come mai, secondo lei, dopo tutti questi anni di attività, il design africano è ancora così poco conosciuto qui in Occidente? Quali ostacoli ha incontrato nel cercare di diffonderne la conoscenza a livello internazionale?
Vi è, a mio parere, un duplice fattore. Da un lato, il problema riguarda l’Africa: siamo noi stessi a non aver raccontato in maniera adeguata la nostra storia. Come dice il proverbio nigeriano, “finché i leoni non avranno i loro scrittori, i racconti di caccia continueranno a glorificare il cacciatore”. La sensazione è che designer e creativi africani non abbiano sufficiente fiducia nel proprio talento creativo, quindi noi stessi tendiamo a imitare ed esaltare ciò che arriva da fuori. E questo è il primo problema. Il secondo riguarda la visione stereotipata che il mondo ha dell’Africa, che non aiuta a comprendere come l’Africa abbia molto di più da offrire, oltre all’artigianato. Gran parte di ciò che viene visto come arte o design africano viene solitamente associato a forme artigianali del tutto rudimentali, etichettate come tradizionali o etniche. E ogni volta che un designer africano tenta di discostarsi da quelle forme e sperimentare qualcosa di più moderno e cosmopolita, la gente fa di tutto per riportarlo verso l’etnico.
E.K.: Ha anticipato una delle domande che volevo farle: perché, secondo lei, il pubblico internazionale tende a pensare al design africano come a un insieme di souvenir esotici o kitsch, anziché concentrarsi sugli oggetti esteticamente più interessanti che vengono prodotti ogni giorno in Africa?
 Sibusis Brian Mokhachane,backpacks, Accessories designer and Social enterpreneur, South Africa.
Sibusis Brian Mokhachane,backpacks, Accessories designer and Social enterpreneur, South Africa.
A rischio di semplificare eccessivamente la questione, la riassumerei in due parole: la prima è ignoranza. Nessuno lo ha informato meglio, per cui il pubblico non conosce la ricchezza del panorama creativo africano. Ecco perché è fondamentale il ruolo di un’organizzazione come la vostra nel promuovere una visione alternativa del mondo e dell’Africa all’interno di un contesto globale. La seconda parola è arroganza, che dal mio punto di vista si traduce nel rifiuto di accettare che dal continente africano possa nascere qualcosa di eccellente, entusiasmante e del tutto innovativo. Sull’ignoranza possiamo agire, promuovendo una maggiore informazione, ma l’arroganza va affrontata con forza, perché qualunque cosa diciamo, la gente ha già un’idea ben precisa e non è disposta ad ascoltare.
E.K.: Crede abbia senso parlare di design africano? Cosa si intende per design africano?
No, credo che l’Africa sia troppo grande perché si possa parlare di un “design africano”. Anche un Paese come l’Italia, di dimensioni estremamente ridotte a confronto con l’Africa, varia enormemente da città a città, per cui ridurre l’Africa a un’unica idea o rappresentazione stilistica è errato. Si può parlare di elementi di design per i quali si riscontra una certa comunanza tra i vari Paesi africani, come ad esempio l’uso di colori e materiali rustici, legati alla terra, o la ricorrenza di determinati motivi o elementi cromatici, ma in tutta onestà non posso affermare che esista qualcosa di definibile come “design africano” o “stile africano”. Credo che sarebbe un insulto alla creatività di un continente popolato da più di un miliardo di persone e composto da 54 Paesi. È troppo ricco per poter essere ridotto a un unico concetto.
E.K.: Sarebbe un po’ come dire “design europeo”, non avrebbe senso…
Esattamente. Se prendiamo il design di IKEA e lo chiamiamo design europeo, sarebbe un insulto nei confronti di molte altre forme di design. Anche se proviene dall’Europa e ha una sua chiara riconoscibilità dal punto di vista estetico, non vuol dire che sia questa l’unica tipologia di design prodotta in Europa. La mia sfida personale è proprio questa: difendere il continente africano ogni qual volta se ne presenta l’occasione.
E.K.: Se dovesse indicare alcuni temi o concetti chiave che l’Africa propone per il nuovo millennio, quali sarebbero?
Un primo tema è l’informalità. L’idea che le cose non debbano essere necessariamente formali per poter essere considerate una forma d’arte o di design. Il secondo è l’hackability: la capacità di trasformare, combinare, mutare la destinazione degli oggetti, far funzionare qualcosa unendo vecchio e nuovo, mescolando, mettendo insieme Africa e Occidente. Un altro concetto chiave è l’ibridazione. L’idea di non perseguire forme pure, ma combinare in maniera pragmatica diversi elementi. E poi vi è l’autenticità, che vuol dire non nascondere nulla alla vista: se, ad esempio, nel design vi è un filo metallico, esso rimane visibile, non viene trasformato in qualcosa di irriconoscibile, diventa pura espressione.
E.K.: Il tempo è uno dei parametri fondamentali del design. Oggi vi è un design “usa e getta” e un design orientato al recupero. Un design che produce scarti, immondizia, e un design che nasce da quell’immondizia. Qual è il modello al quale si ispira o intende orientarsi il design africano?
La verità è che esistono entrambi i modelli e questo nasce da una necessità. L’hackability, la riciclabilità, l’informalità fanno parte della realtà in cui vivono la maggior parte degli africani. Ovviamente vi sono anche africani che possono permettersi di creare mobili nuovi, per cui non vi è solo il riciclo o il riuso di materiali esistenti: si realizzano anche delle cose nuove. Vi sono, quindi, entrambe le cose, ma se dovessi indicare delle percentuali, direi che vi è un 20% di nuove creazioni e un 80% di materiali riciclati; e questo nasce da un’esigenza pratica.
 Madri Van Zyl Iioni jewellery, Jewellery designer, South Africa .
Madri Van Zyl Iioni jewellery, Jewellery designer, South Africa .
E.K.: Le forti ondate migratorie verso il nostro Paese hanno generato nuovi modi di vivere gli spazi, di consumare. È possibile concepire questi immigrati come il nuovo target di un nuovo design? Quali risposte dà il design alla nuova emergenza migratoria?
Come disse una volta un mio amico dello Zimbabwe, “l’Africa non è povera, ciò che le manca è soltanto una gran quantità di denaro”. Quello che ha l’Africa è l’umanità. Quando penso agli immigrati che dall’Africa arrivano in Europa e nel resto del mondo, penso all’umanità che essi portano con sé. Un’umanità che si traduce in un senso di comunità. Vedo come la tecnologia ha ridotto al minimo l’interazione tra le persone. La tecnologia, a mio parere, dovrebbe essere un supporto, non un elemento che si sostituisce alle relazioni umane. Alla base delle comunità africane continua a esserci l’idea che “io sono perché noi siamo”. Il rinnovamento che esse possono portare all’interno delle comunità europee è dunque legato alla centralità del fattore umano in ogni nostra attività. Riportare l’elemento umano al centro del mondo del lavoro, della vita sociale, delle innovazioni tecnologiche, del design: potrebbe essere questo un contributo davvero vitale.
E.K.: Oggi è tempo di recuperare la dimensione sociale del design e abbandonare o dimenticare quell’aspetto glamour che lo rende banale, ma che molto spesso è l’unico a essere pubblicizzato. Qual è, secondo lei, il ruolo politico del design?
Il design sociale è il settore in cui, a mio avviso, tutti i designer dovrebbero investire. Vi è un’espressione utilizzata in ambito giuridico che mi ispira particolarmente: è il concetto di “probono”, ovvero l’idea di devolvere il ricavato del proprio lavoro “per una buona causa”. Vorrei invitare i designer a impiegare anche solo il 20% del proprio tempo a favore di un design socialmente responsabile. Oggi il mondo è investito da un’ondata di caos sociale, economico e politico che non ha precedenti. Non abbiamo mai vissuto una simile condizione di instabilità. Allo stesso tempo vi sono al mondo più designer di quanti ce ne siano mai stati. I designer sono per natura ottimisti, sia da un punto di vista professionale che talvolta anche personale. Io mi definisco un ottimista critico. Dal momento che siamo esperti in problem solving, il design può avere un ruolo fondamentale nel mondo odierno. Ogni designer assume una posizione ben precisa attraverso le scelte che opera, poiché ogni scelta di design ha un impatto sulla società. Ma non sembriamo essere consapevoli di questo potere. L’ultima frontiera del design è la leadership politica. E vorrei che i designer iniziassero a influenzare il pensiero politico e i leader dei loro rispettivi Paesi attraverso le proprie competenze e il proprio modo di pensare. Il design può davvero contribuire a risolvere alcuni problemi, ovviamente non da solo, ma insieme ad altre discipline.
E.K.: Può dirci qualcosa sulla formazione nell’ambito del design in Africa? Crede ci sia un numero sufficiente di scuole di design? Pensa possano essere migliorate? Qual è lo scenario attuale?
La formazione nel campo del design manca di un’unica cosa: il riconoscimento. Il riconoscimento di ciò che significa intraprendere un percorso formativo in questo ambito. Sono stato il primo in famiglia a occuparmi di design e a studiare questa disciplina, ma nessuno capiva realmente di cosa si occupa un designer (“puoi farmi un ritratto?”). Manca, da parte delle istituzioni, il riconoscimento del design come professione a tutti gli effetti. In molti Paesi africani il design è considerato solo in parte una professione, diversamente da quanto accade per chi fa architettura, ingegneria o giurisprudenza. E, in qualità di educatore in materia di design, la mia sfida più grande è quella di riuscire a far comprendere alla società civile che il design può davvero contribuire al benessere delle persone. Da qui la necessità di ripensare il sistema educativo e orientarlo verso l’impegno sociale, divenendo quindi co-designer, insieme ai membri della comunità, e agendo sulla loro conoscenza tacita, profondamente radicata nell’esperienza individuale.
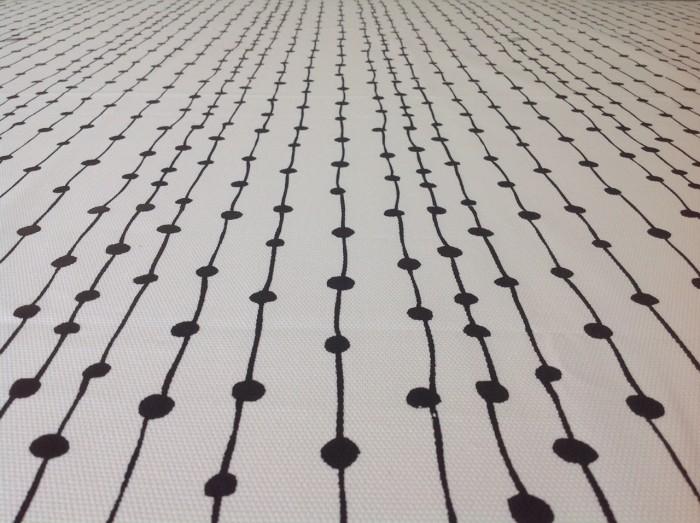 Megan Smith, Billy button black, Textile designer, South Africa.
Megan Smith, Billy button black, Textile designer, South Africa.
E.K.: Il design guarda alla Cina per la produzione e la Cina guarda all’Italia per il design. Cosa possiamo imparare dall’Africa?
Ciò che rende unica l’Africa è che il design creato nel continente africano nasce da necessità concrete. L’Italia può essere considerata all’avanguardia per ciò che riguarda il pensiero creativo, il design e l’innovazione, e vanta molti dei brand più famosi al mondo. Non credo vi siano altri Paesi in grado di produrre un simile livello di eccellenza nel design a livello globale. E poi c’è la Cina, che è diventata letteralmente la fabbrica del mondo, producendo qualunque genere di merce. In Africa la produzione industriale è molto meno sviluppata. In Cina vi è una produzione di massa, in Africa una produzione guidata dal bisogno, per cui la mentalità dell’“hacker” e del “maker” è fortemente radicata nel continente africano. Il secondo elemento che caratterizza in maniera esclusiva il contesto africano è legato alle opportunità tecnologiche offerte dalla stampa 3D e dalla prototipazione rapida. La mia previsione è che la supremazia cinese sulla produzione mondiale andrà a decrescere. Perché con la stampa 3D e la prototipazione rapida ci sarà una nuova rivoluzione, analoga a quella prodotta in campo editoriale dal desktop publishing: prima a pubblicare erano solo le grandi case editrici, ora può farlo chiunque disponga di uno scanner e di una stampante. L’epoca della democratizzazione della produzione è alle porte. Abbiamo case in 3D, cibo in 3D, veicoli in 3D. Se l’Africa continua a potenziare la cultura del “maker” e dell’“hacker”, che già appartiene al nostro DNA, credo riusciremo a diventare autosufficienti intorno al 2050.
E.K.: Questo per ciò che concerne la produzione, che dire del consumo? Crede che l’esportazione del design africano all’estero aumenterà o si tenderà a consolidare il consumo interno al continente?
Credo si procederà in entrambe le direzioni. Per prima cosa, dal punto di vista dei progetti legati all’economia, il XXI secolo sarà il secolo dell’Africa. Ma ciò non avverrà in automatico, dovranno essere il design e la creatività a guidare questo processo. Se pensiamo a Paesi come la Nigeria, il Ghana, il Sudafrica o il Kenya, vediamo che vi è una classe media in espansione che ha avuto accesso ai migliori esempi di design e creatività prodotti a livello globale e che adesso chiede una maggiore qualità da parte delle produzioni locali. Tuttavia, per rimanere competitiva, l’Africa deve comunque esportare. Tornando al discorso della proporzione 80/20, credo che la maggior parte di ciò che produciamo continuerà a essere consumato all’interno del continente africano e il restante 20%, costituito dai prodotti di maggiore qualità, verrà esportato all’estero e troverà un mercato globale.
A.S: Da un lato assistiamo all’espansione della classe media all’interno del continente africano, dall’altro le potenzialità connesse a tale crescita spesso rimangono tali. E dal punto di vista dei brand, le statistiche rivelano che l’80% dei brand percepiti come marchi di qualità non sono africani. Perciò, finché non avremo dei brand africani, l’Africa rimarrà in secondo piano. Cos’è che deve accadere perché ci siano una moltitudine di brand africani riconosciuti non solo all’estero ma anche all’interno delle economie africane, senza che essi vengano però inglobati in un grande e anonimo brand africano?
Per prima cosa, i governi devono essere molto più attivi nel promuovere soluzioni e prodotti locali. Lo vediamo già nella produzione di contenuti televisivi, il 90% dei quali – su pressione di molti Paesi africani – deve essere prodotto a livello locale, catalizzando in tal modo i talenti creativi esistenti sul territorio. L’elemento locale è l’élite locale. Se si inizia a essere più “patriottici” verso le soluzioni prodotte localmente, le evoluzioni future potranno essere davvero significative. Prendiamo ad esempio la musica africana: non c’è bisogno di vendere la musica africana agli africani, perché essi amano già la propria musica; e lo stesso può dirsi per la moda africana. Ma la tendenza è meno netta per altri prodotti, come scarpe, cappelli o automobili. Se riusciamo a portare lo stesso entusiasmo di cui gode la musica o la moda africana nella promozione del brand africano, allora riusciremo a sostenerlo.
AS: Come valuta la situazione dell’espansione dell’élite africana in Nigeria, Sudafrica, etc., e come può, questa élite, avere un ruolo di traino in ambito creativo?
 Siyanda Mazibuko, Pate arts and crafts, Furniture designer. South Africa.
Siyanda Mazibuko, Pate arts and crafts, Furniture designer. South Africa.
Dobbiamo fare un passo indietro e concepire le sfide che l’Africa è chiamata ad affrontare come un potenziale da mettere a frutto. Il primo fattore da considerare è la politica. Gran parte dell’élite africana non ha fiducia nel proprio sistema politico, quindi il denaro guadagnato in ambito locale finisce nei conti all’estero. Perciò, se queste persone iniziano a fidarsi del proprio sistema politico, potremo assistere a dei cambiamenti nel lungo periodo. L’Africa è uno dei pochi luoghi dove è ancora possibile realizzare profitti e, per l’appunto, entrare a far parte rapidamente di una élite. Ma la ricchezza dell’Africa non è distribuita in maniera omogenea, per cui se riuscissimo a mettere insieme le risorse e a far in modo che esse abbiano un impatto critico, potremmo raggiungere degli ottimi risultati.
AS: Cosa fanno le organizzazioni come la vostra per educare e sensibilizzare i consumatori sull’importanza della produzione e dei brand locali?
L’utilità di Design Indaba e di altri festival di design in Africa è quella di mostrare al pubblico ciò che esiste attualmente sul mercato. I visitatori rimangono piacevolmente sorpresi dalla qualità dell’offerta locale. Queste organizzazioni chiamano quindi a raccolta in uno stesso luogo industria e commercio. Solitamente i creativi non brillano per senso degli affari. Quando si tratta di potenziare la produzione delle loro splendide creazioni, non sono in grado di farlo. Perciò la nostra opera di sensibilizzazione può favorire l’incontro tra spirito imprenditoriale e talento creativo, in una modalità sostenibile, e credo che questo possa costituire un fattore di crescita.
EK: Un’ultima domanda: qual è il più grande stereotipo sul continente africano che vorrebbe abbattere?
Il primo, sottolineato anche da Binyavanga Wainaina, è che l’Africa non è un Paese. E questa è per me una grande sfida personale. Quando viaggio in varie parti del mondo, la gente mi dice: “Al tuo rientro, salutami il tal dei tali in Lagos”, senza considerare che io mi trovo a Città del Capo… Un altro stereotipo è legato al fatto che ciò che avviene in una parte dell’Africa in qualche modo diventa un problema africano. Se vi è un attacco terroristico in una località africana, allora la gente dice che l’Africa non è un luogo sicuro. Questa idea stereotipata dell’Africa, vista come un unico grande Paese, è un problema. Una delle mie slide più note si intitola “Le reali dimensioni dell’Africa” e mostra come l’Africa possa contenere al suo interno Cina, Stati Uniti ed Europa… e resta ancora spazio.
Ciò che dichiaro in questa intervista sono riflessioni nate dall’esperienza personale di un individuo che ha trascorso la maggior parte della propria vita nel continente africano, senza per questo pretendere di comprenderne la complessità. Come afferma Kwame Nkrumah, non sono africano perché sono nato in Africa; sono africano perché è l’Africa a essere nata in me. Ed essa può nascere in qualunque individuo, a prescindere dal fatto che provenga o meno da questo continente. L’Africa è un modo di vivere. E può tornare a contagiare il mondo con la sua umanità, la sua gioia e la sua ricchezza.
Traduzione di Laura Giacalone.
Con il supporto di 







