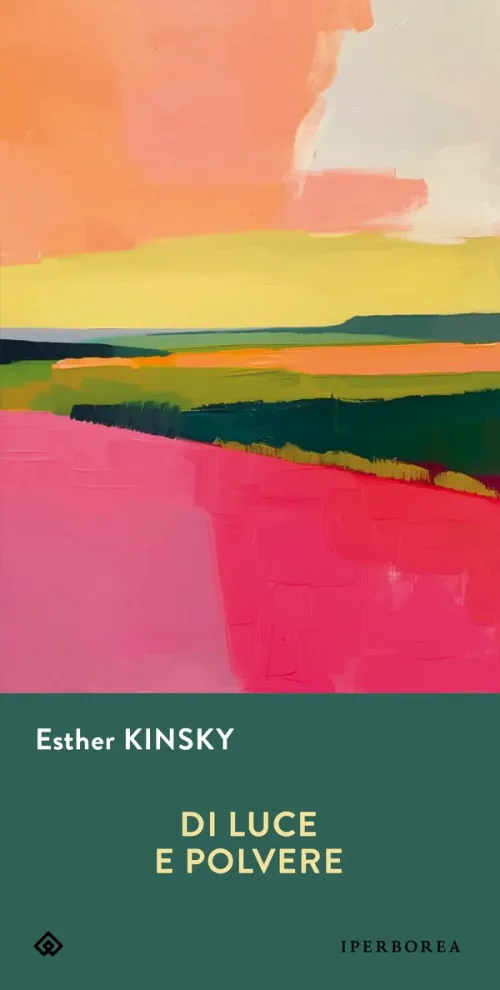Esther Kinsky: vedere più lontano
Si riemerge dalla lettura del romanzo di Esther Kinsky, Di luce e polvere (Iperborea, 2025), come se nel frattempo fossimo stati ammessi a vedere qualcosa di così intimo alle nostre vite da risultare, proprio per questo, spesso invisibile. Raramente come in queste pagine la scrittura è capace di evocare il nostro rapporto con le immagini. Un rapporto tanto confidenziale da risultare quasi carnale.
Del resto, le immagini sono la materia di cui è fatta la maggior parte dei nostri ricordi. Così, quelle che abbiamo visto al cinema finiscono per mescolarsi indelebilmente con quelle che appartengono alla nostra memoria. Ha luogo una sorta di osmosi permanente, in cui memoria ed esperienza cinematografica si contaminano a vicenda, al punto da non sapere più dove inizi l’una e dove finisca l’altra. Di alcune cose non si saprà più se le abbiamo viste in un film o se le abbiamo vissute realmente – come direbbe la nostra lingua comune – uno di questi giorni o una di queste notti.
La scrittura del romanzo ci porta vicini a quel punto in cui si consuma il confine presunto tra le immagini vissute e le immagini viste, perché tutte le immagini diventano ricordi. Diventano la memoria, vera e inventata al tempo stesso, che dà forma all’esistenza. Non solo: i ricordi di ciascuno si mescolano con i ricordi di un altro e, in generale, con immagini che vengono da altrove. Questo altrove è stato, e per certi versi è ancora, il cinema.
Di luce e polvere ci conduce così su quel crinale di densità in cui le immagini si fanno prossime, tutte apparentate da un’affinità elettiva segreta, e finiscono per ritrovarsi intrecciate le une alle altre, al punto da risultare inseparabili. Così i ricordi di un amore prevedono anche i film che si sono visti insieme, e le immagini di una città si colorano dei cinema che abbiamo frequentato…
Le vicende del libro ci portano in un piccolo centro abitato dell’Ungheria. È lì che la protagonista – una straniera – s’imbatte in un edificio abbandonato, con una scritta scolorita sulla facciata: Mozi. Cinema. Da quel momento, seguiamo il lento formarsi – e poi il compiersi – dell’idea di acquistarlo, per restituirlo alla città come luogo di cultura e di vita condivisa. Un gesto quasi anacronistico, che riattiva memorie, relazioni, desideri.
Nel farlo, la sua storia incontra quella dell’uomo che aprì il cinema nel dopoguerra e dei suoi compagni di strada: come Ljuba, la donna che si innamorò di lui quando un fulmine interruppe una proiezione o Józsi, l’ex proiezionista che ora ripara biciclette. Di questi personaggi sapremo solo dettagli all’apparenza marginali – frammenti, deviazioni, episodi minimi – ma proprio per questo capaci di evocare una presenza. Di farceli vedere, come appunto accade in un film. E le storie di queste persone sono a loro volta intrecciate con i film che passavano dallo schermo del Mozi.
La sala cinematografica è uno dei protagonisti del libro e proprio questo costringe chi legge a confrontarsi con una serie di preziosi anacronismi. Che si tenti di far rinascere il Mozi in un presente dominato da visioni domestiche, solitarie, digitali, segnala come la visione cinematografica come esperienza collettiva appartenga ormai al passato, superata dall’affermarsi di nuove abitudini. Non a caso, dopo la sua nuova chiusura, il Mozi sarà destinato a diventare una sala da bowling – ennesima conferma, se mai ce ne fosse bisogno – dell’assurdità apparente di voler riaprire un cinema abbandonato da anni.

Così, quando la protagonista tornerà tra le rovine di quello che un tempo era stato “il suo” cinema, si troverà davanti una scena emblematica: tutte le poltroncine ammassate contro la parete, rivolte verso il muro anziché verso lo schermo. Nel destino di questi arredi si condensa una potente allegoria del passaggio tra le epoche: “Così com’erano, le poltrone avevano quindi distolto lo sguardo dalla lontananza, rimanevano numerate ma ridotte alla cecità”.
C’è anche un secondo livello di anacronismo che attraversa la scrittura di Esther Kinsky: una sorta di saggezza delle cose e delle loro relazioni segrete. Ogni vita è se stessa, certo, ma esiste soltanto nel dialogo – consapevole o meno – che intrattiene con altre vite, con altre storie. Per remote che siano – come quella di Deutsch László, il primo proprietario del cinema – sono comunque vicende di contemporanei. E se il Mozi ritrova, anche solo per un istante, il proprio respiro in un presente saturo di visioni televisive e private, è perché resta un luogo capace di tessere legami tra presente e passato. Un passato che non è mai del tutto alle spalle, ma continua a vivere nei racconti, nei gesti, nei resti silenziosi degli uomini e delle donne di oggi.
È qui che affiora il senso più profondo dell’anacronismo: un’intempestività delle immagini, che ritornano quando meno ce lo si aspetta. Tutto il libro è percorso da queste apparizioni: panorami, volti che sono anche paesaggi, nomi che riemergono dal fondo della storia come da un fiume carsico. In questo senso, la poetica del libro risponde – più di ogni altra e con una lucidità rara – all’intuizione benjaminiana secondo cui esistono cose che restano indimenticabili, anche se nessuno le ricorda più.
Che cos’è allora il cinema? Diremo che, nelle pagine del romanzo, esso diventa il crocevia delle esistenze. Più precisamente: il crocevia delle storie di quei personaggi che, come noi, sembrano privi di un destino, abbandonati a un tempo senza eventi e senza direzione. Quella sala, nel mezzo di una cittadina che pare distante da tutto – perfino da se stessa – diventa il luogo in cui si intrecciano la facoltà del ricordare e quella dell’immaginare. Due movimenti della mente e del cuore che il cinema, più di ogni altra arte, tiene insieme in un’unica esperienza visiva. Dove inizia l’una e dove finisce l’altra, non è mai del tutto chiaro.
Come il cannocchiale di Galileo sconvolse l’astronomia, la cultura e l’antropologia del tardo Cinquecento, così il cinema ha trasformato la nostra capacità di vedere: il mondo e l’oltre-mondo, la realtà e le galassie delle cose possibili. Cose che non si sono realizzate, ma che trovano nel cinema – e nell’immaginazione che il cinema nutre – un luogo dove poter essere viste.
Lo dichiara con forza il titolo originale del libro, Weiter sehen: vedere più avanti, vedere più lontano – ma anche continuare a vedere, non smettere, non cedere. È, diremo, un verbo della resistenza: uno sguardo che insiste, che non dispera di vedere e di vedere ancora.
La parola ungherese mozi viene da mozgókép: immagini in movimento. E proprio di questo è fatto il cinema di immagini mosse, instabili, mobili, i cui bordi sfumano, si perdono. Basta un movimento di macchina per cambiare punto di vista, spostarsi a destra, a sinistra, in alto o in basso. Sono immagini che fluttuano, e ci conducono verso un ignoto che ci attende da sempre. Anche quando conosciamo il film a memoria, anche quando ne ricordiamo ogni svolta, il gesto della visione continua a custodire una meraviglia che resiste all’usura.
La sala cinematografica è stata il luogo in cui intere generazioni hanno imparato a guardare. Lì hanno scoperto che dentro lo sguardo vive un desiderio e che quello stesso desiderio poteva trasformarsi in un’avventura. Lo facevano immersi in nuvole di fumo, in quegli anni che oggi ci sembrano mitici, quando nei cinema si poteva ancora fumare, e le colonne di fumo salivano lente, attraversando il fascio luminoso della proiezione. E anche allora, forse, sentivano la fine del film come un momento di malinconia. Non per la tristezza del finale, ma “perché non si poteva più continuare a vedere, perché la vista su un altrove attraverso quello schermo-finestra si chiudeva”.
In fondo, il cinema è stato – e ancora è – tutto questo: un dispositivo che ci ha insegnato a smontare la realtà per ricomporla in immagini. Per questo nelle immagini si cela sempre una porzione di distanza, una pluralità di mondi possibili, un tratto d’infinito. È proprio in grazia di quella distanza che abbiamo imparato a vedere sentieri che non sapevamo di voler percorrere, dato che non ne conoscevano nemmeno l’esistenza.
Significativa, in questo senso, è la parola serba per “cinema” che l’autrice ricorda: Bioskop, “un luogo in cui si guarda la vita”. Ma forse è anche il luogo in cui la vita guarda se stessa. E come potrebbe farlo, se non osservando vite che non sono le sue e che sono vite degli altri? Non è forse anche questo un modo per vedere più lontano?
È questo che accadeva – e che ancora accade – quando la sala cinematografica diventa il luogo in cui, tra lo schermo e gli sguardi, si tendono fili invisibili e magici, nati dall’incontro tra la luce delle immagini e l’occhio degli spettatori.
Come se, seguendo quel flusso intermittente – quel tenue bagliore che attraversa il buio della sala per raggiungere gli occhi di chi guarda – si potesse attraversare il tempo. Guardare altrove, dall’altra parte del presente, verso un passato mai vissuto, verso volti e storie che non abbiamo mai conosciuto. Verso una preistoria nostra, ma dimenticata.
E questa esperienza si accompagna sempre a una certa vertigine visiva, prodotta dalla forza delle immagini: “una sequenza selvaggia di immagini, volti, gesti, brevi scene che si schiudevano su qualcosa di sconvolgente e del tutto estraneo per quel posto, un’estraneità liberatoria dalla quale poi ci si sarebbe risvegliati nel vuoto malinconico e nella lentezza di una serata incantevole”.

Per quanto solitaria, questa esperienza non è mai stata individuale. È sempre stata legata alla presenza degli altri spettatori in sala, alla vicinanza – silenziosa ma tangibile – di corpi che guardano nella stessa direzione. In quella condizione unica, e oggi sempre più rara, si tiene insieme la solitudine dello sguardo e la comunanza della visione. Un’intimità condivisa, fragile e potente, che nasce nel buio, davanti allo stesso schermo.
Là, nella sala, si viveva l’invenzione di uno spazio a sé, distinto dal resto del mondo, in cui le abituali coordinate spazio-temporali – quelle su cui si fonda la nostra esperienza – risultavano sospese. Almeno temporaneamente, sino a che il film non fosse finito e la luce in sala non si fosse riaccesa, lasciando uscire gli spettatori in strada. Si può vedere più lontano, si può guardare verso una lontananza, solo quando si è capaci di lasciarsi alle spalle tutto il resto. Si orienta il proprio corpo in funzione della visione, in direzione dello schermo, che come un’immensa finestra magica lo rende possibile. È quello spazio di cui Roland Barthes avrebbe detto che somiglia tanto al lavoro del baco da seta, che lavora ed è tutto preso dal suo desiderio proprio perché è rinchiuso dentro il suo bozzolo.
Un tempo, quella delle immagini era una festa: almeno nei paesi dell’Est, si poteva ancora festeggiare le immagini. Oggi, il nuovo ordine mondiale offre invece alla gente solo il senso della propria sconfitta storica. Il regno del benessere promesso si è tramutato nella visione frustrante di beni inaccessibili, raggiungibili solo in minima parte. “Manca sempre qualcosa”, dice la voce narrante, e la frustrazione è diventata lo stato normale. Una condizione che accomuna tutti, ma che è avvertita con più dolore proprio da coloro che avevano sperato che il nuovo ordine colmasse i vuoti, sanasse le mancanze, facesse giustizia delle fratture, magari traducendo quell’utopia in colate di cemento e simboli del progresso, veri o presunti.
E invece, la perdita del cinema è avvenuta di pari passo con la perdita del senso delle cose. Hanno perduto anche la fiducia nei propri sensi. Hanno perduto, nel linguaggio del libro, il senso della lontananza, che è di solito ciò che tiene uniti alle cose più preziose.
“Cosa andiamo a fare al cinema?, dicevo quando mio marito mi proponeva di uscire”. Chi parla è la rappresentante di un’epoca in cui è venuto meno l’incanto di un tempo in cui andare al cinema implicava l’accettazione di un certo non sapere, la sospensione dell’idea che tutto debba essere sotto controllo. Che film vuoi vedere stasera?, è invece la domanda che precede oggi ogni visione casalinga, ma spesso non sappiamo davvero cosa vogliamo vedere. Passiamo troppo del nostro tempo libero a cercare un film che corrisponda a un desiderio indistinto, all’umore di una serata. Eppure, la cosa essenziale non sta nemmeno lì, nel sapere o non sapere cosa si vuole: sta nel fatto che si andava in sala anche senza sapere bene che cosa si stesse cercando.
La sala cinematografica è uno spazio altro, in cui vigono regole diverse. Ma proprio per questo, anche quando capitava di vedere un brutto film, le aspettative non venivano deluse. Perché vedere un film significa pur sempre: “vedere più lontano di prima, esplorare un orizzonte che senza lo schermo non esisterebbe”.
E quando si esce dal cinema, il film continua. Le conversazioni si impregnano di ciò che si è visto, ma anche delle tracce che l’esperienza ha lasciato sul corpo. A volte, più del film, restava il ricordo del ritorno: “ricordo i tragitti per tornare a casa, finito il film, a piedi, un’ora in più, se dopo il viaggio di andata e l’ingresso al cinema i soldi non bastavano per un biglietto dell’autobus”.
Il fulminante incipit del libro – che si dovrebbe far leggere a tutti gli studenti – ci mostra che il “vedere più lontano” non ha a che fare con i contenuti del film, con il che cosa, ma con i modi del vedere: con “l’angolazione dello sguardo e la distanza delle cose”. Con i rapporti tra prossimità e lontananza che intratteniamo con la realtà. L’immagine, in questo senso, non ci dà solo accesso all’esistente, ma anche al possibile. Il cinema è forse, più di ogni altro, il dispositivo che ha posto al centro la questione del come vedere.
Ha creato uno spazio fisico in cui, nel buio, si apre una visione nuova. Il cinema non è solo l’immagine proiettata sullo schermo, ma lo spazio stesso in cui questa immagine può accadere. Il grande buio in cui l’impresa delle immagini trova modo di dispiegarsi. È la sensazione avvolgente del luogo, il senso di epifania che solo lì – e solo in quel buio – le immagini possiedono.
Weiter sehen è un libro che, con la lucidità di un saggio e la grazia di un romanzo, andrebbe letto da chiunque si occupi di cinema, immagine, visione. Perché mette al centro la domanda che conta: come si guarda?
È proprio il trionfo del cosa, la riduzione del film a narrazione, a spiegare – secondo l’autrice – la morte del cinema: “l’opinione malsana e dilagante che bastasse veder sfarfallare l’immagine digitalizzata su uno schermo qualunque” è il segno di una deriva. Una deriva che prende la scorciatoia dell’apparenza e rinuncia all’esperienza. “L’illusoria comodità della continua disponibilità di dati traducibili in una serie di immagini” non è ancora visione. Non basta a costruire uno sguardo. E non basta certo a farci vedere più lontano.
Weiter sehen ci invita a pensare anche una nuova metafisica della sala cinematografica, o meglio ancora: un nuovo materialismo della percezione. Perché le immagini non sono solo visioni: sono materia che ci attraversa, che si deposita: “Lo sguardo dello spettatore e il raggio di luce del proiettore si incrociavano e si mescolavano, componendo le particelle che si depositavano in tutti i pori di coloro che guardavano e poi filtravano tutto quello che trovava accesso dal mondo esterno”.
Le immagini, dunque, sono fatte di particelle. La loro materia è ciò che resta nel fondo dei nostri sguardi e dei nostri corpi, come un sedimento invisibile. È lì che vanno a finire i frammenti di film, le scene dimenticate ma mai davvero perdute, i volti che ci avevano toccato senza che lo sapessimo.
Questo materialismo poetico si ritrova anche in un altro notevole passaggio del libro: quello in cui si racconta di un brevetto per una vernice prodotta con vecchie pellicole cinematografiche di celluloide. Come se i film potessero tornare sotto forma di colore, e ogni pennellata stendesse sul muro un’eco fragile di immagini, un ricordo sottile che si espande sull’intonaco.
Il cinema è stato e continua a essere – e così la vita – un luogo pieno di incontri e impronte. Uno spazio abitato da ricordi improvvisi, da profumi d’infanzia, da atmosfere che sfuggono alla presa delle parole, ma che proprio per questo si imprimono più a fondo. Nel buio della sala – come nel fondo della memoria – qualcosa resta.
Qualcosa che ci tocca, ci trasforma, ci accompagna. E forse è in questo deposito sensibile che continua ad agire il cinema. Come promessa di uno sguardo che sa vedere più lontano. O come un’immagine che, nel momento stesso in cui svanisce, continua a risplendere dentro di noi.