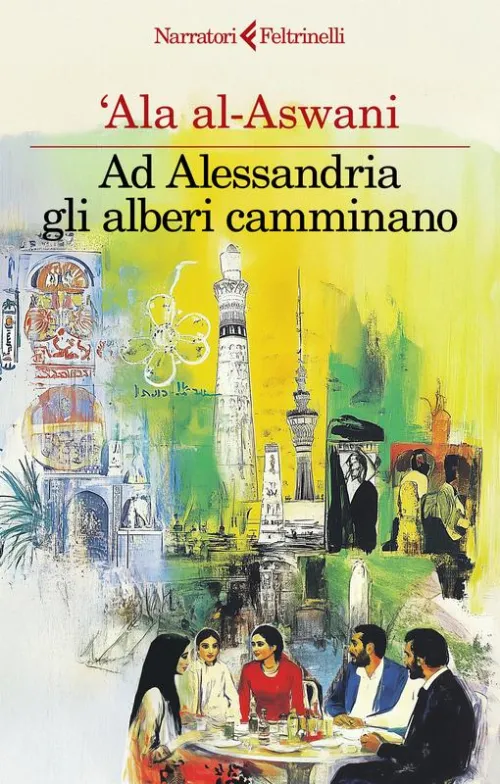Al-Aswani: l’Egitto e la sindrome della dittatura
Era opera del demonio, di sicuro, quella oceanica fiducia concessa a Gamal Abdal-Nasser. Lo credeva fermamente lo scrittore egiziano Tawfiq-al-Akim. Mentre scriveva il suo libro Il ritorno della coscienza, nel 1974, doveva trovare una giustificazione forte, qualcosa di ultraterreno, per accettare l’idea che il suo popolo avesse supplicato a gran voce, con le lacrime agli occhi, il dittatore di rimanere al suo posto. Nonostante la clamorosa sconfitta subita nella guerra contro Israele, che aveva portato l’esercito ebraico a dilagare sui campi di battaglia, occupando in rapida successione il Sinai, la Cisgiordania, Gaza, le Alture del Golan e Gerusalemme Est.
Solo un sortilegio negromantico, un intervento diabolico poteva spiegare l’irragionevole difesa da parte del popolo egiziano di un uomo che aveva trascinato il suo Paese verso una sconfitta umiliante. E, allora, Tawfiq-al-Akim aveva tirato in ballo Satana in persona, la magia nera, l’abbaglio di un miraggio che si era trasformato in un incubo. Nel suo libro, infatti, scriveva: “Nasser ci ha stregati a tal punto che non abbiamo nemmeno capito di essere stati posseduti dal demonio. Forse era la sua magia speciale, come dicono, o forse era il sogno stesso, così gravido di speranze e promesse. O forse era quel meraviglioso miraggio dei successi rivoluzionari che aveva tramato per noi e ci aveva trasformati in tanti strumenti di quell’estesa propaganda, con i suoi pifferi, tamburi, inni, canzoni e film, che ci permettevano di ritenerci un grande Stato industrializzato che stava guidando il mondo in via di sviluppo nelle riforme agricole, la luce guida del Medio Oriente”.
In Egitto, negli stessi anni, c’era chi non credeva affatto al canto delle sirene di Nasser. E tantomeno ai sortilegi demoniaci con cui il dittatore era riuscito ad avere dalla propria parte una stragrande maggioranza della popolazione. C’erano persone che non si lasciavano ipnotizzare dalla propaganda di regime, come l’avvocato e scrittore socialista Abbas al-Aswani, uno degli accaniti oppositori del dittatore. Oltre che padre di quello che viene considerata una delle voci più interessanti della letteratura egiziana: ‘Ala al-Aswani.
Figlio di una solida cultura libertaria, al-Aswani è convinto, da sempre, che “la risposta è la democrazia” per qualunque tipo di regime vada al potere in Egitto. Lo ha scritto in decine di articoli dedicati alla rivoluzione che regalò grandi illusioni nel 2011, trasformando piazza Tahrir nel simboli mondiale della possibile alternativa all’oscurantismo islamico dei Fratelli Musulmani. Ma anche al pugno di ferro militare del generale Abdel Fattah al-Sisi. E se non bastasse, lo scrittore ha ribadito la sua inestinguibile voglia di trasparenza politica partecipando alla fondazione del movimento per la democrazia Kifaya.
In più, al-Aswani ha voluto raccontare quanto ingombranti siano stati i poteri forti nella storia dell’Egitto nei suoi libri. A partire da quel grande successo internazionale che è Palazzo Yacoubian (tradotto da Bianca Longhi nel 2006 per Feltrinelli), dove la comédie humaine dell’Egitto moderno, fatta di giovani pieni di speranze, ricchi affaristi, intellettuali gay, poveracci che vivono sui tetti dei palazzi, deve confrontarsi con una radicata corruzione politica, l’ipocrisia religiosa e l’arroganza dei potenti.
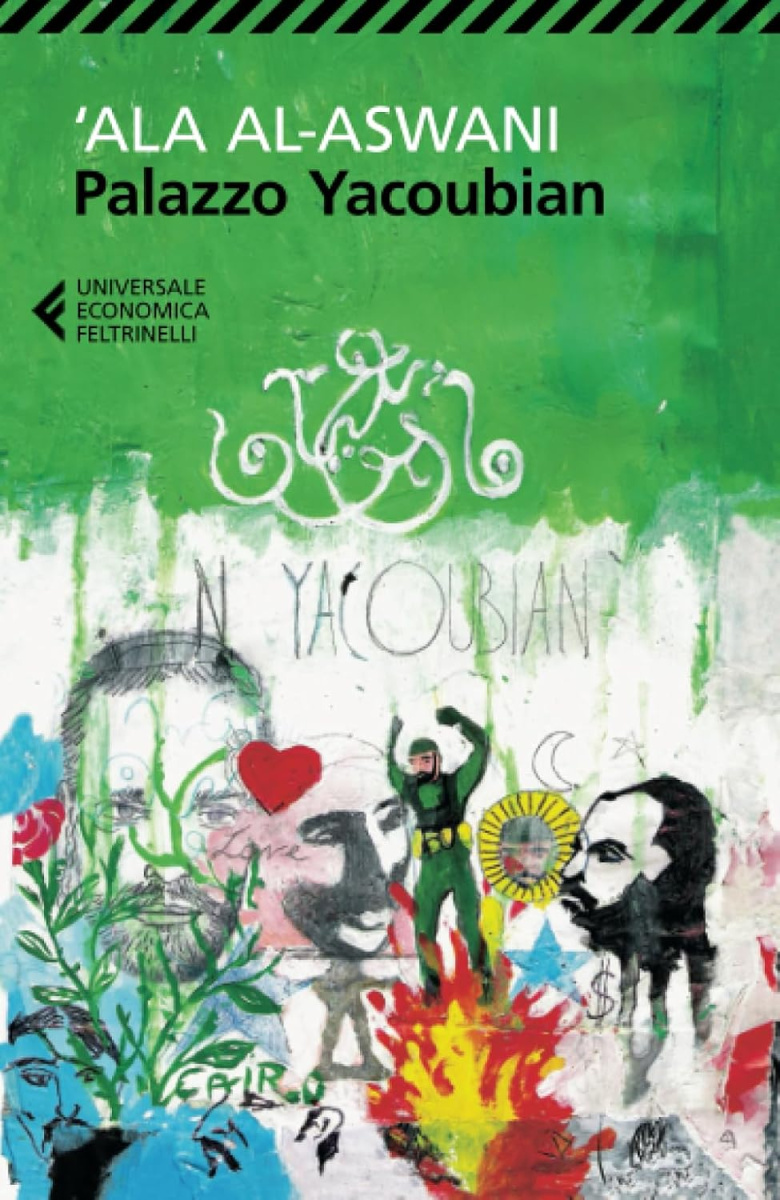
Il romanzo Sono corso verso il Nilo (tradotto da Elisabetta Bartuli e Cristina Dozio nel 2018 per Feltrinelli) dimostra quanto fragili fossero le illusioni legate alle ribellioni di massa del 2011. Visto che la rivoluzione di piazza Tahrir si è rivelata capace di partorire una repubblica solo per finta. Come nel mito del titano Crono, ribattezzato Saturno dagli antichi romani e immortalato da Francisco Goya nel perturbante dipinto “Saturno che divora i suoi figli”, in cui il Potere si mostra pronto a scannare la propria prole per non essere esautorato.
La sindrome della dittatura, del Potere che deraglia dalla propria retta via per trasformarsi in un implacabile meccanismo atto a sorvegliare e punire, è sempre stata al centro dell’opera del dentista ‘Ala al-Aswani, che da un po’ di tempo ha deciso di lasciare la professione medica per dedicarsi solo alla scrittura. Cinque anni fa, nel 2020, Feltrinelli ha pubblicato, nella traduzione di Giancarlo Carlotti, La dittatura. Il racconto di una sindrome. Testo lucidissimo in cui lo scrittore, nato al Cairo nel 1957, dimostra come la tentazione liberticida del Potere non sia un retaggio del passato. Ma abbia esteso le proprie radici di pianta altamente tossica, di malattia endemica, fino al nostro tempo. Moltiplicando dall’Africa all’Asia, dall’Europa all’America Latina l’asfissiante controllo esercitato da decine di piccoli Grandi Fratelli pronti a imporre il terrore. Anche grazie a una pressante manipolazione delle informazioni che viaggiano sull’autostrada di internet e dei social media.
Se nel 2014 al-Aswani era ritornato con la memoria agli ultimi tempi della monarchia di Sua Maestà re Faruk Primo, e della sua corte dei miracoli, nel romanzo Cairo Automobile Club (tradotto da Elisabetta Bartuli per Feltrinelli), adesso il medico-scrittore fa un passo avanti nel divenire della Storia. E ambienta il suo nuovo libro Ad Alessandria gli alberi camminano (tradotto da Elisabetta Bartuli e Cristina Dozio per Feltrinelli, pagg. 409, euro 22) nei primi anni Sessanta. Quando la rivoluzione di Nasser riusciva ancora a illudere gli egiziani che il sogno socialista potesse allontanare la pressione colonialista, che voleva chiudere l’Egitto in un insignificante angolo di mondo.
Nei romanzi di al-Aswani, sono sempre i personaggi a scandire il ritmo della storia. Perché il medico-scrittore è convinto che “un intellettuale non deve mai smarrire il rapporto con il popolo, con quello che sente la gente. Altrimenti finirà per perdere di valore anche agli occhi dei lettori”. Così, ogni volta, l’impasto narrativo prende forza puntando gli occhi su personaggi che abitano la vita quotidiana. Che lottano e soffrono per difendere il loro posto minimo nella realtà. Figure di carta che ricordano gli immortali protagonisti dei grandi romanzi francesi dell’800 firmati da Honoré de Balzac e Victor Hugo, Gustave Flaubert e Émile Zola.
Ma questa volta, la commedia umana di al-Aswani va in scena su un palcoscenico d’eccezione. Sì, perché, fin dal titolo lo scrittore dichiara di voler raccontare la sua storia ambientandola in quello che è stato a lungo uno dei simboli di tolleranza, curiosità, fervore intellettuale e umanità nell’Egitto che si preparava a vivere la roboante ascesa, e il sanguinoso tramonto, di Nasser: Alessandria. La città dalle tante culture, crocevia di civiltà e di credo religiosi, incontro di stili architettonici e tradizioni diversi.
Prendendo a prestito i versi del poeta greco Kostantinos Kavafis, nato e morto proprio ad Alessandria d’Egitto, al-Aswani dichiara subito il suo grande amore per quel luogo inimitabile. Lo stesso che farà da palcoscenico alle vite dei suoi personaggi: “Ti verrà dietro la città. Per le stesse strade girerai. Negli stessi quartieri invecchierai e in queste stesse case imbiancherai. Finirai sempre in questa città. Verso altri luoghi – non sperare – non c’è nave per te, non c’è altra via”.
I versi di Kavafis sono lì a tracciare la rotta, apparentemente immutabile, di un gruppo di amici che si riuniscono in uno dei migliori ristoranti di Alessandria: Artinos. Un posto esclusivo, dove “era impossibile trovare un tavolo se non avevi prenotato”. Ma dove quello che si è autoproclamato, non senza un pizzico di ironia, un amichevole Caucus, trascorre una buona parte del proprio tempo libero, intrecciando racconti e chiacchiere, partecipando alle storie d’amore e d’amicizia degli altri, apprezzando l’atmosfera raffinata e rilassante creata dalla splendida figlia del proprietario, Leda Artinos, e dall’impeccabile maître d’origine italiana Carlo Sabatini. Un uomo che ama le donne in maniera incondizionata.
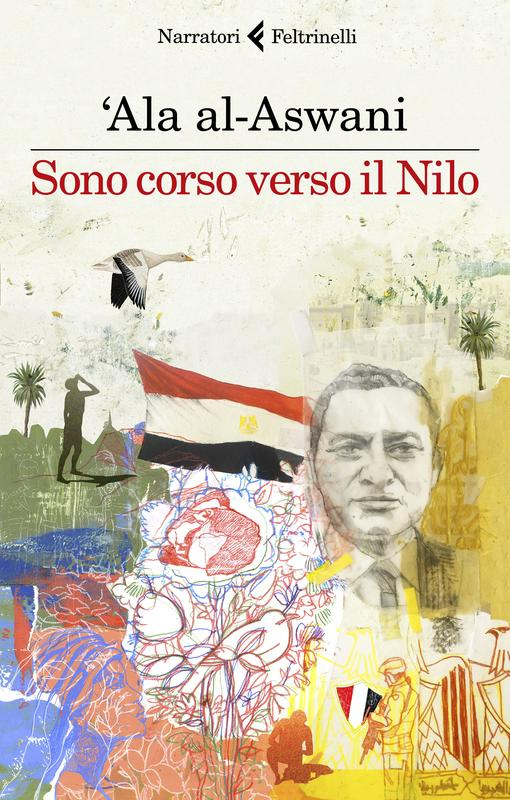
Nel gruppo che forma il Caucus ci sono personaggi che simboleggiano la libertà di Alessandria e l’incrociarsi di francesi e greci, italiani e egiziani. Tutti profondamente legati, innamorati della città. Oltre a Leda e Carlo ci sono la francese Chantal Lemaître, proprietaria della Libreria Balzac; l’industriale del cioccolato Tony Kazzan; il pittore Anas al-Sairafi; l’avvocato libertario ‘Abbas al-Qosi e sua moglie Noha, figlia del pascià destituito al-Shawarbi. E poi, danzatrici del ventre, uomini svelti con il coltello ma dotati di un forte codice d’onore, ambigui colonnelli del Dipartimento di indirizzo morale, ferventi socialisti trasformati in luride spie al servizio del regime.
Un coro di voci, di vite, di storie che procedono rettilinee, ma che poi si intersecano, mescolando amori e ossessioni, grandi progetti e miseri fallimenti, ferite profonde e intemperanze, andando a formare il tessuto narrativo del romanzo. Un termitaio di storie tenuto assieme da una grande amicizia, che non impallidisce nemmeno quando la rivoluzione di Nasser diventa una claustrofobica macchina del controllo e della repressione.
Al-Aswani è bravissimo a costruire un romanzo, forse il suo più bello insieme a Palazzo Yacoubian, dove la forza pirotecnica del racconto alberga in sé l’ombra oscura della persecuzione politica. Dove, sulla ribalta delle pagine, la leggerezza dei sogni e dei sentimenti si deve specchiare assai in fretta nel riflesso torbido e inquietante delle trame di potere, della corruzione, dell’inganno travestito da progetto politico.
Mentre Alessandria smarrisce i suoi connotati di città ospitale, tollerante, sempre pronta a guardare verso il futuro, riaffiora dalla memoria la leggenda della donna con lo sguardo più acuto di tutto l’Egitto. Grazie a Zarqa’ al-Yamama, per lunghi anni, la sua tribù era sempre riuscita a sconfiggere i nemici. Perché lei sapeva mettere a fuoco le loro mosse quando erano ancora lontani dal villaggio. Ma il giorno in cui aveva iniziato a ripetere “vedo degli alberi che camminano”, nessuno si era più fidato delle sue preveggenze. Anzi, l’avevano sbeffeggiata pensando che fosse ormai vecchia e rincretinita. Poche ore dopo i nemici, celati sotto grandi rami d’albero, avevano attaccato il villaggio, distruggendolo.
Ai personaggi di al-Aswani è ben chiaro che l’immaginazione aiuta a leggere il futuro con maggiore lucidità. Però è difficile dare ascolto agli artisti, ai poeti e agli scrittori che da sempre vestono i panni del veggente. Così, anche le figure che animano il romanzo finiscono per illudersi e convincersi che mai Nasser troverà il coraggio di barattare il sogno della rivoluzione con l’incubo della dittatura. Mentre Alessandria perderà, inesorabilmente, la sua innocenza di città senza pregiudizi, per diventare un posto asfittico, dove non c’è spazio per i sogni.
In Ad Alessandria gli alberi camminano al-Aswani riesce a dosare con grande bravura la voglia di costruire intrecci narrativi frizzanti e coinvolgenti insieme alla necessità di non smettere mai di tenere gli occhi puntati sulla realtà. Così, nel guazzabuglio di destini umani che riempiono le pagine del romanzo, tra mille derive drammatiche, personalissime e spesso buffe, la Storia lascia intravvedere il suo lato più tenebroso, che si materializza quando la dittatura stabilisce una relazione malata tra chi governa e il popolo.
Ancora una volta, il passato sembra non insegnare niente. Perché, come dice l’industriale del cioccolato Tony Karrar prima di andarsene dall’Egitto, “un dittatore ha bisogno di alimentare la teoria del complotto per presentarsi come difensore del popolo”. E le sue menzogne finiscono per fare presa, sempre. Basta alzare gli occhi dalle pagine del romanzo e guardarsi in giro.