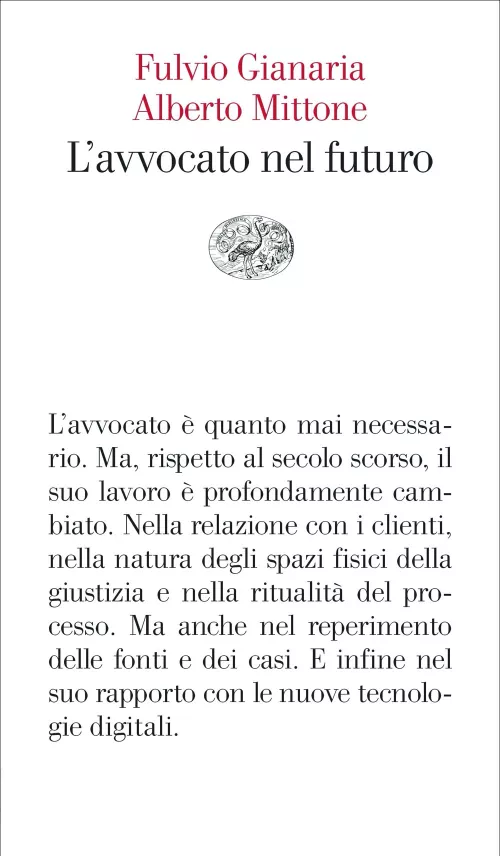Chiamati in causa
Con la levità assertoria che può permettersi solo lo storico delle forme antiche, Yan Thomas descrive il diritto come una programmatica elusione del vero. Non c’è dolo o intento criminoso, né sperperi di poteri o sperequazioni di sorta. Secondo Thomas, il diritto è una tecnica discorsiva – acme della forza ordinante del linguaggio – che non aderisce al reale ma ne riordina gli elementi proiettandovi delle categorie autoreferenziali, un tempo elaborate dalla dottrina, oggi perlopiù dai Parlamenti, alle volte dalle Corti. Insomma, una tecnica che presta un linguaggio – specialistico, lambiccato, il più delle volte legnoso e inelegante – a chi vi si rivolge per risolvere problemi e superare conflitti.
E – quel che più sorprende chi nella vita ordinaria è abituato a distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è – il diritto sovverte l’esigenza di ogni scienza e coscienza ad accertare il vero ponendo fine all’indagine indefinita dei fatti con un perentorio pro veritate habebitur. La forza del diritto sta proprio nel prendere distanza dalla natura, nel disinteressarsi delle sue dinamiche profonde, nel “prendersi gioco senza limiti di sorta […] dei vincoli della realtà esteriore” (Yan Thomas, Fictio legis, Quodlibet, 2016, p. 24). Insomma: il diritto “respinge il dubbio, quando, malgrado il dubbio, deve emettere un giudizio: l’esigenza della decisione sospende, dopo esservisi provvisoriamente assoggettata, l’esigenza di verità” (pp. 18-19).
Non è certo l’ordine della moralità che si può invocare per giudicare una disposizione tanto fraudolenta: se si interessasse al vero, al fatto per come andato, il diritto sarebbe una disciplina come tante altre, mentre è l’unico sapere umano che sappia dotare del proprio linguaggio chi si trova a dover superare dispute che, prive di quel linguaggio, si risolverebbero nella forza. Una rinuncia al vero che ha a un tempo dell’oblativo e dell’eroico, come per tutti i miti fondativi che un po’ tendono al melodrammatico e non hanno confidenza con l’ironia. Ma questo spazio linguistico serrato, rinserrato in categorie artate, spesso illeggibili persino a chi si dota di più di un titolo di laurea, presuppone la distinzione tra esperti e profani come fosse una premessa inquestionata a sostegno di un intero cosmo. Per fare ingresso nel campo giuridico, per servirsi delle sue tecniche e raggiungere gli effetti sperati, i profani devono ricorrere agli esperti. Questo ceto più che sacerdotale è, per così dire, il telamone sulle cui spalle poggia il tempio dove si celebrano i riti della pace sociale.
L’avvocato nel futuro (Einaudi, 2022), di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone, libro di grande eleganza e capacità di suggestione, illustra con efficacia questa duplice esigenza di creazione di un microcosmo linguistico, nutrito da rituali precettivi, e di mediazione quasi iniziatica da parte di figure interamente votate all’uso delle tecniche giuridiche. L’affresco iniziale è preciso, gustoso e deliberatamente orientato a restituire il senso di sacralità di una professione. Tuttavia, là dove si è soliti celebrare la terzietà sapienziale e immacolata del giudice oppure la concettualità creativa dei giuristi, nel libro l’accento cade sulla figura, decisiva per l’ingresso dei profani nel campo giuridico, di chi è “chiamato presso” (advocatus) per fare da guida, consulente, sostegno e perorante.
Con rapidi cenni sul modo in cui il processo in antichità, in particolare a Roma, si specializza, diviene sempre meno affare di popolo, sviluppa protocolli rigidissimi e si dota di figure codificate, Gianaria e Mittone indicano come proprio l’emergere della figura dell’avvocato segnali sempre un passaggio di fase degli ordinamenti giuridici: l’avvocato si rende necessario quando l’ordinamento raggiunge una specializzazione in cui non è più ammissibile alcuna commistione tra saperi giuridici e non-giuridici – “la scienza è solo un’ospite nel processo” (p. 55) – e tocca così una “complessità che esclude i profani” (p. 4). Il salto è tutt’altro che secondario: al profano non è più consentito difendersi da sé, né l’eventuale professione di hybris gioverebbe al buon esito della causa che lo riguarda.
Secondo una dinamica che sembra riproporsi in ogni frangente della storia (ma su questo gli antropologi non trovano un consenso), la figura dell’esperto tanto più si impone quanto più il diritto si fa la sola disciplina che rende utilizzabili le leggi (p. 6). Il mestiere dell’avvocato, in questo assetto, è quello di precettore: educare, al bisogno; introdurre finché ce n’è necessità; predisporre gli ammennicoli che fanno al caso, facendo uso di strumenti affilati come “la ricerca dei contenuti da illustrare oralmente (inventio), i criteri e i tempi con i quali proporli (dispositio), la scelta delle parole e dei toni (elocutio), la capacità di esporre a braccio (memoria), la gestualità (actio) [che] rappresentano ancora oggi i momenti essenziali di un’arte raffinata e seducente” (pp. 16-17).
Proprio nell’avvocato, potremmo dire, si raggiunge la tensione massima tra le due tendenze del diritto, che ha come scopo quello di riordinare l’esperienza ordinaria tramite tecniche studiatissime e nondimeno deve permettere ai profani di affacciarsi sulla scena, di giocare un qualche ruolo, mai però senza il sostegno di chi sa dire e sa fare. Essì, perché il comportamento del profano, nel tempio del diritto, è sempre scomposto, improprio, al meglio inefficace. Infatti, il diritto, insistono Gianaria e Mittone, procede secondo un rituale disciplinato che è “immobile, ripetitivo, basato su cerimonie, atti, gesti, espressioni svolte da personaggi dotati di una speciale legittimazione” (p. 24).
Ma se tale e tanta è la fiducia che la collettività ripone nell’azione riparatrice del diritto, quali rischi si corrono quando, come accade oggi, la natura stessa del campo giuridico e la produzione delle sue figure subiscono pressioni che promettono stravolgimenti? Questa una delle linee tematiche principali di L’avvocato nel futuro, che vuole in fondo approssimare scenari per farsi trovare pronti.

Quando il mondo di ieri via via si slabbra, e le forme di comunicazione e di formazione dei modi di vita si fondono con strumenti nuovi e a proiezione globale, come i social media, il ceto degli avvocati deve rispondere a sfide che interessano tutti: la trasmissione delle competenze in un mercato della formazione professionale che si allarga e disperde, la progressiva liberalizzazione dei modi di esercizio della professione, l’iperspecializzazione dovuta alla crescente complessità della giurisdizione, la concorrenza impagliata dalla persistenza delle tariffe professionali, la trasformazione degli studi professionali in imprese di mercato, il ricorso sempre più massiccio a tecnici di altre discipline, indispensabile per padroneggiare materiali sempre più ricchi – per non parlare della crescente invadenza del digitale e dell’intelligenza artificiale nel processo, cui è dedicato un capitolo importante (pp. 79-104).
La prognosi è del massimo interesse: “La minacciosa immagine della toga sfumerà per lasciare il campo alle vesti più anonime dei negoziatori”; “debole sarà l’avvocato non specializzato, anche perché dovrà confrontarsi con un diritto sempre più sconfinato”; “dal canto suo apparirà sempre più dominante la tecnologia, agevolante o dirompente che sia, che fornirà ai professionisti strumenti nuovi producendo nuove opportunità e nuove diseguaglianze” (p. 106). Ma al di là della diagnostica e delle previsioni, Gianaria e Mittone hanno il merito di cogliere il nodo con felicità di sintesi. Senza l’uggia di chi censura il nuovo, la loro preoccupazione non è tanto segnalarci il male che viene dai prevedibili sviluppi, quanto ribadire che il diritto è una tecnica che ha le esigenze strutturali di cui sopra. La loro sintesi meditata è: “si potrà avere giustizia senza riti?”. E in questo interrogativo vibra l’istinto connaturato di chi sa che il diritto esige i suoi protocolli, i quali certo potranno cambiare nel tempo (nessuno sosterrebbe che le ritualità dello ius civile dei primordi sarebbero oggi di alcuna utilità, neppure nei pressi del Campo Boario), ma comunque devono essere parte immancabile della scena.
Questo perché – vien da dire a chi scrive, insistendo su qualcosa che non sta nel libro, ma che vi si intreccia senza difficoltà – il diritto, per poter svolgere la sua funzione di riassetto dell’esperienza ordinaria, e quindi per dispensare del vero (o quantomeno della sua ricerca indefinita), necessita di azioni canonizzate, capaci di imporsi con un inflessibile richiamo a qualcosa, se non di santo, quantomeno di sacro. Il diritto, che pur in origine si dovette separare dalla religione, di questa non importò tanto le divinità quanto l’imperativo alla credenza: il diritto deve imporre che gli si creda, che risulti indubitabile, che la sua verità provvisoria possa invalidare, come rammenta Thomas, ogni aspirazione del profano al vero naturale.
L’efficacia terapeutica del diritto sta proprio nella sua capacità di procurarsi l’obbedienza anche quando converrebbe imbracciare il fucile e ribaltare l’esito della causa con l’efficacia che può garantire solo la soppressione fisica dell’avversario. Che non si confonda, quindi, lo sfilarsi della toga o il far di maglia in aula con la democratizzazione del diritto, perché il dissiparsi del rituale, piuttosto, mette il sapere giuridico in concorrenza con altre tecniche e altri saperi che con il vero fattuale hanno assai più confidenza e prossimità.
Verrebbe da richiamare qui la valutazione un poco moralista (ma quanto vera) di Walter Siti circa quel che accade alla letteratura quando si piega alle esigenze delle nuove modalità di comunicazione, che chiamano a “uno stile che non richieda molta cultura letteraria a chi legge né sforzi di decifrazione sintattica, quindi poche allusioni o omaggi alla tradizione – semmai qualche punta espressionistica che rompa lo standard e offra, con poca spesa, il brivido di star leggendo letteratura” (Walter Siti, Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura, Rizzoli 2021, p. 40). C’è poco da fare: per ottenere una buona consulenza avvocatizia, come per leggere buona letteratura, conviene faticare e sborsare qualche soldo in più, perché quello che si chiede al diritto – come in parte alla letteratura, ma questo è altro discorso – è di produrre effetti di realtà durevoli. E per riuscire in questo occorre rivolgersi o a un fattucchiere o a un professionista addestrato secondo canoni duri, durevoli, faticosi e molto sospettosi della flessibilità che tutto piega. Il lettore si fidi, del libro e del caveat.